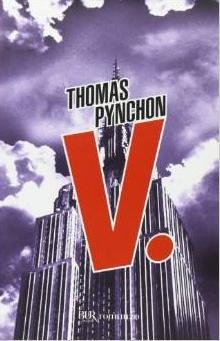ho dieci strofe per per lasciare un bel ricordo
ho dieci piani che mi aspettano giù in fondo
e sono certo in pochi possono capire
ma davvero io son felice di morire
ho fatto tutto quello che dovevo fare
ed ho sbagliato per il gusto di sbagliare
son stato sveglio quando era meglio dormire
ed ho dormito solo per ricominciare
son stato solo tutto il tempo necessario
a guardare gli altri e non per fare il solitario
ed ho creduto in tutti per quel che ho potuto
mi son rialzato sempre dopo esser caduto
ho preso in giro solo quelli più potenti
a loro ho preferito sempre i pezzenti
me ne son fregato dei giudizi della gente
nessuno giudica se è un poco intelligente
ne ho amati molti perché lo volevo fare
tanti ne ho odiati ma anche loro per amore
ho preferito Gesù Cristo a suo padre
anche se entrambi non li voglio al funerale
ho scelto tutto quello che volevo fare
ed ho pagato ben contento di pagare
perché la scelta in fondo è l'unica cosa
che rende questa vita almeno dignitosa
e quindi scelgo di saltar dal cornicione
come un gabbia- no, un falco, un piccolo aquilone
come un aereo, una falena, un pipistrello
che vola alto, invece ora io mi sfracello
ed ho scelto te per dei motivi misteriosi
siam stati accanto per giorni meravigliosi
e lo sai bene che lo faccio per natura
non rivederti più é l'unica paura
ai benpensanti che lo trovano immorale
a quelli che lo leggeranno sul giornale
alle signore bocca larga e parrucchiere
a chi non mi lascia farlo in altre maniere
io scelto esattamente tutto quel che sono
senza la scelta io la vita l'abbandono
ho scelto tutto, tutto tranne il mio dolore
lo ammazzo io e non c'è niente da capire
Performed by Appino
venerdì 29 marzo 2013
giovedì 28 marzo 2013
Ci troviamo la mattina
Ci troviamo la mattina a essere veloci più di quanto la
natura non ci abbia dotato: due parole, un movimento, due baci, un saluto. Ci vediamo,
ci sentiamo, ci baciamo, buona giornata, ciao.
mercoledì 27 marzo 2013
Skyfall
Gli ingredienti per fare bene c’erano tutti, a partire dal regista, tale Sam Mandes, fino ad arrivare a un James Bond anomalo ma ormai rodato come Daniel Craig. Se poi si aggiunge il fatto che tutti ne parlavano tanto bene, pensavo di essere davanti a un bel film, capace di farmi divertire in spensieratezza. Invece ciò che riesce a fare questo Skyfall, e lo riesce a fare davvero bene almeno nel mio caso, è far venire voglia di rivedersi il primo capitolo del reboot firmato appunto Daniel Craig. La vicenda sa di già visto, già sentito, già provato. Ed è inutile inserire un cattivo nascosto per metà film dando la parte a Javier Bardem: sembra quasi che lo si sia fatto solo per il gusto di vedergli indossare un nuovo parrucchino dopo quello ben più famoso de Non è un paese per vecchi. Il resto del cast è di alto livello, anche se relegato in parti minori, vedasi Ralph Fiennes, ma tutto quanto non riesce a elevare la pellicola a un film che potrebbe avere valore vedere. Ciò che si salva, o che per lo meno cerca di salvare del tutto la produzione, facendo passare in secondo piano le incongruenze presenti nella sceneggiatura, è il fatto di essere il primo 007 moderno a prendere in considerazione, giocandoci, il naturale passaggio del tempo, lasciandosi alle spalle e cercando di valutare il periodo in cui i film di James Bond potevano dirsi attuali, e dove lo spionaggio aveva regole ben precise. Con il passare degli anni e la trasformazione del lavoro di una spia, certi aspetti e alcuni comportamenti che si vuole vedere in un film di Bond sono andati persi. In questo Skyfall riesce ad essere al passo con i tempi e a non nascondersi dietro un dito o fare finta di nulla. Cita il passato (si veda la macchina di Bond) e sposta l’azione in un’ambientazione dove i trucchi e i metodi di una volta possano avere ancora valore. Per il resto forse è meglio il nuovo vecchio Casinò Royale, anche se non me lo ricordo bene, ma è proprio qui che Skyfall fa il suo dovere, magari involontario: invoglia a rivedere un film di 007.
martedì 26 marzo 2013
Marlene Kuntz @Officina Giovani
Quando si segue la propria strada musicale da abbastanza
anni e con abbastanza successo, si arriva inevitabilmente a un punto nel quale
ci si domanda se per caso quello che ci si appresta a fare non sia in qualche
modo ripetitivo, se non lo si sia già fatto in precedenza. Per ovviare a questa
domanda, o magari per cercare di rispondere, la tendenza è quella di allargare
la propria formazione a un numero sempre maggiore di strumentisti, andando così
ad arricchire arrangiamenti di canzoni conosciute a memoria di altri suoni e
vibrazioni: archi, spesso violini, etc. Si guardi all’esempio nostrano degli
Afterhours: nel loro ultimo concerto a cui ho assistito il palco faceva fatica
a contenere il numero di musicisti chiamati a suonare.
I Marlene Kuntz, che hanno pubblicato il loro primo album
nel 1994 ma sono in giro dal 1990, non possono chiamarsi fuori ed evitare di
dovere rispondere alla domanda di cui sopra. Per farlo però non utilizzano la
solita formula di aggiunta, ma vanno controcorrente, come spesso succede nelle
loro scelte anche musicali e di genere, e decidono di lavorare in sottrazione. Sul
palco infatti per questo concerto del loro nuovo tour “3 di 3” (con cui tra l’altro
giocano con il titolo di una loro canzone [nota per i non fan]) salgono solo
loro, ovvero i veri Marlene: Luca Bergia alla batteria, Riccardo Tesio alla
chitarra, e Cristiano Godano a chitarra e voce.
Allo stesso modo, le location individuate per questa serie
di concerti non sono enormi, grandi spazi infiniti nei quali radunare un numero
grandissimo di spettatori, ma sono abbastanza ristretti, raccolti, quel tanto
da suggerire un rapporto con il pubblico più diretto e, in un certo senso,
sincero. L’Officina Giovani, in quel di Prato, non fa eccezione, tant’è che
Godano & Co. per tutta la durata del concerto potranno guardare negli occhi
chi è venuto a vederli, distanziati da loro solo di un metro scarso, quello tra
il palco poco rialzato e le transenne del pubblico.
Proprio per la dimensione esigua del locale, decido di
presentarmi alla biglietteria con un buon anticipo. Lo spettacolo è previsto
per le 22.30 e calcolando che i tre di Cuneo non inizieranno mai a quell’ora,
vado a ritirare il biglietto, io puntuale, alle 22.30, conscio che dovrò
aspettare: non è un problema. Quando arrivo l’Officina non è ancora piena e mi
lascia l’opportunità di scegliermi il posto con cura, andando a calcolare l’impatto
sonoro e la visuale migliore. Dopo avere girovagato per un po’ trovo il mio
habitat ideale a poco meno di due metri dal palco, tra due piloni che vanno a
sorreggere il soffitto e che altrimenti avrebbero rovinato il campo visivo. La posizione
è quasi perfetta, rasenta quanto di più vicino ci possa essere a un faccia a
faccia frontale, e lo è fino a quando un muro di capelli leggermente
rettangolare non mi si piazza davanti dopo essersi ricongiunto con un amico che
a quanto pare gli teneva il posto. Il sosia in versione ingrandita di Slash dei
Guns ‘n’ Roses è un tipo alto a cui non si può immaginare una faccia, talmente
la nuca è coperta di ricci neri: quella chioma lo definisce già più di quanto
non potrebbe fare qualsiasi altro lineamento facciale, anche il più
fantascientifico. Se anche avesse una cicatrice a tagliarli in due un occhio,
lui rimarrebbe comunque il tizio con un rettangolo di capelli ricci che mi
oscura gran parte del palco.
Di spostarsi non se ne può parlare, perché ormai il concerto
dovrebbe iniziare da un momento all’altro, e in più sono bonariamente
circondato da altre persone che hanno la decenza di spirito di lasciare tra sé
e gli altri quel minimo spazio di libertà di movimento che permette a qualsiasi
individuo di compiere dei gesti ordinari quali, per esempio: grattarsi un
attimo la testa, o applaudire una canzone.
Ma al peggio non c’è mai fine, tant’è che quando la musica
registrata si zittisce di colpo, presagendo l’ingresso sul palco dei nostri,
due giovanotti tutti galvanizzati mi si piazzano davanti in quel ristretto vuoto
che c’è tra il tizio dai riccioli neri e
le mie mutande, dicendosi l’uno all’altro tutti eccitati: qui c’è posto!
Avvilisco, un po’ per il disagio arrecatomi e un po’ perché da
un certo punto di vista odio vedermi così intollerante quando sono a un
concerto: è un sintomo dell’età che avanza. Per fortuna non c’è tempo di cadere
in un baratro di tristezza senile che subito i tre di tre salgono uno alla
volta sul palco.
Il concerto inizia con una lettura di Fingendo la poesia. Lettura nel vero senso del termine, tant’è che
Godano, in giacca nera e camicia bianca, tiene davanti agli occhi un foglio in
cui è trascritto il testo della sua stessa canzone, quasi che senza la musica per
lui quelle parole fossero nuove. Le letture con solo una soffice base sonora,
che a intervalli più o meno regolari andranno a dare fiato al concerto, paiono
volere porre maggiormente l’attenzione, qualora ce ne fosse bisogno (magari per
i fan più duri e puri del rumore rumoreggiante degli esordi di gioventù quasi
sonica), sulle parole e sulla scelta importante di ogni singola di esse. Scarnificandone
via il suono, le note, e pure la
melodia, oltre ovviamente al ritmo, si scopre tutta la profondità di senso e la
ricercatezza delle canzoni, e dai testi stessi ne emerge l’intenso e curato
lavoro che sta dietro a essi.
Il gruppo è compatto e ovviamente rodato. Dopo un breve
riscaldamento con pezzi acustici, nei quali si può apprezzare la pulizia
elegante di Riccardo negli assoli, i Marlene sono pronti a sfrecciare su
carreggiate più elettriche. Il via è dato dall’inaspettata cover di Breed dei Nirvana. Appena il pubblico la
riconosce trasforma quella che fino a poco prima avevo scambiato per muta indifferenza
in esaltante fragore. Parte il pogo, e nonostante qualcuno riesca rifilarmi un
pestone sull’alluce destro già in non perfette condizioni, approfitto del
marasma generale per mettermi alle spalle il tizio dai folti capelli neri. Senza
l’ingombrante figura di questa copia annerita di Casaleggio montato a neve, il
concerto decolla alla grande acquistando una nuova fantastica dimensione:
quella visiva.
Per esempio: quando canta e suona Sapore di miele, con la camicia bianca ampiamente sbottonata sul
petto e tutta trasparente e appiccicata sulla pelle per il sudore, è
innegabile, nei suoi movimento scattosi e feroci, che Cristiano Godano si uno
degli animali più sensuali del panorama
musicale ad abbracciare una chitarra. Al tempo stesso, riacquisire il contatto
visivo mi permette di immergermi ancora di più nell’atmosfera del concerto,
cantando a squarciagola le canzoni e saltando come un indemoniato, ballando: al
diavolo il pensiero di essere vecchio, e ‘fanculo a tutti i giovanetti con cui
avevo condiviso la platea all’ultimo concerto degli Zen Circus, quegli sbarbati
che mi avevano fatto sentire così fuori luogo. Questo è il rock italiano,
quello vero, e suona nelle note essenziali di Overflash o sull’armonia più rilassata di Nuotando nell’aria.
Il rock italiano ha un nome e un cognome ben definiti. Il rock
italiano è i Marlene Kuntz più di quanto i Marlene Kuntz non facciano parte del
rock italiano. Da un certo punto di vista il gruppo di Cuneo lo detta il rock
italiano, lo forma, plasmandolo per assurdo a sua immagine e somiglianza nelle
più svariate declinazioni i tre decidano di cantarlo: con rumore e furia, o con
più armonia e ragionamento. Siano essi in forma allargata o nel nucleo
compatto, tre di tre la mischia gaia di vipere. E allora, lasciatevi mordere da
queste vipere. È sempre un piacere di veleno.
lunedì 25 marzo 2013
Il circo del diavolo
Le storie che si raccontavano da ubriachi – pirotecniche,
come veri e propri spettacoli – non obbedivano alle leggi inutili e tediose
dell’attendibilità.
Era più facile raccontare la verità se la si travestiva da finzione.
Rudy guardò Henry, i suoi occhi verdi luminosi e tristi, e
capì che non avrebbe potuto fare nulla per salvarlo. Ma anche dopo essersene
reso conto, sapeva che non avrebbe smesso di provarci, perché erano amici, e
quando si è amici il minimo che si può fare è questo: provarci.
Solo, con il resto del mondo a ricordarti chi eri, non eri
che uno dei tanti
“Le carte hanno una loro storia, lo sapevi? Non ne sono
certo, ma credo che il re rappresenti qualcuno.”
Henry non riuscì a trattenersi e disse tutto d’un fiato: “Il
re di cuori rappresenta Carlo magno, il re di quadri è Giulio Cesare, il re di
fiori è Alessandro il Grande e il re di picchè è Davide, un personaggio della
Bibbia.”
Le cose belle si trovano nelle piccole scatole.
“È così che si fa amicizia con gli animali”, disse Hannah. “Trattandoli
con amore.” Fece una pausa pensando a quanto aveva detto. “Lo stesso vale per
le persone, credo. Se sei carino con loro, loro saranno carine con te.”
La vita è triste, ma le vere tragedie colpiscono solo pochi
e perseguitano il resto di noi per sempre.
L’unica differenza tra un eroe reale e un eroe tragico è che
l’eroe tragico sopravvive alle sue perdite.
Non è il numero di perdite che conta, ma la loro gravità.
Pensai dovesse avere i suoi stessi capelli biondi e gli occhi
azzurri, la stessa luminosità, così radiosa che per dormirle accanto bisognava
girarsi di spalle.
Sarebbe bello se dentro di noi ci fosse una lampadina che si
accende automaticamente quando qualcuno si innamora di noi. Sarebbe bello se l’amore
venisse sempre corrisposto.
Le luci si accenderanno e ti ritroverai davanti al pubblico,
e ogni singola persona ti guarderà con due occhi, credimi: uno che vuole vederti
trionfare, l’altro che vuole vederti crollare e fallire. In questo mondo non
hai molte occasioni per sbagliare.
“L’amore”, ripeté Henry, facendo un passo verso Marianne,
che non sembrava neppure accorgersi della sua presenza. “Se solo sapessimo come
funziona. Perché senza dubbio è un trucco, un’illusione. Può qualcosa di così
meravigliosamente potente, misterioso e ingannevole essere anche reale?”
Il fatto era che aveva bevuto quasi troppo. Non gli capitava
mai di bere troppo, ma gli capitava spesso di bere quasi troppo, e questa era
una di quelle occasioni. Era leggermente stordito, un paio di secondi in
ritardo rispetto al mondo.
Capire cosa ci è successo è un conto; capire perché è
successo è tutta un’altra cosa.
I miei genitori erano preoccupati per me e io ero preoccupato
per loro. Capii, grazie a loro e a quasi tutti gli adulti che conoscevo, che
quando un ragazzo diventa uomo la ricerca della verità, nella maggior parte dei
casi, si concludeva.
Sono un tipo curioso, ho sempre voglia di imparare. Cerco di
capire le cose. La verità ti dà un senso di libertà. È come una cosa positiva,
anche quando quello che scopri non è bello.
Non ne ero tanto sicuro, ma se dici le cose con la giusta
convinzione la gente tende a credere a tutto. Cominci a crederci persino tu.
A volte, da qualche parte, per ragioni che non immagineresti
e crederesti mai, qualcuno è felice.
Il dolore era arrivato a un livello tale da trasformarsi
chissà come in una forma di piacere intorpidito.
Le persone vivono nel mondo come se il mondo fosse un posto
in cui vivere. Come se fosse fatto per loro. E la cosa più straordinaria fu che
Henry lo capì in quel momento – il mondo era fatto per loro.
Per lui, per tutti noi. È per questo che il mondo esiste. Buon Dio. Perché ci
aveva messo così tanto a capirlo? Che questa vita, questo mondo, era qualcosa
di cui anche lui poteva far parte?
Daniel Wallace
venerdì 22 marzo 2013
La distanza
Muovi le tue mani su di me
Il silenzio sembra indispensabile
Per controllare le parole
E dimostrare di sentirsi debole
Tu da me non hai che l'assenza
Quello che ti resta è la distanza
Tu da me non avrai che l'assenza
Muovati rapidamente
Legami
Poi controlla l'istabilità
di ogni nostro punto di contatto e spiegami
cosa vuoi da me, come devo cambiare per non farti star male
Tu da me non hai che l'assenza
Quello che ti resta è la distanza
Tu da me non avrai che l'assenza
Quello che ti resta è la distanza
La distanza
Muovi le tue mani su di me
Il silenzio sembra indispensabile
E poi finire le parole dentro ai gesti stanchi
e poi tornare ad imparare a rimanere soli
Siamo lontani
Lontani
Così quello che ti resta è la distanza
Tu da me non avrai che l'assenza
Quello che ti resta è la distanza
La distanza
E poi finire le parole
Come finire le parole
Performed by Paolo Benvegnù
Il silenzio sembra indispensabile
Per controllare le parole
E dimostrare di sentirsi debole
Tu da me non hai che l'assenza
Quello che ti resta è la distanza
Tu da me non avrai che l'assenza
Muovati rapidamente
Legami
Poi controlla l'istabilità
di ogni nostro punto di contatto e spiegami
cosa vuoi da me, come devo cambiare per non farti star male
Tu da me non hai che l'assenza
Quello che ti resta è la distanza
Tu da me non avrai che l'assenza
Quello che ti resta è la distanza
La distanza
Muovi le tue mani su di me
Il silenzio sembra indispensabile
E poi finire le parole dentro ai gesti stanchi
e poi tornare ad imparare a rimanere soli
Siamo lontani
Lontani
Così quello che ti resta è la distanza
Tu da me non avrai che l'assenza
Quello che ti resta è la distanza
La distanza
E poi finire le parole
Come finire le parole
Performed by Paolo Benvegnù
giovedì 21 marzo 2013
Quando stiamo male
Quando stiamo male stiamo male a turno, prima io e poi te, o viceversa. In questo modo ci possiamo curare a vicenda, e passarci amorevolmente la malattia. In questo modo si riparte, in ciclo continuo: prima io, poi te, poi di nuovi io, e poi di nuovo te.
mercoledì 20 marzo 2013
Noi siamo infinito
Noi siamo infinito è quel genere di film che ti piace vedere e per cui vai al cinema scartando eventualmente altre pellicole come Zero Dark Thirty, e che non appena entri in sala pensi: o cazzo! Complice il fatto di essere andato a vederlo di sabato pomeriggio l’età media degli spettatori oscillava tra i 14 ai 16 anni, mentre il numero di spettatori maschili si poteva riassumere in: due (me compreso). Il richiamo è forse dovuto all’ambientazione del film stesso, nel quale si vanno a raccontare i problemi di un giovane ragazzo che deve affrontare il trauma dei primi periodi del liceo. Sarà solo un pretesto, perché non sarà quel trauma il vero problema del protagonista, ma ben altro. I primi giorni di scuola sono solo il mezzo con cui vengono introdotti i suoi migliori amici che si applicheranno in modo inconsapevole a sorreggere il suo mondo per evitargli un crollo. E proprio i suoi amici sono in qualche modo i protagonisti del film, quasi disarcionando il povero Logan Lerman dal proprio ruolo. Da una parte c’è la neo ex Harry Potter Hermione Grenger Emma Watson, per la quale il regista Chbosky (anche autore del romanzo da cui è tratto il film) ha un occhio di riguardo nelle inquadrature e nella gestione della storia (un occhio di riguardo neppure troppo nascosto sin dalla prima apparizione del personaggio di Sam) e dall’altra il bravo Erza Miller che insieme al precedente …E ora parliamo di Kevin si presenta prepotentemente nell’ambiente indipendente.
La storia si risolverà senza troppi colpi di scena, andando a raccontare uno spaccato di vita più o meno condiviso da parte di tutti i ragazzi durante il quale ci si sente incompresi e alienati. L’amicizia, prima, e l’amore, poi, saranno capaci di formare una buona ciambella di salvataggio alla quale aggrapparsi per non affogare. Ma cosa succede quando la ciambella ti viene sottratta dalle circostanze? Questo forse è diventare grandi.
La storia si risolverà senza troppi colpi di scena, andando a raccontare uno spaccato di vita più o meno condiviso da parte di tutti i ragazzi durante il quale ci si sente incompresi e alienati. L’amicizia, prima, e l’amore, poi, saranno capaci di formare una buona ciambella di salvataggio alla quale aggrapparsi per non affogare. Ma cosa succede quando la ciambella ti viene sottratta dalle circostanze? Questo forse è diventare grandi.
martedì 19 marzo 2013
Cerco DFW in California
Da San Francisco a Los Angeles per scoprire quanto manca
David Foster Wallace. Leggere le sue opere può ispirare tanto quanto
leggere su di lui, come se alcune molecole del suo genio continuassero a
fluttuare nell’aria che respiro.
Il tempo meteorologico a San Francisco è incerto, meno clemente di quanto avevo sperato: scrosci di pioggia si alternano a schiarite della stessa brevità — soltanto il vento umido è incessante. Mi trovo costretto a indossare uno sull’altro i vestiti primaverili che avevo previsto per la vacanza, realizzando che un giaccone invernale non è equiparabile alla somma di un qualsivoglia numero di strati estivi. Per di più, la città è spopolata durante il coprifuoco postnatalizio. Percorro a piedi i saliscendi da Marina a North Beach con una sensazione di libertà che si alterna a un’altra di smarrimento: la mancanza di scopo di chi è rimasto chiuso fuori casa.
La City Lights è tra i pochi negozi aperti, il che conferma in larga parte l’impressione che si tratti ormai di un feticcio per turisti più che di una vera libreria. Ma poco importa: è straordinariamente bella, rifornita e silenziosa (come se i decametri di scaffali in legno assorbissero ogni suono), e la disposizione dei libri suggerisce la chiarezza mentale di chi l’ha concepita, senza rivelarne a fondo il piano.
David Foster Wallace mi scruta dall’alto, dalla copertina di un volume posizionato in modo che la sua facciona tenga d’occhio gli avventori. La fotografia traslucida è una delle poche in cui sorride e il libro si rivela essere una sua biografia postuma, redatta da tale D. T. Max. «Prendila, t’interessa» suggerisce la mia compagna, che deve avermi visto trasalire. «No — ribatto io —, no, no». Il punto è che mi ero prefissato esplicitamente, dopo il suicidio di DFW nel settembre del 2008, che non avrei ceduto alla tentazione di leggere alcuna sua biografia, così come non avrei considerato le pubblicazioni di lavori che lui non aveva autorizzato — avevo assistito a uno sciacallaggio simile nei confronti di Jeff Buckley finché, a forza di acquistare dischi con versioni pessime delle sue poche canzoni, mi ero quasi disamorato di lui.
Nel momento in cui mi trovo alla City Lights di San Francisco — 26 dicembre 2012 — sono già venuto meno al secondo dei miei propositi (ho letto e riletto quanto emerso dagli svariati e impietosi carotaggi dell’opera di DFW), ma il diktat sulla biografia è ancora solido. Si tratta di una questione di principio, deontologica quasi, oltre che della paura di vedermi sgretolare un idolo davanti agli occhi: il punto è che ogni narratore devolve una parte gigantesca delle proprie energie e del proprio tempo a trovare per ogni opera che produce — per ogni singola riga di ogni singola opera che produce — il giusto livello di trasposizione della sua storia personale: essere troppo avari di sé si traduce quasi sempre in freddezza, in sostanziale disinteresse verso la materia; eccedere comporta altri rischi più gravi, fra cui ossessività, autocommiserazione (quasi sempre di matrice freudiano-regressiva) e dissapori, se non proprio pasticci legali, con parenti o amici intimi. Negli ultimi anni della sua vita, poi, DFW sembrava impegnato a esplorare proprio il pernicioso confine fra privato e finzione letteraria. Nel romanzo a cui stava lavorando e che non avrebbe terminato, Il re pallido, compare fra gli altri un personaggio di nome David Wallace, con tanto di Social Security Number, l’omologo del nostro codice fiscale. È plausibile che nell’epoca d’oro delmémoire DFW volesse smontare il giocattolo dell’ultimo modello d’intrattenimento e guardarci dentro, scoprire quali insicurezze si celavano dietro tanta morbosità da parte del pubblico e una così favorevole disposizione a denudarsi da parte degli autori. Ovviamente, il mémoire che aveva a sua volta imbastito non era che la parodia di un racconto autobiografico, un resoconto che, nella pretesa esasperata di dichiararsi vero, non faceva altro che mostrare in continuazione la propria falsità strutturale. Che rispetto dimostrerei a DFW e alla sua ricerca, acquistando una biografia postuma che fa piazza pulita di tutti i filtri metanarrativi e se ne infischia del giusto- livello-di-trasposizione? Esco dalla City Lights con una copia della biografia di D. T. Max stretta fra il gomito e il fianco (titolo: Every Love Story Is a Ghost Story). Ho comprato anche una vecchia raccolta di Alice Munro, Runaway, per attenuare il senso di colpa.
A Carmel-by-the-Sea inizio la lettura. Non c’è molto altro da fare in questa cittadina benestante. La descrizione dell’albergo aveva promesso una piscina riscaldata, che si è rivelata uno stagno dal colore sospetto, e comunque piove. Dalla finestra, oltre la coltre di alberi, balugina un oceano appena più chiaro del cielo. Forse non è soltanto morbosità. Forse è più semplice e anche più limpido di così. La verità è che DFW mi manca. E mi manca con un’intensità maggiore di quella con cui mi mancano, per dire, certe persone in-carne-e-ossa scomparse in modi altrettanto improvvisi/cruenti dalla mia vita, tanto che mi trovo spesso a fantasticare su forme strane di metempsicosi, nelle quali alcune molecole aeree del suo genio e della sua umanità fluttuano attraverso l’atmosfera fino a me, che le inalo, e diventano mie — e lui diventa me. Tutto ciò suona un po’ vergognoso, ad ammetterlo. Ma la disponibilità a innamorarsi dell’irreale tanto quanto del reale mi è sempre apparsa come una premessa essenziale della narrativa. Può darsi si tratti, più precisamente, di un disturbo, una sorta di ametropia del sentimento, per la quale non si riesce a focalizzare esattamente gli oggetti nel campo dell’affetto, a collocarli in profondità secondo quello che si presume l’ordine giusto.
DFW mi manca, sì, mi manca il suo essere-nel-mondo, quindi escogito dei modi per averlo vicino, e l’ultimo che mi si è offerto è questa biografia. Come per i Grandi Amori Romantici, esiste un’età favorevole anche per i Grandi Amori Letterari, e DFW è capitato al centro della mia più fertile: avevo diciotto anni. Le passioni che si instaurano in quella fase tardoadolescenziale, quando il magma della personalità inizia a solidificare, diventano i miti fondanti del nostro carattere culturale, ci restano addosso, ostinate e prive di senso, come quelle cisti sebacee che capita facciano la loro comparsa in punti imprevisti del corpo. Di passioni-cisti io ne avevo una miriade oltre a DFW e al già citato Jeff Buckley: certe serie televisive più strappalacrime del sopportabile come The OC, Tori Amos, Chuck Palahniuk, i frozen cocktail, Kirsten Dunst, il Natale in famiglia, Bret Easton Ellis… Spinto da una voglia iconoclasta di rinnovamento, verso i ventisei anni le sottoposi tutte quante a un check-up severo, casomai nel frattempo qualcuna fosse diventata maligna o invalidante. DFW ha superato il test, Chuck Palahniuk no, ma adesso mi chiedo se dopotutto fosse così necessario e salubre tentare di sbarazzarsi di tutte quelle passioni, magari un po’ ossidate, magari ormai poco rappresentative, che quando ero ancora semiliquido mi fecero palpitare. È davvero questa la via della nostra realizzazione di adulti, toglierci dal naso tutte le lenti deformanti che da ragazzi ci facevano ingigantire o mortificare gli oggetti (sentimentali) che si offrivano alla nostra considerazione? O questa smania di aggiornare anche i nostri affetti è solo l’ennesima lente deformante che poniamo in cima alle altre?
Ecco il genere di domanda sulla quale DFW avrebbe facilmente costruito un racconto ricorsivo di venti o più pagine: la storia di un ragazzo che, nel tentativo di guardare con onestà a ciò che ne è ormai dei suoi amori del passato, fa del suo meglio per massacrarli, con il risultato di aumentarne sempre di più il valore mitico e quindi l’indistruttibilità. Ogni volta che nelle storie di DFW compare qualcosa di analogo a una minuscola cisti sebacea, puoi stare certo che quella cisti si accrescerà — proprio nel tentativo di estirparla— fino a sfigurare l’intero organismo. Tutte le serie ricorsive costruite da DFW sono altamente divergenti, la direzione è sempre quella dell’aggravarsi perpetuo cosicché, una volta avviate, possono essere interrotte solamente da un atto esterno, violento, qualcosa di simile a ciò che ci succede quando il nostro computer «va in palla» e inizia a presentare con insistenza lo stesso messaggio poco comprensibile di errore, accompagnato da quel suono che ha qualcosa di apertamente accusatorio, e noi ci rendiamo conto che non siamo in grado di fermare quanto sta succedendo, che siamo del tutto inermi e fra un attimo lo schermo potrebbe ricoprirsi di lettere e numeri o diventare inesorabilmente blu, quindi premiamo con forza il pulsante Power e se neppure quello funziona stacchiamo la spina dalla presa di corrente, percorsi — noi, non più il computer — da una scarica elettrica di terrore. La sola via d’uscita dalle ricorsività di DFW è lo spegnimento, che in certi casi estremi, come quello del manipolatore seriale protagonista del racconto Caro vecchio neon o in quello assai più realista della sua vita, coincide con la morte — con il suicidio.
A diciotto anni, il modo di procedere di DFW mi colpì come un esercizio di onestà dissacrante e perfetto, il genere di demistificazione che andavo cercando in quegli anni di solidificazione- del-magma-della-personalità. Il senso tragico che stava alla base dei suoi ragionamenti si accostava bene con quello residuale della mia adolescenza; lo sfoggio di intelligenza, poi, era proprio il traguardo che mi ponevo a quel punto. Tutto questo stabilì la nostra affinità segreta — quasi ultraterrena —, indusse la crescita della mia passione-cisti più che per qualunque altro scrittore mi fosse capitato di leggere fino a quelmomento. E, anni dopo, rese il suo suicidio doloroso quanto un tradimento personale.
Nel suo pseudo-mémoire, oltre al codice fiscale, DFW aveva riportato per intero anche il suo indirizzo. Durante un’incursione dentro una Books Inc. ho ritrovato la pagina dove è scritto e l’ho ricopiato sul retro di un ticket di parcheggio: 725 Indian Hill Bldv., Claremont. Obbligo i miei compagni di viaggio a seguirmi in quel pellegrinaggio un po’ macabro attraverso la periferia senza fine di Los Angeles. Non protestano neppure, devono ormai avere capito quanto la questione sia importante e controversa, ad altissimo rischio di scontro verbale.
Arriviamo a Claremont al crepuscolo. L’aria si è rinfrescata di colpo. Le aiuole nello spartitraffico di Indian Hill Boulevard sono tutte fiorite, incredibilmente curate. La casa al numero 725 non ha nulla in più o in meno delle altre, soltanto il portone del garage — il garage dove DFW si è ucciso — mi colpisce per la sua larghezza, ma può darsi che si tratti di una suggestione. Nel cortile c’è un albero di Natale composto di sole palline, un cono da cui fuoriesce un cavo della corrente — l’albero è spento. Sul lato opposto due limoni e unmandarino sono carichi di frutti. Il prato è stato sistemato da poco, come tutti quelli del circondario, intravedo ancora i segni paralleli del tosaerba. Avanzo di qualche passo, violando la proprietà privata e l’intimità degli sconosciuti che ora vivono qui. I miei compagni di viaggio si sono allontanati, come per rispetto. Vorrei compiere qualche gesto simbolico, magari rubare un sasso dall’acciottolato che corre lungo il marciapiede, ma sono ancora abbastanza in me per desistere. Tocco solo uno dei limoni e poi m’incammino verso la macchina. Prima di salire faccio la pipì contro un acero, di fretta: è il genere di quartiere dove temi possano arrestarti per avere urinato contro un tronco.
Il giorno seguente, dentro il parco di Joshua Tree, mi perdo di nuovo nelle fantasticherie di metempsicosi. L’atmosfera del luogo contribuisce in larga parte: un deserto roccioso dove la notte — puoi scommetterci — gli arbusti così distanziati parlano l’uno con l’altro, al riparo da sguardi umani. La natura qui sembra in uno stato di quiescenza, pronta a ritornare quella prospera che era un tempo. Inizio a pensare ai joshua tree e ai cactus e alle palme giganti come a incarnazioni di morti, la cui forma specifica dipende dalle qualità possedute in vita. L’albero che attribuisco a DFW è un’impalcatura di tronchi e rami spogli, con la corteccia elegantemente attorcigliata su se stessa, un albero che non ho mai visto dalle nostre parti, complicato eppure razionale contro il cielo azzurro. Mi faccio scattare una foto lì accanto, poi cerco di rubargli l’energia, abbracciandolo: conosco persone che con gli alberi fanno così.
Ciò che devo ammettere lungo la strada di ritorno verso Palm Springs, e con un po’ di delusione per me stesso, è che leggere DFW mi ispira almeno quanto leggere di DFW. Seguire le sue vicissitudini mi suscita la stessa irreprensibile voglia di sedermi alla scrivania e di scrivere a profusione, come avvenne dopo La scopa del sistema quando, senza premeditazione alcuna, mi avventurai nei miei primi goffi racconti. E non è soltanto questo: DFW — i suoi libri e, scopro ora, anche i libri che parlano di lui — mi spingono a scrivere come lui, con una forza di attrazione plagiatoria che nessun altro autore ha mai più esercitato su di me. Dev’essere per via di quella sua spacconeria irritante e così fascinosa, della sua smania di essere a tutti i costi più lungo, digressivo e interconnesso di quanto sia davvero necessario, della sua esigenza di attraversare sempre tutti i livelli di profondità di un fenomeno fino a sbattere il sedere contro il cemento armato dell’unica verità fondamentale sottesa a tutti: la consapevolezza, in questo mondo, di essere soli e irraggiungibili.
Sul volo San Francisco-Zurigo dove con ogni probabilità contraggo l’influenza virale con complicazioni urinarie che mi terrà a letto nei successivi quattro giorni, termino di leggere Every Love Story Is a Ghost Story. Nelle ultime pagine si avverte l’imbarazzo di D. T. Max nel fare i conti con il suicidio di DFW. Il biografo sceglie la via più sobria: poche frasi di storia medica, molto nette, che accreditano in pieno la tesi della cessazione volontaria del Nardil da parte di David dopo anni di trattamento, e del suo conseguente tracollo. Il finale lo conoscevo già, eppure ha il potere di annientarmi. Complice il jet-lag, la prima notte a casa non mi addormento fino alle cinque del mattino. Ho una sola consolazione in mezzo al fluire dei pensieri: sembra che la casa di DFW che ho visitato non fosse davvero quella dove si è tolto la vita. Dopo essere vissuti in affitto al 725 di Indian Hill Blvd., lui e la moglie ne acquistarono un’altra non troppo distante. Il portone del garage che ho visto era solo un normale portone di garage, dal quale DFW è entrato e uscito insieme ai suoi cani. Saperlo è abbastanza per farmi sentire meglio.
Paolo Giordano
Trovato qui: Archivio David Foster Wallace Italia
Il tempo meteorologico a San Francisco è incerto, meno clemente di quanto avevo sperato: scrosci di pioggia si alternano a schiarite della stessa brevità — soltanto il vento umido è incessante. Mi trovo costretto a indossare uno sull’altro i vestiti primaverili che avevo previsto per la vacanza, realizzando che un giaccone invernale non è equiparabile alla somma di un qualsivoglia numero di strati estivi. Per di più, la città è spopolata durante il coprifuoco postnatalizio. Percorro a piedi i saliscendi da Marina a North Beach con una sensazione di libertà che si alterna a un’altra di smarrimento: la mancanza di scopo di chi è rimasto chiuso fuori casa.
La City Lights è tra i pochi negozi aperti, il che conferma in larga parte l’impressione che si tratti ormai di un feticcio per turisti più che di una vera libreria. Ma poco importa: è straordinariamente bella, rifornita e silenziosa (come se i decametri di scaffali in legno assorbissero ogni suono), e la disposizione dei libri suggerisce la chiarezza mentale di chi l’ha concepita, senza rivelarne a fondo il piano.
David Foster Wallace mi scruta dall’alto, dalla copertina di un volume posizionato in modo che la sua facciona tenga d’occhio gli avventori. La fotografia traslucida è una delle poche in cui sorride e il libro si rivela essere una sua biografia postuma, redatta da tale D. T. Max. «Prendila, t’interessa» suggerisce la mia compagna, che deve avermi visto trasalire. «No — ribatto io —, no, no». Il punto è che mi ero prefissato esplicitamente, dopo il suicidio di DFW nel settembre del 2008, che non avrei ceduto alla tentazione di leggere alcuna sua biografia, così come non avrei considerato le pubblicazioni di lavori che lui non aveva autorizzato — avevo assistito a uno sciacallaggio simile nei confronti di Jeff Buckley finché, a forza di acquistare dischi con versioni pessime delle sue poche canzoni, mi ero quasi disamorato di lui.
Nel momento in cui mi trovo alla City Lights di San Francisco — 26 dicembre 2012 — sono già venuto meno al secondo dei miei propositi (ho letto e riletto quanto emerso dagli svariati e impietosi carotaggi dell’opera di DFW), ma il diktat sulla biografia è ancora solido. Si tratta di una questione di principio, deontologica quasi, oltre che della paura di vedermi sgretolare un idolo davanti agli occhi: il punto è che ogni narratore devolve una parte gigantesca delle proprie energie e del proprio tempo a trovare per ogni opera che produce — per ogni singola riga di ogni singola opera che produce — il giusto livello di trasposizione della sua storia personale: essere troppo avari di sé si traduce quasi sempre in freddezza, in sostanziale disinteresse verso la materia; eccedere comporta altri rischi più gravi, fra cui ossessività, autocommiserazione (quasi sempre di matrice freudiano-regressiva) e dissapori, se non proprio pasticci legali, con parenti o amici intimi. Negli ultimi anni della sua vita, poi, DFW sembrava impegnato a esplorare proprio il pernicioso confine fra privato e finzione letteraria. Nel romanzo a cui stava lavorando e che non avrebbe terminato, Il re pallido, compare fra gli altri un personaggio di nome David Wallace, con tanto di Social Security Number, l’omologo del nostro codice fiscale. È plausibile che nell’epoca d’oro delmémoire DFW volesse smontare il giocattolo dell’ultimo modello d’intrattenimento e guardarci dentro, scoprire quali insicurezze si celavano dietro tanta morbosità da parte del pubblico e una così favorevole disposizione a denudarsi da parte degli autori. Ovviamente, il mémoire che aveva a sua volta imbastito non era che la parodia di un racconto autobiografico, un resoconto che, nella pretesa esasperata di dichiararsi vero, non faceva altro che mostrare in continuazione la propria falsità strutturale. Che rispetto dimostrerei a DFW e alla sua ricerca, acquistando una biografia postuma che fa piazza pulita di tutti i filtri metanarrativi e se ne infischia del giusto- livello-di-trasposizione? Esco dalla City Lights con una copia della biografia di D. T. Max stretta fra il gomito e il fianco (titolo: Every Love Story Is a Ghost Story). Ho comprato anche una vecchia raccolta di Alice Munro, Runaway, per attenuare il senso di colpa.
A Carmel-by-the-Sea inizio la lettura. Non c’è molto altro da fare in questa cittadina benestante. La descrizione dell’albergo aveva promesso una piscina riscaldata, che si è rivelata uno stagno dal colore sospetto, e comunque piove. Dalla finestra, oltre la coltre di alberi, balugina un oceano appena più chiaro del cielo. Forse non è soltanto morbosità. Forse è più semplice e anche più limpido di così. La verità è che DFW mi manca. E mi manca con un’intensità maggiore di quella con cui mi mancano, per dire, certe persone in-carne-e-ossa scomparse in modi altrettanto improvvisi/cruenti dalla mia vita, tanto che mi trovo spesso a fantasticare su forme strane di metempsicosi, nelle quali alcune molecole aeree del suo genio e della sua umanità fluttuano attraverso l’atmosfera fino a me, che le inalo, e diventano mie — e lui diventa me. Tutto ciò suona un po’ vergognoso, ad ammetterlo. Ma la disponibilità a innamorarsi dell’irreale tanto quanto del reale mi è sempre apparsa come una premessa essenziale della narrativa. Può darsi si tratti, più precisamente, di un disturbo, una sorta di ametropia del sentimento, per la quale non si riesce a focalizzare esattamente gli oggetti nel campo dell’affetto, a collocarli in profondità secondo quello che si presume l’ordine giusto.
DFW mi manca, sì, mi manca il suo essere-nel-mondo, quindi escogito dei modi per averlo vicino, e l’ultimo che mi si è offerto è questa biografia. Come per i Grandi Amori Romantici, esiste un’età favorevole anche per i Grandi Amori Letterari, e DFW è capitato al centro della mia più fertile: avevo diciotto anni. Le passioni che si instaurano in quella fase tardoadolescenziale, quando il magma della personalità inizia a solidificare, diventano i miti fondanti del nostro carattere culturale, ci restano addosso, ostinate e prive di senso, come quelle cisti sebacee che capita facciano la loro comparsa in punti imprevisti del corpo. Di passioni-cisti io ne avevo una miriade oltre a DFW e al già citato Jeff Buckley: certe serie televisive più strappalacrime del sopportabile come The OC, Tori Amos, Chuck Palahniuk, i frozen cocktail, Kirsten Dunst, il Natale in famiglia, Bret Easton Ellis… Spinto da una voglia iconoclasta di rinnovamento, verso i ventisei anni le sottoposi tutte quante a un check-up severo, casomai nel frattempo qualcuna fosse diventata maligna o invalidante. DFW ha superato il test, Chuck Palahniuk no, ma adesso mi chiedo se dopotutto fosse così necessario e salubre tentare di sbarazzarsi di tutte quelle passioni, magari un po’ ossidate, magari ormai poco rappresentative, che quando ero ancora semiliquido mi fecero palpitare. È davvero questa la via della nostra realizzazione di adulti, toglierci dal naso tutte le lenti deformanti che da ragazzi ci facevano ingigantire o mortificare gli oggetti (sentimentali) che si offrivano alla nostra considerazione? O questa smania di aggiornare anche i nostri affetti è solo l’ennesima lente deformante che poniamo in cima alle altre?
Ecco il genere di domanda sulla quale DFW avrebbe facilmente costruito un racconto ricorsivo di venti o più pagine: la storia di un ragazzo che, nel tentativo di guardare con onestà a ciò che ne è ormai dei suoi amori del passato, fa del suo meglio per massacrarli, con il risultato di aumentarne sempre di più il valore mitico e quindi l’indistruttibilità. Ogni volta che nelle storie di DFW compare qualcosa di analogo a una minuscola cisti sebacea, puoi stare certo che quella cisti si accrescerà — proprio nel tentativo di estirparla— fino a sfigurare l’intero organismo. Tutte le serie ricorsive costruite da DFW sono altamente divergenti, la direzione è sempre quella dell’aggravarsi perpetuo cosicché, una volta avviate, possono essere interrotte solamente da un atto esterno, violento, qualcosa di simile a ciò che ci succede quando il nostro computer «va in palla» e inizia a presentare con insistenza lo stesso messaggio poco comprensibile di errore, accompagnato da quel suono che ha qualcosa di apertamente accusatorio, e noi ci rendiamo conto che non siamo in grado di fermare quanto sta succedendo, che siamo del tutto inermi e fra un attimo lo schermo potrebbe ricoprirsi di lettere e numeri o diventare inesorabilmente blu, quindi premiamo con forza il pulsante Power e se neppure quello funziona stacchiamo la spina dalla presa di corrente, percorsi — noi, non più il computer — da una scarica elettrica di terrore. La sola via d’uscita dalle ricorsività di DFW è lo spegnimento, che in certi casi estremi, come quello del manipolatore seriale protagonista del racconto Caro vecchio neon o in quello assai più realista della sua vita, coincide con la morte — con il suicidio.
A diciotto anni, il modo di procedere di DFW mi colpì come un esercizio di onestà dissacrante e perfetto, il genere di demistificazione che andavo cercando in quegli anni di solidificazione- del-magma-della-personalità. Il senso tragico che stava alla base dei suoi ragionamenti si accostava bene con quello residuale della mia adolescenza; lo sfoggio di intelligenza, poi, era proprio il traguardo che mi ponevo a quel punto. Tutto questo stabilì la nostra affinità segreta — quasi ultraterrena —, indusse la crescita della mia passione-cisti più che per qualunque altro scrittore mi fosse capitato di leggere fino a quelmomento. E, anni dopo, rese il suo suicidio doloroso quanto un tradimento personale.
Nel suo pseudo-mémoire, oltre al codice fiscale, DFW aveva riportato per intero anche il suo indirizzo. Durante un’incursione dentro una Books Inc. ho ritrovato la pagina dove è scritto e l’ho ricopiato sul retro di un ticket di parcheggio: 725 Indian Hill Bldv., Claremont. Obbligo i miei compagni di viaggio a seguirmi in quel pellegrinaggio un po’ macabro attraverso la periferia senza fine di Los Angeles. Non protestano neppure, devono ormai avere capito quanto la questione sia importante e controversa, ad altissimo rischio di scontro verbale.
Arriviamo a Claremont al crepuscolo. L’aria si è rinfrescata di colpo. Le aiuole nello spartitraffico di Indian Hill Boulevard sono tutte fiorite, incredibilmente curate. La casa al numero 725 non ha nulla in più o in meno delle altre, soltanto il portone del garage — il garage dove DFW si è ucciso — mi colpisce per la sua larghezza, ma può darsi che si tratti di una suggestione. Nel cortile c’è un albero di Natale composto di sole palline, un cono da cui fuoriesce un cavo della corrente — l’albero è spento. Sul lato opposto due limoni e unmandarino sono carichi di frutti. Il prato è stato sistemato da poco, come tutti quelli del circondario, intravedo ancora i segni paralleli del tosaerba. Avanzo di qualche passo, violando la proprietà privata e l’intimità degli sconosciuti che ora vivono qui. I miei compagni di viaggio si sono allontanati, come per rispetto. Vorrei compiere qualche gesto simbolico, magari rubare un sasso dall’acciottolato che corre lungo il marciapiede, ma sono ancora abbastanza in me per desistere. Tocco solo uno dei limoni e poi m’incammino verso la macchina. Prima di salire faccio la pipì contro un acero, di fretta: è il genere di quartiere dove temi possano arrestarti per avere urinato contro un tronco.
Il giorno seguente, dentro il parco di Joshua Tree, mi perdo di nuovo nelle fantasticherie di metempsicosi. L’atmosfera del luogo contribuisce in larga parte: un deserto roccioso dove la notte — puoi scommetterci — gli arbusti così distanziati parlano l’uno con l’altro, al riparo da sguardi umani. La natura qui sembra in uno stato di quiescenza, pronta a ritornare quella prospera che era un tempo. Inizio a pensare ai joshua tree e ai cactus e alle palme giganti come a incarnazioni di morti, la cui forma specifica dipende dalle qualità possedute in vita. L’albero che attribuisco a DFW è un’impalcatura di tronchi e rami spogli, con la corteccia elegantemente attorcigliata su se stessa, un albero che non ho mai visto dalle nostre parti, complicato eppure razionale contro il cielo azzurro. Mi faccio scattare una foto lì accanto, poi cerco di rubargli l’energia, abbracciandolo: conosco persone che con gli alberi fanno così.
Ciò che devo ammettere lungo la strada di ritorno verso Palm Springs, e con un po’ di delusione per me stesso, è che leggere DFW mi ispira almeno quanto leggere di DFW. Seguire le sue vicissitudini mi suscita la stessa irreprensibile voglia di sedermi alla scrivania e di scrivere a profusione, come avvenne dopo La scopa del sistema quando, senza premeditazione alcuna, mi avventurai nei miei primi goffi racconti. E non è soltanto questo: DFW — i suoi libri e, scopro ora, anche i libri che parlano di lui — mi spingono a scrivere come lui, con una forza di attrazione plagiatoria che nessun altro autore ha mai più esercitato su di me. Dev’essere per via di quella sua spacconeria irritante e così fascinosa, della sua smania di essere a tutti i costi più lungo, digressivo e interconnesso di quanto sia davvero necessario, della sua esigenza di attraversare sempre tutti i livelli di profondità di un fenomeno fino a sbattere il sedere contro il cemento armato dell’unica verità fondamentale sottesa a tutti: la consapevolezza, in questo mondo, di essere soli e irraggiungibili.
Sul volo San Francisco-Zurigo dove con ogni probabilità contraggo l’influenza virale con complicazioni urinarie che mi terrà a letto nei successivi quattro giorni, termino di leggere Every Love Story Is a Ghost Story. Nelle ultime pagine si avverte l’imbarazzo di D. T. Max nel fare i conti con il suicidio di DFW. Il biografo sceglie la via più sobria: poche frasi di storia medica, molto nette, che accreditano in pieno la tesi della cessazione volontaria del Nardil da parte di David dopo anni di trattamento, e del suo conseguente tracollo. Il finale lo conoscevo già, eppure ha il potere di annientarmi. Complice il jet-lag, la prima notte a casa non mi addormento fino alle cinque del mattino. Ho una sola consolazione in mezzo al fluire dei pensieri: sembra che la casa di DFW che ho visitato non fosse davvero quella dove si è tolto la vita. Dopo essere vissuti in affitto al 725 di Indian Hill Blvd., lui e la moglie ne acquistarono un’altra non troppo distante. Il portone del garage che ho visto era solo un normale portone di garage, dal quale DFW è entrato e uscito insieme ai suoi cani. Saperlo è abbastanza per farmi sentire meglio.
Paolo Giordano
Trovato qui: Archivio David Foster Wallace Italia
lunedì 18 marzo 2013
V.
Nel parlare di lei, però, si era scoperto una strana
tenerezza, come se si stesse rendendo conto, forse addirittura in quello stesso
momento, mentre procedeva nel suo racconto, che il sesso poteva essere ben più
misterioso del previsto, una partita di cui tutto sommato non si poteva
conoscere il punteggio, poiché non era un punteggio scritto in cifre.
Profane credeva alla metà di ciò che Paola diceva. La metà
soltanto, perché le donne sono solo la metà di una cosa che ha sempre due
aspetti.
Io sono solo un esperto in chirurgia plastica. Non sono uno
psicanalista. Forse un giorno esisterà un medico capace di fare la chirurgia
plastica anche al cervello, che riuscirà a fare di ogni ragazzino un Einstain,
di ogni bambina una Eleonora Roosvelt. O addirittura di rendere la gente meno
cattiva. Fino a quel momento, come faccio a sapere che cosa succede dentro una
persona?
La discussione era andata avanti per un po’, senza che
nessuno dei due si arrabbiasse realmente, e alle tre di notte era giunta l’inevitabile
conclusione – il letto – per cancellare con le carezze il mal di testa che era
venuto a entrambi. Niente di definitivo, niente era mai definitivo.
Stencil cominciò ad accorgersi che dormire richiedeva tempo,
un tempo che avrebbe potuto essere usato altrimenti, in modo più attivo.
In realtà, l’amore di cui Stencil era ancora capace ora si
ripiegava completamente su se stesso, verso questo suo sentirsi interiormente
vivo. Una volta scoperta questa nuova sensazione, Stencil riusciva a malapena a
lasciarla libera, tanto era preziosa. Per mantenerla in vita, doveva continuare
a inseguire V.; ma nel caso l’avesse trovata, quale poteva essere il passo
successivo, se non tornare nel suo vecchio stato di semincoscienza? Cercava
perciò di non pensare al momento in cui la sua ricerca sarebbe finita.
Avvicinarsi a lei e poi fuggire, ecco la sua tattica.
Non ti rendi conto che gli uomini rischiano di lasciarci la
pelle, per cercare di “capire” qualcuno?
Profane non ce l’aveva con lei. Cercò di comunicarglielo con
lo sguardo, ma chi poteva dire che cosa avvenisse in quegli occhi? Sembravano
assorbire tutta la luce della strada
Ogni tanto veniva preso da questo desiderio irrefrenabile di
essere crudele e allo stesso tempo di lasciarsi pervadere dal dispiacere, un
dispiacere talmente grande da uscirgli dagli occhi e dai buchi delle scarpe,
andando a raccogliersi in una grande pozza, su una strada dove si era
rovesciato di tutto, dalla birra al sangue, ma che aveva visto ben poca
compassione.
Fina aveva lo sguardo ardente. Si contorceva lenta e
sensuale nella vasca, il suo corpo fulvo fremeva tutto, pronto a risucchiarlo
come le sabbie mobili.
Fuori, il pomeriggio ripiegava su se stesso, avvolgendosi a
spirale, mosso appena da una leggera brezza.
In che razza di epoca viviamo, se un uomo diventa un nemico
solo quando ci dà la schiena?
Da tempo Stencil era ormai giunto alla conclusione che La
Situazione non aveva mai una sua realtà oggettiva: esisteva soltanto nella
mente di quelli che per caso vi si trovavano immersi, in un determinato
momento. Poiché la somma di queste diverse menti tendeva a formare un composto
più ibrido che omogeneo, La Situazione doveva necessariamente apparire al
singolo osservatore come un diagramma in quattro dimensioni, mentre il suo
occhio era abituato a vedere il mondo solo in tre dimensioni.
I diplomatici dicono sempre così. Vivono sempre sull’orlo di
un qualche baratro. Senza una crisi internazionale non sarebbero capaci di
dormire la notte.
Tu, da bambino, probabilmente avrai portato via un dono
simile da parte di tuo padre, senza renderti conto che era ancora prezioso per
lui tanto quanto lo era per te. Però quando gli inglesi parlano di “tramandare”
qualcosa di generazione in generazione, la cosa si ferma lì. Un figlio non
restituisce al padre niente di quel che ha ricevuto. Forse tutto questo è molto
triste e non è molto caritatevole, però è così da tempo immemorabile, e non
cambierà mai. L’atto di dare e di restituire può avvenire solo tra due persone
della stessa generazione.
I turisti vogliono solo carezzare la pelle di un posto, un
esploratore ne vuole conquistare il cuore. Forse è un po’ come essere
innamorati.
“Ci sono delle sere,” rifletté ad alta voce “quando sono da
solo, in cui penso che siamo come delle scimmie in un circo, delle scimmie che
imitano il comportamento degli uomini, prendendoli in giro. Forse è tutto
quanto una presa in giro, e tutto quello che possiamo dare agli uomini è una
presa in giro della libertà, della dignità. Però non può essere così.”
In quel momento, seduto su quella panchina dietro la
biblioteca, Profane era certo solo di una cosa: chiunque lavorava per
guadagnare soldi inanimati, per poi potersi comperare oggetti anch’essi
inanimati, doveva essere fuori di testa. I soldi inanimati servivano a
procurarsi calore animato: le unghie morte che affondavano nelle scapole vive,
i gemiti di piacere contro il cuscino, i capelli arruffati, le palpebre
socchiuse, le reni che si contorcevano…
Se i sogni sono solo il prodotto delle sensazioni registrate
durante la veglia, prima immagazzinate e poi rielaborate, allora un voyeur non può avere dei sogni suoi.
Be’, e l’anima che cos’è, in fondo, se non l’”idea” del
corpo, l’astrazione che si cela dietro la realtà: ciò che Esther era realmente
e che si rivelava ai sensi con certe imperfezioni, in carne e ossa.
Saprei spiegare che cos’è l’”amore”? saprei dirle che il mio
amore per lei rientra nello stesso tipo di amore che provo per gli addetti ai
Bofor, per i piloti degli Spitfire, per il nostro Governatore? Che si tratta di
un amore che abbraccia questa isola, un amore per tutto ciò che si muove su di
essa? In maltese non ci sono parole per esprimere tutto questo. Non esistono le
sfumature più sottili di significato, né le parole adatte a descrivere gli
stati d’animo. Lei non sa leggere le mie poesie, io non so tradurgliele.
Non toccarle, queste mura. Trasmettono un’esplosione a
miglia e miglia di distanza. La roccia sente tutto, e lo trasmette alle ossa, salendo
su per le dita, per il braccio e poi già attraverso la cassa toracica, le ossa
delle gambe, e poi di nuovo fuori, attraverso le ossa dei piedi. Il fatto che
questa vibrazione sia passata velocemente dentro di te è solo un caso, però è
come se fosse stato un avvertimento.
Tutto questo mentre stavano imparando l’unica lezione della
vita: che nella vita di un individuo accadono più incidenti di quanto un uomo
possa ammettere, se non vuole correre il rischio di impazzire.
Se vogliamo avere un umanesimo, dobbiamo prima essere
convinti della nostra umanità. Più ci spingiamo nella decadenza, più diventa
difficile.
È un peccato comune a chi è falsamente animato, a chi è
privo di fantasia, il non voler accettare una situazione tollerabile.
In questo silenzio non c’è tensione né inquietudine: è un
silenzio calmo, sicuro, il silenzio della noia, dei rituali ben noti.
Però in sogno ci sono due mondi: il mondo della strada e il
mondo sotto la strada. Uno è il regno della morte, l’altro è il regno della
vita. Come può un poeta vivere senza esplorare l’altro regno, sia pure solo
come una specie di turista? Un poeta si nutre di sogni. Se i convogli non
riescono a passare, di che cos’altro ci si può nutrire?
Perdere la fede è una faccenda complicata che richiede
tempo. Non ci sono “epifanie” o momenti della verità.
Viene da chiedersi se l’atteggiamento di noi adulti, reso
così disperatamente ingarbugliato dall’amore, dalle convenzioni sociali e dalla
metafisica, avrebbe funzionato meglio. Di sicuro, il modo di comportarsi dei
bambini rivelava molto più buon senso.
Il porto sfavillava al sole: salutavamo tutti quelli che
incontravamo, gli parlavamo o gli sorridevamo. I capelli di Elena catturavano i
raggi del sole nella loro rete vischiosa, le efelidi danzavano sulle sue
guance.
Triste sarebbe un aggettivo inadeguato. La luce non è
triste, o perlomeno non dovrebbe esserlo.
Le foglie degli alberi del parco hanno cominciato a sfregare
l’una contro l’altra, come le zampe delle locuste. Era accompagnamento musicale
più che sufficiente.
Dopo aver buttato fuori tutte le vecchie parole rimaste a
lungo indigeste, procedettero a riempire quella mansarda di urla inutili come
se volessero vomitare il tessuto vivo, quegli organi che non avevano il diritto
di essere da nessun’altra parte, se non dov’erano.
“È meglio non parlare di amore” disse rivolta al muro. “È
sempre pericoloso. Bisogna ingannarsi un po’ a vicenda.”
Il ritratto che dà delle sue donne è una natura morta
armoniosa e senza età, una descrizione dell’amore in uno dei suoi molti
estremi: V. sul pouf che guardava Melanie distesa sul letto; Melanie che si
guardava allo specchio; l’immagine riflessa che forse ogni tanto contemplava V.
Non c’era nessun movimento, ma solo un attrito minimo. Eppure rappresentava la
soluzione a uno dei paradossi più antichi dell’amore: una sovranità simultanea,
e allo stesso tempo una fusione.
Con sguardo triste, partecipò al suo dolore; che cos’altro
avrebbe potuto fare? Esprimere un giudizio morale? L’amore è sempre l’amore. Si
manifesta nelle dislocazioni più impensate. Quella povera donna ne era
devastata.
Supponiamo invece che il mondo, tra il 1859 e il 1919, abbia
contratto una malattia che nessuno si è premurato di diagnosticare, perché i
sintomi erano troppo vaghi, una malattia che si è mescolata ai fatti della
storia, i quali presi uno per uno non sono diversi da prima, ma tutti insieme
sono… fatali. È così che la gente considera l’ultima guerra: una malattia
nuova, rara, che adesso è stata curata e debellata per sempre.
“La vecchiaia è forse una malattia?” chiese Mehemet. “ Il
corpo rallenta, le macchine si logorano, i pianeti descrivono il loro cerchio
traballando, il sole e le stelle
bruciano piano come delle candele fumose. Perché dice che è una malattia? Solo
per ridurla a una dimensione più accettabile,
per poterla guardare, per sentirsi a suo agio?”
Mara viene sempre raffigurata alta, snella, il seno e il
ventre piccoli. Non importa quale sia la moda femminile prevalente, lei rimane
immutata. Il suo volto presenta sempre un naso leggermente arcuato, gli occhi
piccoli, distanti fra loro. Uno non si volterebbe certo a guardarla per strada.
Però, dopotutto, lei era solo maestra dell’amore. Sono gli alunni dell’amore ad
aver bisogno di essere belli.
Quando la libertà di criticare il governo viene sospesa per
quattro anni dallo stesso governo, era logico aspettarsi che il risentimento a
lungo represso sfociasse in un torrente impetuoso, anche se non per questo
necessariamente pericoloso.
Thomas Pynchon
venerdì 15 marzo 2013
Place
I see so much now
How my head spins round
Tell me just what to do
Cause I'm lost inside it all
Cause I would like to get to know you
I would like to get to know you
To know you
Cause if there is a place for me, a place for you
This is what I've found
And if there is a place for me, a place for you
This is what I've found
Try to forget how
All these things came round
Tell me just what to do
Cause I'm lost inside it all
Cause I would like to get to know you
I would like to get to know you
To know you
Cause if there is a place for me, a place for you
This is what I've found
And if there is a place for me, a place for you
This is what I've found
So hold your head high
Think about a better time
So hold your head high
Think about a better time
So hold your head high
Think about a better time
So hold your head high
Think about a better time
So hold your head high
Think about a better time
So hold your head high
Think about a better time
So hold your head high
Think about a better time
So hold your head high
Think about a better time
Hold your head high
Think about...
Cause if there is a place for me, a place for you
This is what I've found
And if there is a place for me, a place for you
This is what I've found
If there is a place for me, a place for you
If there is a place for me, a place for you
If there is a place for me, a place for you
If there is a place for me
Performed by Lucy Rose
How my head spins round
Tell me just what to do
Cause I'm lost inside it all
Cause I would like to get to know you
I would like to get to know you
To know you
Cause if there is a place for me, a place for you
This is what I've found
And if there is a place for me, a place for you
This is what I've found
Try to forget how
All these things came round
Tell me just what to do
Cause I'm lost inside it all
Cause I would like to get to know you
I would like to get to know you
To know you
Cause if there is a place for me, a place for you
This is what I've found
And if there is a place for me, a place for you
This is what I've found
So hold your head high
Think about a better time
So hold your head high
Think about a better time
So hold your head high
Think about a better time
So hold your head high
Think about a better time
So hold your head high
Think about a better time
So hold your head high
Think about a better time
So hold your head high
Think about a better time
So hold your head high
Think about a better time
Hold your head high
Think about...
Cause if there is a place for me, a place for you
This is what I've found
And if there is a place for me, a place for you
This is what I've found
If there is a place for me, a place for you
If there is a place for me, a place for you
If there is a place for me, a place for you
If there is a place for me
Performed by Lucy Rose
giovedì 14 marzo 2013
Facciamo insieme di notte le strade
Facciamo insieme di notte le strade che al mattino ci portano a lavoro. Simuliamo una compagnia futura a occhi chiusi, quasi stessimo sognando, con le palpebre ancora abbottonate dal sonno, non ancora svegli: facciamo finta di essere insieme.
mercoledì 13 marzo 2013
Candidato a sorpresa
Critica sociale sul mondo politico americano? Sarebbe stato lecito aspettarselo, visto l’argomento trattato da Candidato a sorpresa, e in effetti c’è pure un po’, soprattutto in bella vista nella primissima parte, quella che accompagna i titoli di testa. Poi il film sfugge dai binari che si potevano essere ipotizzati, deragliando completamente per seguire le capacità comiche di Will Ferrell e Zach Galifianakis.
La pellicola diventa così una divertente storia comica trasportata nel mondo delle campagne elettorali americane, quelle per così dire di provincia, non quelle enormi per le presidenziali. Ci sono gag divertenti e uscite davvero irriverenti, nelle quali i due protagonisti sguazzano felici come grossi pesci in uno stagno tutto loro: sono i re, assoluti di questa commedia, e Ferrell può definirsi anche una specie di paladino di questo tipo di film, un precursore, il capo governativo, vantando innumerevoli cloni ambientati in altri mondi attuali e passati, portati tutti all’eccesso per sottolinearne l’assurdità. Ormai questo genere di film è possibile definirlo alla Will Ferrell, e non sempre risulta essere un male. Conoscendone la natura è possibile capire ancor prima di iniziare a guardarlo se un film ti potrà piacere oppure no, se è meglio lasciar perdere o se prendersi il tempo per vederlo. Qui si ride, si scherza, si passa un’ora e mezza in perfetta beatitudine comica, se però volete vedere qualcosa di serio riguardo l’ambiente politico americano è meglio prendere Le idi di Marzo. Basta saperlo, appunto.
Cosa volete (di più)?
La pellicola diventa così una divertente storia comica trasportata nel mondo delle campagne elettorali americane, quelle per così dire di provincia, non quelle enormi per le presidenziali. Ci sono gag divertenti e uscite davvero irriverenti, nelle quali i due protagonisti sguazzano felici come grossi pesci in uno stagno tutto loro: sono i re, assoluti di questa commedia, e Ferrell può definirsi anche una specie di paladino di questo tipo di film, un precursore, il capo governativo, vantando innumerevoli cloni ambientati in altri mondi attuali e passati, portati tutti all’eccesso per sottolinearne l’assurdità. Ormai questo genere di film è possibile definirlo alla Will Ferrell, e non sempre risulta essere un male. Conoscendone la natura è possibile capire ancor prima di iniziare a guardarlo se un film ti potrà piacere oppure no, se è meglio lasciar perdere o se prendersi il tempo per vederlo. Qui si ride, si scherza, si passa un’ora e mezza in perfetta beatitudine comica, se però volete vedere qualcosa di serio riguardo l’ambiente politico americano è meglio prendere Le idi di Marzo. Basta saperlo, appunto.
Cosa volete (di più)?
martedì 12 marzo 2013
Cervello
Ci sono tanti pensieri in testa. Se si taglia la calotta cranica, in modo orizzontale, all’altezza delle tempie, si può guardare dentro e vedere flussi di pensieri in costante movimento. Aprendo la testa come una scatola, riponendo il coperchio poi sul tavolo o su un mobile, il cervello apparirebbe così pulsante, quasi a voler simulare il battito del cuore. Una specie di gelosia tra organi: il cervello vuole sentimenti, il cuore vuole pensare.
I pensieri, le idee, i ragionamenti, si muovono in un ambiente ristretto e spingono contro le pareti per cercare più spazio, nel quale muoversi ancora e di più. Le emicranie sono punture fatte dall’interno con gomiti sporgenti che tentano di spostarsi da un punto all’altro senza creare confusione, o urtare qualcuno, senza riuscirci. I mal di testa sono pressioni costanti di una stanza troppo piena e troppo affollata, dove tutti vogliono entrare per avere a disposizione quel minimo di tempo utile per divertirsi, o anche solo vivere.
Poi ci sono i momenti di silenzio totale e innaturale immobilismo di chiunque, dentro e fuori. Allora ci si trova davanti con un cervello che è pieno e vuoto allo stesso tempo, dove tutti si sono presi una pausa e puoi vedere miliardi di pensieri fermi come non dovrebbero essere mai. Sono gli attimi durante il quale il cervello smette di volere imitare il cuore e si placa nei movimenti. L’unico modo che ha per farlo e cessare di pensare, mantenere la costante attività basilare, quella che permette ai polmoni di respirare, alle palpebre di sbattere: azioni di routine da eseguire senza neppure rendersene conto.
Mentre il cervello è in pausa, e i pensieri sono fermi, tutte quanti in attesa di un qualcosa che dovrebbe accadere ma che nessuno sa chi potrebbe farlo accadere, tu sei in piedi, davanti a una testa aperta di un individuo che non conosci e che, al momento, non parla. La stanza è illuminata solo da un ovale bianco che pare provenire proprio dal cranio aperto, quasi le idee fossero davvero delle lampadine che si illuminano quando prendono vita.
E allora capisci, per assurdo, seguendo tu un ragionamento tanto contorto quanto improbabile. Se il cervello è fermo, e le idee sono ritte in piedi ad aspettare un segnale, ognuna con in mano un bicchiere di birra o un cocktail da sorseggiare tra un discorso e un altro, come mai sono ancora tutte quante illuminate e forniscono la luce, non solo al loro padrone ma anche a te?
Pur senza muoversi il cervello pensa, e le idee sono ferme, ti guardano, come in attesa di una rivelazione; ma sono loro ad avere capito ancora prima di te: non c’è modo di fermarsi, e anche quando credi di essere perfettamente immobile, dentro di te si muove tutto.
I pensieri, le idee, i ragionamenti, si muovono in un ambiente ristretto e spingono contro le pareti per cercare più spazio, nel quale muoversi ancora e di più. Le emicranie sono punture fatte dall’interno con gomiti sporgenti che tentano di spostarsi da un punto all’altro senza creare confusione, o urtare qualcuno, senza riuscirci. I mal di testa sono pressioni costanti di una stanza troppo piena e troppo affollata, dove tutti vogliono entrare per avere a disposizione quel minimo di tempo utile per divertirsi, o anche solo vivere.
Poi ci sono i momenti di silenzio totale e innaturale immobilismo di chiunque, dentro e fuori. Allora ci si trova davanti con un cervello che è pieno e vuoto allo stesso tempo, dove tutti si sono presi una pausa e puoi vedere miliardi di pensieri fermi come non dovrebbero essere mai. Sono gli attimi durante il quale il cervello smette di volere imitare il cuore e si placa nei movimenti. L’unico modo che ha per farlo e cessare di pensare, mantenere la costante attività basilare, quella che permette ai polmoni di respirare, alle palpebre di sbattere: azioni di routine da eseguire senza neppure rendersene conto.
Mentre il cervello è in pausa, e i pensieri sono fermi, tutte quanti in attesa di un qualcosa che dovrebbe accadere ma che nessuno sa chi potrebbe farlo accadere, tu sei in piedi, davanti a una testa aperta di un individuo che non conosci e che, al momento, non parla. La stanza è illuminata solo da un ovale bianco che pare provenire proprio dal cranio aperto, quasi le idee fossero davvero delle lampadine che si illuminano quando prendono vita.
E allora capisci, per assurdo, seguendo tu un ragionamento tanto contorto quanto improbabile. Se il cervello è fermo, e le idee sono ritte in piedi ad aspettare un segnale, ognuna con in mano un bicchiere di birra o un cocktail da sorseggiare tra un discorso e un altro, come mai sono ancora tutte quante illuminate e forniscono la luce, non solo al loro padrone ma anche a te?
Pur senza muoversi il cervello pensa, e le idee sono ferme, ti guardano, come in attesa di una rivelazione; ma sono loro ad avere capito ancora prima di te: non c’è modo di fermarsi, e anche quando credi di essere perfettamente immobile, dentro di te si muove tutto.
lunedì 11 marzo 2013
E come sempre mi spiego male e non è facile capire cosa voglio dire
Sto leggendo V. di Thomas Pynchon. Non è il suo primo libro che leggo, sapevo a cosa andavo incontro quando l’ho iniziato. Pynchon è così: non proprio facile, a volte ostico, a tratti straniante, spesso ubriacante con nomi e situazioni inverosimili. Ma non è la difficoltà della prosa, né tantomeno la complessità della struttura narrativa, della storia, l’intreccio, o anche solo le singole parole scelte e usate, che mi fissano qui su questa pagina ora. Sono arrivato a pensare, con l’aiuto di qualcuno (è ovvio) (grazie a una cena, meno ovvio, ma più vero) quanto sia difficile non tanto Pynchon o qualsiasi altro autore, grande o piccolo. Mi sono soffermato sull’importanza piccola, a tratti microscopica, delle parole, di quelle anche più semplici, tipo: questo, o anche: tipo, o: anche. O: o. Tutte le parole, dalla prima all’ultima, da quella più impossibile a quella più impensabile. E allo stesso tempo, mentre pensavo a questo (proprio questo), pensavo anche a quanto fossero, tutte insieme o prese singolarmente, di una difficoltà quasi incalcolabile. Non nel dirle, a parlare, quanto piuttosto da capire nel leggerle.
E anche se qui ora mi sto spiegando male, e le parole sembrano rigirarsi tutte quante contro, attorcigliandosi le une sulle altre in un groviglio indistricabile di lettere dove non si riesce a capire dove inizi una frase e dove invece ne finisca un’altra (quasi a volere sottolineare loro stesse, le parole, la loro forza e la loro difficoltà), voglio dire, qui, le stesse parole usate magari in un discorso diretto, a voce, tra due persone, sono assai più difficili da capire, qui, in questa pagina scritta. I segni usati per definirle, i disegni che compongono in grafia la scrittura.
Leggere è un’attività talmente naturale, ora. Tendo a dimenticarne l’importanza. Come respirare. È diventato talmente automatico da non rendersene neppure conto. Apro un libro, apro V., leggo Pynchon, e nel frattempo respiro, tra una parole e un’altra. Inspiro, espiro. Leggo: “Meditava con aria impenetrabile lungo le rive di quel placido fiume del pessimismo italiano, dove tutti gli uomini erano corrotti: la storia avrebbe continuato a svilupparsi secondo una ricapitolazione degli stessi schemi.” (non è molto di buon auspicio). Se mi devo fermare per grattare un poco la testa (forse devo fare spazio dentro, dentro la testa, per le parole e le idee che sto leggendo), o togliere un ciuffo di capelli dagli occhi, spostarli dietro le orecchie, tutto questo ha bisogno di più attenzione nei movimenti di quanto invece non ne abbia bisogno leggere. Se devo spostare la mano, portarla alla nuca, grattarmi, etc, devo mettermi a pensare di farlo, di spostare la mano, di portarla alla nuca, di grattarmi; mentre se leggo, leggo e basta: le parole mi entrano in testa passando dagli occhi come se non fossi io a leggerle, a fare un’operazione attiva, quanto piuttosto fossero loro a venirmi dentro passando sempre dagli occhi, in un’operazione nella quale io sono semplicemente passivo. Le accolgo e le capisco, ma non faccio niente per prenderle. Almeno non me ne rendo conto. Invece sposto di poco un poco gli occhi, li faccio scorrere sull’inchiostro, e traduco ciò che vedo in parole effettive che capisco: trasformo i disegni della scrittura in significato.
Tutto questo in un processo automatico, tanto automatico che adesso, proprio ora, mi domando: come ho fatto a impararlo? È una cosa incredibile di cui in effetti non mi ricordo assolutamente, perché ho una vaga memoria di quando non sapevo leggere, quando i libri erano solo un mucchio di pagine con degli scarabocchi sopra; e ho memoria di quando invece sapevo leggere (quando mi sono intestardito a leggere i tre moschettieri o la storia infinita) ma non ho memoria di quando questi due momenti si sono accavallati, quel confine nel quale stato imparando a leggere: ancora non sapevo del tutto, ma qualcosa sapevo. E in questo non posso fare nessun confronto con il respirare, perché non ho proprio mai nessun ricordo di quando ancora non respiravo. Questo perché respirare è naturale, è in qualche modo implicito nell’essere.
Sono arrivato a un punto in cui anche leggere è diventato implicito, e se voglio ricordarmi di quando non leggevo (non per le possibilità di tempo o di voglia, quanto piuttosto proprio di impossibilità intesa come incapacità) devo fare uno sforzo nel guardarmi indietro, e anche facendolo non ho che un ricordo sfocato, del tipo: non ho la visione precisa di un giorno in cui magari non ho mai letto perché non sapevo, ho visioni di giorni in cui non leggevo perché troppo piccolo per interessarmi alla lettura, giorni durante i quali non facevo che giocare e giocare e giocare ancora: giorni troppo corti per contenere tutta quanta la mia esuberanza nel correre e nello scoprire cose nuove.
Se dovessi imparare ora a leggere, da dove inizierei? Se per caso dimenticassi tutto a un tratto come si fa, riuscirei a reimparare a farlo? O se dovessi insegnarlo io a qualcun altro: riuscirei a insegnarlo come è stato insegnato a me?
L’insegnamento della lettura, del leggere e non di cosa leggere o dello scegliere cosa leggere, è questo il difficile, più del leggere in sé. Nel farlo apri un mondo e ne apri mille allo stesso tempo. Se leggere ora per me è così facile è perché tutte le difficoltà si sono rifugiate dentro quella difficoltà, la difficoltà dell’insegnarmelo, talmente profonda, questa difficoltà, che io non riesco a vederne la fine (è per questo che io non riuscirei a farlo, a insegnare a leggere). È a chi ha tutta questa capacità, e soprattutto in modo molto egoistico a chi ha avuto tutta questa capacità nell’insegnarlo a me, che va tutta la mia gratitudine.
Grazie.
Grazie mille.
Davvero.
E anche se qui ora mi sto spiegando male, e le parole sembrano rigirarsi tutte quante contro, attorcigliandosi le une sulle altre in un groviglio indistricabile di lettere dove non si riesce a capire dove inizi una frase e dove invece ne finisca un’altra (quasi a volere sottolineare loro stesse, le parole, la loro forza e la loro difficoltà), voglio dire, qui, le stesse parole usate magari in un discorso diretto, a voce, tra due persone, sono assai più difficili da capire, qui, in questa pagina scritta. I segni usati per definirle, i disegni che compongono in grafia la scrittura.
Leggere è un’attività talmente naturale, ora. Tendo a dimenticarne l’importanza. Come respirare. È diventato talmente automatico da non rendersene neppure conto. Apro un libro, apro V., leggo Pynchon, e nel frattempo respiro, tra una parole e un’altra. Inspiro, espiro. Leggo: “Meditava con aria impenetrabile lungo le rive di quel placido fiume del pessimismo italiano, dove tutti gli uomini erano corrotti: la storia avrebbe continuato a svilupparsi secondo una ricapitolazione degli stessi schemi.” (non è molto di buon auspicio). Se mi devo fermare per grattare un poco la testa (forse devo fare spazio dentro, dentro la testa, per le parole e le idee che sto leggendo), o togliere un ciuffo di capelli dagli occhi, spostarli dietro le orecchie, tutto questo ha bisogno di più attenzione nei movimenti di quanto invece non ne abbia bisogno leggere. Se devo spostare la mano, portarla alla nuca, grattarmi, etc, devo mettermi a pensare di farlo, di spostare la mano, di portarla alla nuca, di grattarmi; mentre se leggo, leggo e basta: le parole mi entrano in testa passando dagli occhi come se non fossi io a leggerle, a fare un’operazione attiva, quanto piuttosto fossero loro a venirmi dentro passando sempre dagli occhi, in un’operazione nella quale io sono semplicemente passivo. Le accolgo e le capisco, ma non faccio niente per prenderle. Almeno non me ne rendo conto. Invece sposto di poco un poco gli occhi, li faccio scorrere sull’inchiostro, e traduco ciò che vedo in parole effettive che capisco: trasformo i disegni della scrittura in significato.
Tutto questo in un processo automatico, tanto automatico che adesso, proprio ora, mi domando: come ho fatto a impararlo? È una cosa incredibile di cui in effetti non mi ricordo assolutamente, perché ho una vaga memoria di quando non sapevo leggere, quando i libri erano solo un mucchio di pagine con degli scarabocchi sopra; e ho memoria di quando invece sapevo leggere (quando mi sono intestardito a leggere i tre moschettieri o la storia infinita) ma non ho memoria di quando questi due momenti si sono accavallati, quel confine nel quale stato imparando a leggere: ancora non sapevo del tutto, ma qualcosa sapevo. E in questo non posso fare nessun confronto con il respirare, perché non ho proprio mai nessun ricordo di quando ancora non respiravo. Questo perché respirare è naturale, è in qualche modo implicito nell’essere.
Sono arrivato a un punto in cui anche leggere è diventato implicito, e se voglio ricordarmi di quando non leggevo (non per le possibilità di tempo o di voglia, quanto piuttosto proprio di impossibilità intesa come incapacità) devo fare uno sforzo nel guardarmi indietro, e anche facendolo non ho che un ricordo sfocato, del tipo: non ho la visione precisa di un giorno in cui magari non ho mai letto perché non sapevo, ho visioni di giorni in cui non leggevo perché troppo piccolo per interessarmi alla lettura, giorni durante i quali non facevo che giocare e giocare e giocare ancora: giorni troppo corti per contenere tutta quanta la mia esuberanza nel correre e nello scoprire cose nuove.
Se dovessi imparare ora a leggere, da dove inizierei? Se per caso dimenticassi tutto a un tratto come si fa, riuscirei a reimparare a farlo? O se dovessi insegnarlo io a qualcun altro: riuscirei a insegnarlo come è stato insegnato a me?
L’insegnamento della lettura, del leggere e non di cosa leggere o dello scegliere cosa leggere, è questo il difficile, più del leggere in sé. Nel farlo apri un mondo e ne apri mille allo stesso tempo. Se leggere ora per me è così facile è perché tutte le difficoltà si sono rifugiate dentro quella difficoltà, la difficoltà dell’insegnarmelo, talmente profonda, questa difficoltà, che io non riesco a vederne la fine (è per questo che io non riuscirei a farlo, a insegnare a leggere). È a chi ha tutta questa capacità, e soprattutto in modo molto egoistico a chi ha avuto tutta questa capacità nell’insegnarlo a me, che va tutta la mia gratitudine.
Grazie.
Grazie mille.
Davvero.
Iscriviti a:
Post (Atom)