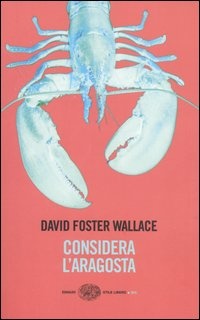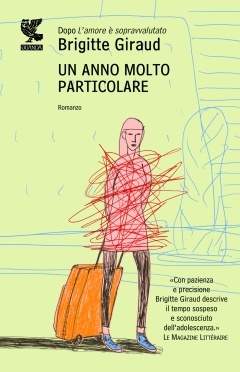Sdraiato sulla riva del fiume teneva le mani intrecciate dietro la testa, le gambe distese con i piedi a puntare verso il corso d'acqua, e un sorriso appena accennato sulla superficie delle labbra. Gli occhi chiusi. Sotto le palpebre non si vedevano i movimenti isterici della fase rem. Non stava sognando. Non stava dormendo. Con l'immaginazione disegnava la posizione delle foglie, appese ai rami degli alberi piantati poco lontano da dove si trovava lui. Si divertiva a posizionarle una a una, con casualità, distratte, appoggiate come con un dito al legno, mentre spostate dal vento producevano un suono leggero, ognuna un piccolo fruscio.
Il colore era verde. Un verde reale, fatto di infinite sfumature impercettibili, con la luce pronta a riflettersi sulla superficie trasfondo la tonalità da spenta ad accesa, rendere l'intera foglia quasi trasparente, oppure farla piombare nell'ombra non appena il sole scompariva dietro una nuvola. La sintesi clorofilliana si attivava e disattivava facendo percorrere la linfa dentro quelle leggere venature in rilievo. Il sangue delle piante, pompava silenzioso con un fluire denso. Non lo avrebbe detto uno scorrere, bensì uno spingere appiccicoso, una calca che si muoveva tutt'una, non separata.
Immaginava questo, mentre il giorno si distendeva sopra di lui, appoggiandosi al suo petto come poteva capitare solo durante le domeniche pomeriggio. Aveva quasi paura di aprire gli occhi, scoprendo in questo modo magari un mondo diverso da quello costruito dentro la sua testa. Si accorse, corrugando un poco la fronte, di quanto potesse essere frustante il vivere distaccato, non tenere legami abbastanza stretti da poterlo definire legato al mondo esterno. Esisteva un mondo, era vero, ma non superava la sua pelle, il suo corpo ne rappresentava l'atmosfera. Frustante era il doversi continuamente palleggiare tra un mondo e l'altro, tra la verità fuori e la verità dentro. Il passare dall'uno all'altro lo avrebbe infine eroso, lo sapeva, perché di solito le persone non sono fatte per essere divise così in due. Le persone sono fatte per restare in un mondo solo, hanno apparati progettati per permettergli di sopravvivere in quel determinato mondo.
I polmoni, per esempio, permettono agli uomini e alle donne di respirare. Sono un sistema piuttosto meccanico, capace di attrarre al loro interno l'aria quando si allargano, facendoli ampliare dentro la cassa toracica. Inspiri e accogli l'aria dentro di te, espiri e cacci via l'anidride carbonica. Questo accadeva nel mondo che stava fuori la sua pelle, un mondo talmente complicato che alla fine si trovava a insinuarsi anche dentro la sua pelle, infatti i polmoni erano degli organi che lui aveva dentro, erano suoi, non erano qualcosa a lui esterno. Eppure facevano parte del mondo di tutti, non erano un tassello del suo mondo personale, quello costruito dentro la sua testa.
Nel suo mondo i polmoni non avevano una vera e propria funzione. C'erano, mantenevano la loro posizione proprio dentro al petto, come gli stessi polmoni del mondo di tutti, ma non si allargavano né si restringevano. Nel suo mondo personale non c'era bisogno di respirare, si poteva vivere trattenendo il fiato per tutto il tempo che si desiderava. Era un'apnea continua, ma senza la sofferenza di quella costante fine che ti attanagliava la gola nel mondo vero, quello di tutti. Era una sensazione del tutto nuova, perché dell'aria nel suo mondo lui non ne aveva bisogno, non era indispensabile.
Respirare è una di quelle azioni di cui, con il passare del tempo, non ti rendi più conto. È un'altra cosa rispetto per esempio al camminare: decidi di spostarti, di andare da un luogo all'altro, e allora inizia a camminare. Te ne accorgi subito. Respirare ti viene invece naturale, te ne accorgi solo quando non lo fai. È un accorgersene al contrario, in negativo. Ti accorgi della mancanza, non della presenza.
In quel momento aprì gli occhi e un pezzo del suo mondo vibrò forte dentro di sé, fino a scostarsi dalle pareti interne della sua pelle, giusto all'altezza dell'inizio dello stomaco.
martedì 31 maggio 2011
venerdì 27 maggio 2011
40 Days
Lost in the equinox lightening flash in a blood red sky
Another game of paradox got the angels choosing sides
Last word of a pistol poem
A faded note on a torn back page
And from the mountain rolls the thunder who has escaped its gilded cage
So be safely on your way and heed the words I say
40 days, boys
40 days
You'll have to leave what you can't carry
40 days, boys
40 days
And I hope that you are ready, well are you ready?
Your words are sad with wisdom and as you speak they float away
In to some mystic vision that holds back this heavy rain
You who have never swam the river
You who have never much as cared
You who now seeks solace will find no comfort here
Fear is never kind
As it creeps into your mind
40 days, boys
40 days
You'll have to leave what you can't carry
40 days, boys
40 days
Well I hope that you are ready
Said, are you ready?
How long must I wait?
How long must I wait?
For the river to run dry, for you to look me in the eye.
How long must I wait?
The savage hooks of midnight, have pierced your milk white skin,
tattooed in gold dust splendor
A jeweled thrown you ascend
So be safely on your way and heed the words I say
Another game of paradox got the angels choosing sides
Last word of a pistol poem
A faded note on a torn back page
And from the mountain rolls the thunder who has escaped its gilded cage
So be safely on your way and heed the words I say
40 days, boys
40 days
You'll have to leave what you can't carry
40 days, boys
40 days
And I hope that you are ready, well are you ready?
Your words are sad with wisdom and as you speak they float away
In to some mystic vision that holds back this heavy rain
You who have never swam the river
You who have never much as cared
You who now seeks solace will find no comfort here
Fear is never kind
As it creeps into your mind
40 days, boys
40 days
You'll have to leave what you can't carry
40 days, boys
40 days
Well I hope that you are ready
Said, are you ready?
How long must I wait?
How long must I wait?
For the river to run dry, for you to look me in the eye.
How long must I wait?
The savage hooks of midnight, have pierced your milk white skin,
tattooed in gold dust splendor
A jeweled thrown you ascend
So be safely on your way and heed the words I say
Performed by Chris Robinson and the new earth mod band
lunedì 23 maggio 2011
Un motivo
Se mi stai leggendo, ora, immagino tu abbia un motivo, se non buono almeno accettabile. Voglio dire: potresti fare altro, tipo uscire per una passeggiata, dedicarti alla tua collezione di farfalle o francobolli, oppure prepararti un panino alla maionese ed elio. Invece ti sei messo comodo, cercando di liberare la mente da tutte le preoccupazioni della giornata, e hai iniziato a leggermi. Questo significherà pure qualcosa? Io per esempio quando leggevo lo facevo per cercare di imparare. Aprivo i libri e mi immergevo nelle loro pagine, seguendo il ritmo delle parole, osservando con attenzione i personaggi della storia, stando attento a ciò che facevano e a ciò che non facevano, quali termini usavano, come si interfacciavano con gli altri personaggi. Per me un romanzo è sempre stato una finestra sul mondo sociale, dal quale attingere esperienze laddove tali esperienze io non le potevo o non le volevo vivere. Non mi sono mai drogato, eppure ho letto racconti su racconti di Burroughs e ti posso assicurare che la sua scrittura sia molto molto allucinogena. Non sono mai andato in America, ma insieme a Kerouac ho viaggiato in lungo e in largo per le strade tra New York e San Francisco. Attraverso i libri facevo tutto quello che i miei genitori o la società mi proibivano di fare, o che io non potevo materialmente fare. Per esempio: a me è sempre piaciuto, come immagino pure a te, quel pezzo de Il Giovane Holden nel quale il protagonista si siede a una panchina del parco a osservare il lago e si domanda dove vadano le anitre - nella mia edizione hanno tradotto proprio così: anitre - quando il lago ghiaccia. È un'immagine forte e dolce allo stesso tempo, di lui circondato dai suoi problemi capace però di estraniarsi per un momento e a concentrarsi su un problema per lui più piccolo ma per le anitre assai più grande di tutti i suoi messi insieme. Anche io avevo i miei problemi, come tutti in fondo, e pure io desideravo un momento come quello di Holden, durante il quale lavarmi via di dosso tutte le preoccupazioni e assaporare un po' di tranquillità. Ma il lago nel parco della città dove abitavo, pur avendo le anitre, non ghiacciava mai, neppure durante gli inverni più freddi, perciò cosa avrei dovuto fare? Mi sarei dovuto arrendere? No, ho letto il libro di Salinger e con quello ho avuto pure io il mio momento alla Holden Caulfield.
In modo analogo cercavo di assorbire tutto quello che l'autore di un libro riusciva a passarmi. Non parlo soltanto di una dettagliata descrizione, o di un paragrafo ben riuscito, quanto piuttosto del sapere o dell'intelligenza dell'autore stesso, del significato della storia che stava raccontando. In più guardavo ai protagonisti come a dei modelli che mi potessero insegnare come relazionarsi alle altre persone. Insomma, un libro per me era un vero pozzo dal quale potevo tirare su qualsiasi cosa.
So che è un po' difficile da capire, e io mi sono spiegato male, ma devo andare a memoria, senza la possibilità di attingere a ricordi vicini, quanto piuttosto scavare in abitudini ormai passate, tentando di rammentare cosa provassi e cosa cercassi veramente. Più passano gli anni e più difficile è ricordare. Ora non mi lasciano leggere. Dicono mi distragga troppo, sia pericoloso, perché, cito testualmente, sarebbe come cercare di spegnere un incendio buttandoci badilate di benzina. A volte qui riescono anche a essere simpatici.
Tutto questo comunque per dirti che se stai cercando di imparare qualcosa, come facevo io, o come mi sembra di ricordare facessi, hai sbagliato completamente. Qui non troverai niente di talmente illuminante da farti scattare il genio, o capace di farti comprendere chissà quale aspetto della vita, l'universo e tutto quanto. Io non sono il Buddha in cima alla montagna pronto a offrirti il sapere. Qui non c'è niente da imparare, primo perché ciò che ho fatto non andrebbe mai ripetuto, così dicono; secondo perché quel che ho fatto non è poi tanto difficile da necessitare un corso approfondito su come farlo. Basta aprire, infilare, accendere, e aspettare. Qui troverai il motivo per cui l'ho fatto, cosa che vado ormai ripetendo a intervalli più o meno regolari da circa cinque anni, anche se qua nessuno sembra capirmi. Quanto possa essere interessante dibattere su questo motivo, chiunque potrebbe avanzare seri dubbi, in fondo nessuno cerca di capire la ragione per cui una persona magari si pulisce il culo tre volte con la carta igienica dopo avere cagato, o su come mai a qualcuno piaccia più il gelato alla crema anziché quello alla cioccolata; ma visto che in tutta questa storia in qualche modo c'entri pure te, non credo sarai proprio tu a schierarti tra i primi detrattori. Anzi, forse è proprio questo il motivo principale per cui ti sei messo a leggere.
In modo analogo cercavo di assorbire tutto quello che l'autore di un libro riusciva a passarmi. Non parlo soltanto di una dettagliata descrizione, o di un paragrafo ben riuscito, quanto piuttosto del sapere o dell'intelligenza dell'autore stesso, del significato della storia che stava raccontando. In più guardavo ai protagonisti come a dei modelli che mi potessero insegnare come relazionarsi alle altre persone. Insomma, un libro per me era un vero pozzo dal quale potevo tirare su qualsiasi cosa.
So che è un po' difficile da capire, e io mi sono spiegato male, ma devo andare a memoria, senza la possibilità di attingere a ricordi vicini, quanto piuttosto scavare in abitudini ormai passate, tentando di rammentare cosa provassi e cosa cercassi veramente. Più passano gli anni e più difficile è ricordare. Ora non mi lasciano leggere. Dicono mi distragga troppo, sia pericoloso, perché, cito testualmente, sarebbe come cercare di spegnere un incendio buttandoci badilate di benzina. A volte qui riescono anche a essere simpatici.
Tutto questo comunque per dirti che se stai cercando di imparare qualcosa, come facevo io, o come mi sembra di ricordare facessi, hai sbagliato completamente. Qui non troverai niente di talmente illuminante da farti scattare il genio, o capace di farti comprendere chissà quale aspetto della vita, l'universo e tutto quanto. Io non sono il Buddha in cima alla montagna pronto a offrirti il sapere. Qui non c'è niente da imparare, primo perché ciò che ho fatto non andrebbe mai ripetuto, così dicono; secondo perché quel che ho fatto non è poi tanto difficile da necessitare un corso approfondito su come farlo. Basta aprire, infilare, accendere, e aspettare. Qui troverai il motivo per cui l'ho fatto, cosa che vado ormai ripetendo a intervalli più o meno regolari da circa cinque anni, anche se qua nessuno sembra capirmi. Quanto possa essere interessante dibattere su questo motivo, chiunque potrebbe avanzare seri dubbi, in fondo nessuno cerca di capire la ragione per cui una persona magari si pulisce il culo tre volte con la carta igienica dopo avere cagato, o su come mai a qualcuno piaccia più il gelato alla crema anziché quello alla cioccolata; ma visto che in tutta questa storia in qualche modo c'entri pure te, non credo sarai proprio tu a schierarti tra i primi detrattori. Anzi, forse è proprio questo il motivo principale per cui ti sei messo a leggere.
venerdì 20 maggio 2011
Sudoku
è troppo facile fare il sudoku
troppo difficile morire in galleria
è troppo scomodo un cadavere di drago
è troppo bello vederti andare via
dalle mie canzoni senza nostalgia
ho finito il sudoku lei conta i soldi
si toglie l'orologio s'increma le mani fin sui polsi
ha una collana di perle finte una parrucca
è impeccabile lo smalto rosa sulle dita dei piedi
non è granchè di viso
ma ha un corpo da duecentometrista
la considero una mignotta
perchè ha trecento euro nella borsetta
ma d'altronde ho fatto il sudoku semplice
adesso passo al medio
ma che lunga questa galleria
entra un drago con uno spiedo senza radio
un buietto senza la mitologia
fatti scopare puttana
trenta son troppi
chiamo le guardie
questa vita dentro un bagno dentro un treno dentro un mondo
è troppo facile fare il sudoku
troppo difficile morire in galleria
è troppo scomodo un cadavere di drago
è troppo bello vederti andare via
dalle mie canzoni senza nostalgia
troppo difficile morire in galleria
è troppo scomodo un cadavere di drago
è troppo bello vederti andare via
dalle mie canzoni senza nostalgia
ho finito il sudoku lei conta i soldi
si toglie l'orologio s'increma le mani fin sui polsi
ha una collana di perle finte una parrucca
è impeccabile lo smalto rosa sulle dita dei piedi
non è granchè di viso
ma ha un corpo da duecentometrista
la considero una mignotta
perchè ha trecento euro nella borsetta
ma d'altronde ho fatto il sudoku semplice
adesso passo al medio
ma che lunga questa galleria
entra un drago con uno spiedo senza radio
un buietto senza la mitologia
fatti scopare puttana
trenta son troppi
chiamo le guardie
questa vita dentro un bagno dentro un treno dentro un mondo
è troppo facile fare il sudoku
troppo difficile morire in galleria
è troppo scomodo un cadavere di drago
è troppo bello vederti andare via
dalle mie canzoni senza nostalgia
Performed by Mariposa
martedì 17 maggio 2011
Bagno
Sul lavandino del bagno c'è ancora il tuo ultimo spazzolino consumato. Le setole spelacchiate, disordinate, sparse un po' a destra e un po' a sinistra: sembra uno di quei vecchi barboni disperati che chiedono l'elemosina nel sottopasso della stazione di Firenze. Non ho avuto il coraggio di buttarlo via. Non lo hai fatto tu, quando c'eri, non vedo quale diritto avrei di farlo io.
Stamattina sono entrato in bagno senza accendere la luce. Un chiarore opaco filtrava dalla persiana chiusa. C'era un aria azzurra mista al buio. Il box della doccia chiuso, a nascondere i dispiaceri, i flaconi di bagnoschiuma, shampoo, il balsamo. Una spazzola appoggiata per terra. Un mia lametta da barba non più utilizzabile.
Mi aspettavo di vedere anche fantasmi e spettri, l'ombra opaca di una figura solo tratteggiata nei suoi contorni. Invece non c'era. Lo spazio era pieno solo di questo vuoto inconsistente. Ho allungato una mano come per mescolarlo, quasi si fosse rappreso lì dentro a causa di un chissà quale scarico intasato, ma era leggero, quando ho mulinato la mano il vuoto non è sparito, si è solo spostato, di poco, sgorgando da sopra le pareti del box, come se quest’ultimo fosse una diga. Si è sparso ovunque, il vuoto.
L'ultima volta che mi hai detto di avere un problema, tutto attorno a noi c'era un strano odore di fritto. Sembravamo immersi in una bolla di olio sfrigolante, trasparente, intenti a nuotarci dentro bevendolo invece di respirare l'ossigeno. Ci muovevamo lenti, tu almeno. Quando mi spiegavi che il tuo problema ero io, perché io di problemi ne avevo anche più di uno, e tu non potevi farti carico dei tuoi e dei miei problemi. Devo cercare di risolvere quelli più vicini a me, dicesti, e ancora non avevo capito dove il tuo discorso ci avrebbe portati.
Mi sono sempre nascosto dietro la scusa di una malattia che non ho mai avuto. Te lo dissi fin dal primo giorno, quando facesti scivolare la tua mano dentro la mia dicendo: mi piace in questo modo. Appoggiasti la testa sulla mia spalla, e non faceva più freddo, non avevi più paura, tutto a un tratto il parco non era più buio. Prima di entrarci ti eri fermata un secondo. Avevi guardato l'orologio al polso, notando l'ora tarda. Non sarà pericoloso? chiedesti.
Non ci avevo mai pensato, pur andandoci quasi ogni sera. I giochi per bambini, le altalene e gli scivoli deserti, mi sembravano talmente innocui da non potere fare male a nessuno. Drogati, spacciatori, assassini, stupratori e rapinatori erano fuori dalla mia testa.
Non credo, dissi.
Stamattina sono entrato in bagno senza accendere la luce. Un chiarore opaco filtrava dalla persiana chiusa. C'era un aria azzurra mista al buio. Il box della doccia chiuso, a nascondere i dispiaceri, i flaconi di bagnoschiuma, shampoo, il balsamo. Una spazzola appoggiata per terra. Un mia lametta da barba non più utilizzabile.
Mi aspettavo di vedere anche fantasmi e spettri, l'ombra opaca di una figura solo tratteggiata nei suoi contorni. Invece non c'era. Lo spazio era pieno solo di questo vuoto inconsistente. Ho allungato una mano come per mescolarlo, quasi si fosse rappreso lì dentro a causa di un chissà quale scarico intasato, ma era leggero, quando ho mulinato la mano il vuoto non è sparito, si è solo spostato, di poco, sgorgando da sopra le pareti del box, come se quest’ultimo fosse una diga. Si è sparso ovunque, il vuoto.
L'ultima volta che mi hai detto di avere un problema, tutto attorno a noi c'era un strano odore di fritto. Sembravamo immersi in una bolla di olio sfrigolante, trasparente, intenti a nuotarci dentro bevendolo invece di respirare l'ossigeno. Ci muovevamo lenti, tu almeno. Quando mi spiegavi che il tuo problema ero io, perché io di problemi ne avevo anche più di uno, e tu non potevi farti carico dei tuoi e dei miei problemi. Devo cercare di risolvere quelli più vicini a me, dicesti, e ancora non avevo capito dove il tuo discorso ci avrebbe portati.
Mi sono sempre nascosto dietro la scusa di una malattia che non ho mai avuto. Te lo dissi fin dal primo giorno, quando facesti scivolare la tua mano dentro la mia dicendo: mi piace in questo modo. Appoggiasti la testa sulla mia spalla, e non faceva più freddo, non avevi più paura, tutto a un tratto il parco non era più buio. Prima di entrarci ti eri fermata un secondo. Avevi guardato l'orologio al polso, notando l'ora tarda. Non sarà pericoloso? chiedesti.
Non ci avevo mai pensato, pur andandoci quasi ogni sera. I giochi per bambini, le altalene e gli scivoli deserti, mi sembravano talmente innocui da non potere fare male a nessuno. Drogati, spacciatori, assassini, stupratori e rapinatori erano fuori dalla mia testa.
Non credo, dissi.
lunedì 16 maggio 2011
Fuori strada
Siamo usciti di strada talmente tante volte da non ricordarmene neppure più il numero. Abbiamo accartocciato la macchina - un fazzoletto sporco dentro le tasche dei pantaloni - contro i guardrail, gli alberi, altre macchine ancora, le nostre stesse illusioni. Nessuno ci aveva detto che la strada fosse così scivolosa. Tinto dal nero l'asfalto sembrava essere pulito dal sangue sul quale abbiamo slittato. Ad averci fatto caso, solo dopo ovviamente ce ne siamo resi conto, si poteva vedere la luna riflessa nelle pozze, sentendo lontani i lupi ululare al plenilunio. Mai una notte con le nuvole, le stelle lampadine difettose tra i mille aerei a sorvolare lo spazio sopra di noi. Sembrava così divertente, non abbiamo aspettato altro per firmare, lanciarci alla deriva, perdere gli ormeggi. Dimenticare.
Ci fermavamo nel primo parcheggio di un bar qualsiasi, bastava fosse il più vicino possibile ai nostri sogni. Scendevamo di macchina alla ricerca di un bagno. Dovevamo cagare vomitare e sputare fuori tutto quanto avevamo ingurgitato e ingoiato e aspirato, sperato. Lei ci aspettava in auto, sempre, si rifiutava di accompagnarci. Che schifo! Che stronzi che siete! Che facce di merda! Merda, appunto! Ribattevamo noi. Accendendo la radio a tutto volume lei con la musica si costruiva una tenda, una capanna. Preparava la nostra casa immaginaria affinché tutto sembrasse perfetto al nostro ritorno: mattonelle pulite in cucina, letti rifatti nei sedili posteriori, luci accese dei fanali a illuminare il niente di fronte a noi.
Noi tornavamo scarichi, pompe di benzina in riserva, urlando contro i distributori automatici che ci rubavano i soldi, sputavamo per terra, dandoci spintoni allegri. Le ginocchia ce le siamo sbucciate in questo modo, cadendo senza farsi male, senza proposito. Non avevamo bisogno di paracaduti, di protezioni alle braccia o alla testa. Avevamo la testa dura più dura di quanto si potesse sperare di avere, tanto che qualsiasi idea che ci volevano inculcare non attecchiva e veniva rigettata dopo poche settimane di annaffiamenti, lavaggi di capo, shampoo buttati al vento, risciacqui, balsami per capelli delicati. Noi non eravamo delicati, ma i capelli li perdevamo quasi fossero le buone intenzioni.
Dicevamo che tutto quanto andava bene. Potevamo essere i vostri migliori amici, i vostri peggiori nemici. Potevamo vestirci di qualsiasi bugia voi volevate, trasformandoci oggi nei sogni, domani negli incubi. Mentre gli altri si nascondevano dietro le porte chiuse delle loro camere a pensare pensieri che non avrebbero mai avuto il coraggio di dire, noi sfrecciavamo lungo le strade buie e deserte. Ma tutti quanti, noi loro, lei, tutti ci stavamo nascondendo.
Anche se la musica sembrava dirci di non preoccuparci, di rimandare pure a domani quello che avremmo dovuto fare oggi ieri l'altro ieri, sabato scorso ci dovevamo baciare ma non ci siamo neppure sfiorati, dovevamo vederci per scambiarci pensieri parole opere e omissioni, ma abbiamo lasciato che il tempo ci distraesse indicandoci un'altra via sperduta, perduta, per due. Noi due.
Siamo stati i vostri santi, i vostri maledetti. Siamo stati i cani che avete abbandonato e poi investito. Ma ci stavamo soltanto nascondendo mentre voi stavate facendo altrettanto, nascondendo sotto terra le vostre più intime paure.
Ci fermavamo nel primo parcheggio di un bar qualsiasi, bastava fosse il più vicino possibile ai nostri sogni. Scendevamo di macchina alla ricerca di un bagno. Dovevamo cagare vomitare e sputare fuori tutto quanto avevamo ingurgitato e ingoiato e aspirato, sperato. Lei ci aspettava in auto, sempre, si rifiutava di accompagnarci. Che schifo! Che stronzi che siete! Che facce di merda! Merda, appunto! Ribattevamo noi. Accendendo la radio a tutto volume lei con la musica si costruiva una tenda, una capanna. Preparava la nostra casa immaginaria affinché tutto sembrasse perfetto al nostro ritorno: mattonelle pulite in cucina, letti rifatti nei sedili posteriori, luci accese dei fanali a illuminare il niente di fronte a noi.
Noi tornavamo scarichi, pompe di benzina in riserva, urlando contro i distributori automatici che ci rubavano i soldi, sputavamo per terra, dandoci spintoni allegri. Le ginocchia ce le siamo sbucciate in questo modo, cadendo senza farsi male, senza proposito. Non avevamo bisogno di paracaduti, di protezioni alle braccia o alla testa. Avevamo la testa dura più dura di quanto si potesse sperare di avere, tanto che qualsiasi idea che ci volevano inculcare non attecchiva e veniva rigettata dopo poche settimane di annaffiamenti, lavaggi di capo, shampoo buttati al vento, risciacqui, balsami per capelli delicati. Noi non eravamo delicati, ma i capelli li perdevamo quasi fossero le buone intenzioni.
Dicevamo che tutto quanto andava bene. Potevamo essere i vostri migliori amici, i vostri peggiori nemici. Potevamo vestirci di qualsiasi bugia voi volevate, trasformandoci oggi nei sogni, domani negli incubi. Mentre gli altri si nascondevano dietro le porte chiuse delle loro camere a pensare pensieri che non avrebbero mai avuto il coraggio di dire, noi sfrecciavamo lungo le strade buie e deserte. Ma tutti quanti, noi loro, lei, tutti ci stavamo nascondendo.
Anche se la musica sembrava dirci di non preoccuparci, di rimandare pure a domani quello che avremmo dovuto fare oggi ieri l'altro ieri, sabato scorso ci dovevamo baciare ma non ci siamo neppure sfiorati, dovevamo vederci per scambiarci pensieri parole opere e omissioni, ma abbiamo lasciato che il tempo ci distraesse indicandoci un'altra via sperduta, perduta, per due. Noi due.
Siamo stati i vostri santi, i vostri maledetti. Siamo stati i cani che avete abbandonato e poi investito. Ma ci stavamo soltanto nascondendo mentre voi stavate facendo altrettanto, nascondendo sotto terra le vostre più intime paure.
venerdì 13 maggio 2011
To Begin
Down the stairs to the stone house
Golden light, oh what a fight, another sleepless night
Her dress's, filigree
She tells me all her secrets then I'm back on the street
Oh
It's hard, oh it's hard to help yourself
When you don't know where to begin
It's the devil, it's the boil, it's the black of night
In your head, in your head
Do you see the fire heavy lit before this time
Know you the color of the end of, the end of the end
Silence is dancing to beating drum
Money is nothing but a loaded gun
Oh, whoa
And it's hard, oh it's hard to help yourself
When you don't know where to begin
It's the devil, it's the boil, it's the black of night
In your head, in your head
It's hard, oh it's hard to help yourself
When you don't know where to begin
It's the devil, it's the boil, it's the black of night
In your head, in your head
And it's hard, oh it's hard to help yourself
When you don't know where to begin
In the midst of a moment can you break the boy
Can you tame a demon?
Light a candle in the dark, in the dark, in dark
In the dark, light a candle in the dark, in dark
In dark, in dark, oh, whoa, whoa
In the dark, light a candle in the dark, in dark
In dark, in dark
Golden light, oh what a fight, another sleepless night
Her dress's, filigree
She tells me all her secrets then I'm back on the street
Oh
It's hard, oh it's hard to help yourself
When you don't know where to begin
It's the devil, it's the boil, it's the black of night
In your head, in your head
Do you see the fire heavy lit before this time
Know you the color of the end of, the end of the end
Silence is dancing to beating drum
Money is nothing but a loaded gun
Oh, whoa
And it's hard, oh it's hard to help yourself
When you don't know where to begin
It's the devil, it's the boil, it's the black of night
In your head, in your head
It's hard, oh it's hard to help yourself
When you don't know where to begin
It's the devil, it's the boil, it's the black of night
In your head, in your head
And it's hard, oh it's hard to help yourself
When you don't know where to begin
In the midst of a moment can you break the boy
Can you tame a demon?
Light a candle in the dark, in the dark, in dark
In the dark, light a candle in the dark, in dark
In dark, in dark, oh, whoa, whoa
In the dark, light a candle in the dark, in dark
In dark, in dark
Performed by Alela Diane
mercoledì 11 maggio 2011
Considera l'aragosta
Non stupisce se non riesco ad apprezzare l’ironia che è davvero al cuore di Kafka: e cioè che lo sforzo mostruoso di affermare un sé umano risulta in un se la cui umanità sarà inscindibile da quel mostruoso sforzo. Che il nostro infinito e impossibile percorso verso casa in realtà è già casa. È difficile metterlo in parole, sulla lavagna, credetemi. Potete dire loro che forse è un bene se non “colgono” Kafka. Potete chiedere di immaginare che tutte le sue storie siano una specie di porta. Di immaginare noi che ci avviciniamo e battiamo a questa porta, sempre più forte, battiamo e battiamo, non solo perché vogliamo entrare, ma perché ne abbiamo bisogno; non sappiamo cosa sia ma possiamo sentirlo, questo desiderio disperato e assoluto di entrare, e battiamo e spingiamo e calciamo. Finché ecco che la porta si apre… e si apre verso l’esterno - eravamo già dove volevamo essere sin dal principio. Das ist komisch.
Da un certo punto di vista, la pubblicazione di qualsiasi nuovo libro ben fatto sull’uso dell’americano è sempre accompagnata da una certa ironia. E cioè le persone che si interessano a questo libro sono anche quelle che ne hanno meno bisogno – offrire consigli sulle finezze dell’inglese statunitense è come predicare ai convertiti.
Un collega Snob di mia conoscenza ama dire che ascoltare gente parlare in pubblico di solito è come guardare qualcuno che usa uno Stradivari per battere chiodi.
Di solito che ascolta è in grado di capire cosa intendo quando mi sbaglio e uso desumere invece di presumere o dico indicare per dire. ma molti di questi solecismi – o anche solo farraginose ridondanze come “La porta era di forma rettangolare” – richiedono almeno un paio di nanosecondi di sforzo cognitivo in più, una specie di rapido processo di filtraggio e scarto, prima che il destinatario capisca. Tutta fatica in più. Quanta, esattamente, è discutibile, ma sembra innegabile che quando non rispettiamo certe convenzioni carichiamo l’interlocutore di qualche peso interpretivo in più.
-Mi dica, sig. N-, poniamo il caso che qualcuno, tipo uno straniero o un reporter della Tv o che so io, passasi di qui e le chiedesse che scopo hanno esattamente tutte queste bandiere dopo quello che è successo ieri, lei cosa pensa risponderebbe?
Ottenere il massimo a diciassette anni e perderlo a ventuno a causa di eventi che sono al di fuori del tuo controllo è esattamente come morire solo che poi devi continuare a vivere.
Dando per scontato che siate giovani elettori, vale di nuovo la pena di spendere qualche istante del vostro tempo prezioso per valutare le implicazioni delle due ultime affermazioni dei tecnici. Se siete annoiati e disgustati dalla politica e non vi disturbare a votare, di fatto votate per gli arroccati establishment dei due principali partiti, i quali, potete starne certi, stupidi non sono, ma anzi hanno una consapevolezza profonda di quanto gli convenga mantenervi in una condizione di disgusto e noia e cinismo, fornendovi ogni possibile motivazione psicologica perché il giorno delle primarie ve ne stiate a casa a farvi i cilum guardando Mtv. Sia chiaro: avete tutto il diritto di stare a casa, se volete, ma non prendetevi in giro pensando di non votare. In realtà, non votare è impossibile: si può votare votando, oppure votare rimanendo a casa e raddoppiando tacitamente il valore del voto di un irriducibile.
È naturalmente molto meno difficile suscitare nelle persone autentica rabbia, indignazione e risentimento, piuttosto che indurre gioia, soddisfazione, senso di fratellanza eccetera. Queste ultime sono emozioni fragili e complesse, e ciò che le provoca varia moltissimo da persona a persona, laddove la rabbia e altro sono emozioni più primarie, universali e facili da stimolare.
David Foster Wallace
Disegni ritratti
Poi ho preso a disegnarti. È stata una specie di folgorazione. Una mattina mi sono svegliato e ho cominciato a non fare altro. Ti disegnavo su fogli di carta, su vecchi quaderni, sui muri, per strada, ovunque. Prima le mani, poi le braccia, le gambe, il viso, il seno. Un po' mi sentivo anche in colpa. Tutti apprezzavano quei ritratti, dicevano fossero di una sensibilità unica: le linee scarabocchiate a delineare i contorni del volto, i colori pastello che ti illuminavano i capelli, le curve armoniche con cui si piegavano le braccia, i polsi. Chiunque li vedesse, i miei disegni, non faceva altro che tesserne le lodi.
Io arrossivo sempre. Non sapevo come rispondere. La gente passava davanti al tuo volto fatto dai miei tratti e mi diceva: ti amo. Io rimanevo senza parole. Dire grazie mi pareva troppo banale. Mi limitavo ad arrossire, spostando lo sguardo per non incrociare i loro occhi. Questa gente pronta a innamorarsi di me, per merito in fondo solo tuo, non la conoscevo, non potevo ricambiare il loro sentimento. Avrei potuto prendere le mani di ognuno e stringerle dentro le mie mani, farle sentire accettate, dire: anche io ti amo, a tutti, a ogni persona che me lo diceva. Ma non sarebbe stato sincero, avrei soltanto finto. Non mi sembrava giusto nei loro confronti, né nei tuoi. In più mi sarei sentito un traditore, per avere usato il mio ti amo come banale merce di scambio: i miei sentimenti barattati per farmi sentire adeguato a dei complimenti fatti da altri, con il cuore aperto. Chi sa come richiudere tutti questi cuori senza fare del male, senza lasciare nessuna traccia?
Rispondevo che non era merito mio. La bellezza era tua, gli occhi erano i tuoi, i lineamenti pure. Tutto quanto scaturiva da quei disegni, veniva fuori perché in un modo o nell'altro tu nella vita reale lo avevi dentro, pronto a farlo esplodere o a farlo sfumare in carezze. Ma loro, la gente, non voleva capire, dava tutto il merito a me. Dicevano fosse necessaria un'abilità particolare per trasportare su un foglio di carta tutti gli aspetti speciali di una personalità, fosse quest'ultima reale o anche inventata completamente. Vedevano nelle mie mani uno strumento speciale che gli altri non avevano. Mi chiamavano genio, artista. E io arrossivo sempre di più.
A volte la notte mi svegliavo di soprassalto. Gli incubi mi tormentavano. Avevo paura di cosa avrebbero potuto farmi se mi avessero mai scoperto. Io non era un genio, non ero un artista. Mi sentivo un impostore anche quando mi sentivo appellare come pittore. Io non inventavo niente, mi limitavo a copiare, se così si può dire. Ero colpevole di plagio. Quando avrebbero scoperto il mio trucco tutti si sarebbero scagliati contro di me, anche quelli che mi avevano dichiarato tutto il loro amore, sputando veleno sui tuoi ritratti, su ciò che avevano tanto amato. Quando iniziai a disegnarti non lo feci perché di punto in bianco mi venne l'ispirazione di immortalarti. Lo feci semplicemente perché cominciai a vederti ovunque. Ti vedevo distesa sul letto, ma quando cercavo di toccarti scoprivo che eri impalpabile, svanivi, perciò presi un pennarello e tracciai i tuoi contorni sulle lenzuola. Poi ti ombreggiai, seguendo i chiaro scuri della luce. Lo facevo in casa, sulle pareti delle camere, in cucina, rannicchiata sul pavimento, sdraiata per terra, vestita, svestita, nuda, sorridente, seria, assorta, intenta a guardarmi, a ignorarmi, a pensare cosa avremmo potuto fare insieme, oppure a scacciare le paure che ti facevo venire, il timore di diventare aggressivo, di violentarti non in senso fisico ma in senso morale, stuprarti la mente, sventrarti i desideri. Ti vedevo per strada camminare lungo i bordi di un muro, passare da una casa all'altra con la tua andatura, appoggiata ai lampioni mentre parlavi con altra gente a me sconosciuta, sui vetri in plexiglass delle pensiline delle fermate degli autobus, sui vagoni dei treni, nelle stazioni, sui marciapiedi del centro e della periferia. Solo dopo mesi iniziai a disegnarti su dei fogli di carta, ma anche quelli non erano che semplici ricalchi, niente di speciale.
Io non inventavo niente. Ti vedevo solo ovunque e in tutti i modi cercavo di renderti il più reale possibile. Quando chiudevo gli occhi tu sparivi, proprio come avevi fatto nella realtà. Nella realtà on eri più tornata, mentre quando riaprivo gli occhi tu tornavi. Ti disegnavo per timore che tu decidessi di non tornare neppure in quel caso.
Io arrossivo sempre. Non sapevo come rispondere. La gente passava davanti al tuo volto fatto dai miei tratti e mi diceva: ti amo. Io rimanevo senza parole. Dire grazie mi pareva troppo banale. Mi limitavo ad arrossire, spostando lo sguardo per non incrociare i loro occhi. Questa gente pronta a innamorarsi di me, per merito in fondo solo tuo, non la conoscevo, non potevo ricambiare il loro sentimento. Avrei potuto prendere le mani di ognuno e stringerle dentro le mie mani, farle sentire accettate, dire: anche io ti amo, a tutti, a ogni persona che me lo diceva. Ma non sarebbe stato sincero, avrei soltanto finto. Non mi sembrava giusto nei loro confronti, né nei tuoi. In più mi sarei sentito un traditore, per avere usato il mio ti amo come banale merce di scambio: i miei sentimenti barattati per farmi sentire adeguato a dei complimenti fatti da altri, con il cuore aperto. Chi sa come richiudere tutti questi cuori senza fare del male, senza lasciare nessuna traccia?
Rispondevo che non era merito mio. La bellezza era tua, gli occhi erano i tuoi, i lineamenti pure. Tutto quanto scaturiva da quei disegni, veniva fuori perché in un modo o nell'altro tu nella vita reale lo avevi dentro, pronto a farlo esplodere o a farlo sfumare in carezze. Ma loro, la gente, non voleva capire, dava tutto il merito a me. Dicevano fosse necessaria un'abilità particolare per trasportare su un foglio di carta tutti gli aspetti speciali di una personalità, fosse quest'ultima reale o anche inventata completamente. Vedevano nelle mie mani uno strumento speciale che gli altri non avevano. Mi chiamavano genio, artista. E io arrossivo sempre di più.
A volte la notte mi svegliavo di soprassalto. Gli incubi mi tormentavano. Avevo paura di cosa avrebbero potuto farmi se mi avessero mai scoperto. Io non era un genio, non ero un artista. Mi sentivo un impostore anche quando mi sentivo appellare come pittore. Io non inventavo niente, mi limitavo a copiare, se così si può dire. Ero colpevole di plagio. Quando avrebbero scoperto il mio trucco tutti si sarebbero scagliati contro di me, anche quelli che mi avevano dichiarato tutto il loro amore, sputando veleno sui tuoi ritratti, su ciò che avevano tanto amato. Quando iniziai a disegnarti non lo feci perché di punto in bianco mi venne l'ispirazione di immortalarti. Lo feci semplicemente perché cominciai a vederti ovunque. Ti vedevo distesa sul letto, ma quando cercavo di toccarti scoprivo che eri impalpabile, svanivi, perciò presi un pennarello e tracciai i tuoi contorni sulle lenzuola. Poi ti ombreggiai, seguendo i chiaro scuri della luce. Lo facevo in casa, sulle pareti delle camere, in cucina, rannicchiata sul pavimento, sdraiata per terra, vestita, svestita, nuda, sorridente, seria, assorta, intenta a guardarmi, a ignorarmi, a pensare cosa avremmo potuto fare insieme, oppure a scacciare le paure che ti facevo venire, il timore di diventare aggressivo, di violentarti non in senso fisico ma in senso morale, stuprarti la mente, sventrarti i desideri. Ti vedevo per strada camminare lungo i bordi di un muro, passare da una casa all'altra con la tua andatura, appoggiata ai lampioni mentre parlavi con altra gente a me sconosciuta, sui vetri in plexiglass delle pensiline delle fermate degli autobus, sui vagoni dei treni, nelle stazioni, sui marciapiedi del centro e della periferia. Solo dopo mesi iniziai a disegnarti su dei fogli di carta, ma anche quelli non erano che semplici ricalchi, niente di speciale.
Io non inventavo niente. Ti vedevo solo ovunque e in tutti i modi cercavo di renderti il più reale possibile. Quando chiudevo gli occhi tu sparivi, proprio come avevi fatto nella realtà. Nella realtà on eri più tornata, mentre quando riaprivo gli occhi tu tornavi. Ti disegnavo per timore che tu decidessi di non tornare neppure in quel caso.
martedì 10 maggio 2011
La mia mela
Amavo le frasi con le quali si aprivano i romanzi. A volte trasmettevano l'intera atmosfera del libro, erano una specie di riassunto di ciò che ti attendeva se avresti avuto la pazienza di andare avanti. Mi afferravano le viscere, se lo stile narrativo era crudo, rovistando l'intestino da sotto a sopra con parole spigolose capaci di descrivere non solo situazioni estreme ma anche la loro sostanza, la stessa differenza tra vedere una bistecca e assaggiarla. Oppure scendevano silenziose dentro il mio stomaco, calandosi dalla bocca con un filo, o con il ritmo sinuoso della prosa, e una volta arrivate a destinazione cercavano di farsi spazio allargando le pareti attorno a loro.
Questo facevo quando entravo in una libreria: lasciavo ai libri di entrare a loro volta dentro di me. Ne prendevo uno, lo aprivo, ne leggevo non più di una pagina, e lo rimettevo a posto. Prendevo un altro libro, assaporavo le prima parole, poi lo chiudevo e lo lasciavo dove l'avevo preso. Poi ne prendevo un altro, e un altro ancora, e ancora, fino a quando non si faceva tardi ed ero costretto a tornarmene a casa.
Se un libro valeva la pena di essere letto, durante quelle prime frasi in intimità, a fior di labbra, riusciva comunque a farmi provare qualcosa, fosse questo qualcosa doloroso da morire, quanto una caduta di bicicletta da bambino, con il volto a strusciarsi sanguinante contro l'asfalto ruvido, o al contrario talmente armonioso da riuscire quasi a rendere soffice lo stesso asfalto sul quale cadevo ugualmente. Quando leggevo cercavo in qualsiasi caso la caduta. Detestavo le storie che non mi facevano sanguinare o non mi facevano guarire. Erano storie che mi lasciavano tale e quale a come ero quando le avevo iniziate. I romanzi, quelli veri, devono riuscire a cambiarti, anche se di poco, altrimenti sono solo frasi legate le une alle altre, senza motivo né scopo. Un libro deve accrescerti, mettere un mattoncino nella costruzione del tuo essere, insegnarti, oppure demolire, distruggere certezze, cancellare una piccola parte di te. Se non fa né l'una né l'altra cosa significa soltanto che il suo unico obbiettivo era compiacerti, e questo, ti posso assicurare, non è mai un bene.
Questo facevo quando entravo in una libreria: lasciavo ai libri di entrare a loro volta dentro di me. Ne prendevo uno, lo aprivo, ne leggevo non più di una pagina, e lo rimettevo a posto. Prendevo un altro libro, assaporavo le prima parole, poi lo chiudevo e lo lasciavo dove l'avevo preso. Poi ne prendevo un altro, e un altro ancora, e ancora, fino a quando non si faceva tardi ed ero costretto a tornarmene a casa.
Se un libro valeva la pena di essere letto, durante quelle prime frasi in intimità, a fior di labbra, riusciva comunque a farmi provare qualcosa, fosse questo qualcosa doloroso da morire, quanto una caduta di bicicletta da bambino, con il volto a strusciarsi sanguinante contro l'asfalto ruvido, o al contrario talmente armonioso da riuscire quasi a rendere soffice lo stesso asfalto sul quale cadevo ugualmente. Quando leggevo cercavo in qualsiasi caso la caduta. Detestavo le storie che non mi facevano sanguinare o non mi facevano guarire. Erano storie che mi lasciavano tale e quale a come ero quando le avevo iniziate. I romanzi, quelli veri, devono riuscire a cambiarti, anche se di poco, altrimenti sono solo frasi legate le une alle altre, senza motivo né scopo. Un libro deve accrescerti, mettere un mattoncino nella costruzione del tuo essere, insegnarti, oppure demolire, distruggere certezze, cancellare una piccola parte di te. Se non fa né l'una né l'altra cosa significa soltanto che il suo unico obbiettivo era compiacerti, e questo, ti posso assicurare, non è mai un bene.
lunedì 9 maggio 2011
Un anno molto particolare
Carezzare un cane ha spesso questa funzione, blandire l’animale per lusingare il padrone, riempire il vuoto che si allarga tutt’intorno.
Un gesto minuscolo che darà avvio a tutti gli altri gesti, e la giornata acquisterà spessore, è questo che spero
So che la lettera per Simon sarà lunga, che non gli risparmierò alcun dettaglio. Ho bisogno di pensare in una lingua che sia la mia, di scegliere ogni parola per dire esattamente ciò che sento. In tedesco, invece, ho la sensazione che il mio pensiero si restringa, perdo in perspicacia, soccombo a una semplificazione del mondo che mi spaventa. Ho paura di perdermi, di perdere il senso delle parole, ho paura di scomparire.
Quando gli avevo parlato del mio progetto, dell’idea di andarmene lontano da casa, sfinita perché i nostri genitori non riuscivano a venire a capo dei loro tentativi di separazione, Simon mi aveva detto che avevo ragione di andare a respirare da qualche altra parte. Aveva detto “respirare”, e invece qui soffoco. Soffoco perché non sono mai sola, eppure non ho mai sofferto così tanto di solitudine.
Saper parlare una lingua straniera è proprio questo: essere a proprio agio con i mezzi toni, abili nell’uso delle sfumature.
Il mio compagno mi fa girare ancora una volta prima di affidarmi a un altro ballerino, e io passo da un uomo all’altro per una parte della serata, allora mi dispiace non amare la birra, perché se avessi bevuto un po’ non sarei intralciata da tutta la mia lucidità e l’impressione della realtà non mi colpirebbe con tanta violenza.
Simon ammaliato, che aderisce a ogni parola che dice quella ragazza
Mi sdoppio e assisto allo spettacolo offerto da questa ragazza, d’un tratto frivola e leggera, rapita dall’opacità della notte e dall’insistenza dei bassi che risuonano in tutto il corpo.
Brigitte Giraud
venerdì 6 maggio 2011
Un romantico a Milano
Mamma
che ne dici di un romantico a Milano?
fra i Manzoni preferisco quello vero:Piero
Leggi
c'è un maniaco sul 'Corriere della Sera'
la sua mano per la zingara di Brera
è nera
Fuggi
cosa fuggi non c'è modo di scappare
ho la febbre ma ti porto fuori a bere
non è niente stai tranquilla è solo il cuore
porta ticinese piove ma c'è il sole
quando il dandy muore fuore nasce un fiore
le ragazze fan la fila per vedere
la sua tomba con su scritte le parole
"io vi amo
vi amo ma vi odio però
vi amo tutti
è bello è brutto io non lo so
io vi amo
vi amo ma vi odio però
vi amo tutti
è bello è brutto è solo questo"
Scusi
che ne pensa di un romantico alla Scala?
quando canta le canzoni della mala scola
quasi centomila Montenegro e Bloody Mary
mocassini gialli e sentimenti chiaro-scuri
Cara
scriverà sulle tovaglie dei Navigli
quanta gioia, quanti giorni, quanti sbagli
quanto freddo nei polmoni
che dolore
non è niente non è niente
lascia stare
se la Madonnina muore nasce un fiore
lui non vuole che la sua ragazza legga
quelle frasi incise quelle frasi amare
la sua tomba con su scritte le parole
"io vi amo
vi amo ma vi odio però
vi amo tutti
è bello è brutto io non lo so
io vi amo
vi amo ma vi odio però
vi amo tutti
è bello è brutto è un giglio marcio
io vi amo
vi amo ma vi sputo però
vi amo tutti
è bello è brutto è solo questo"
L'erba ti fa male se la fumi senza stile!
Performed by Baustelle
che ne dici di un romantico a Milano?
fra i Manzoni preferisco quello vero:Piero
Leggi
c'è un maniaco sul 'Corriere della Sera'
la sua mano per la zingara di Brera
è nera
Fuggi
cosa fuggi non c'è modo di scappare
ho la febbre ma ti porto fuori a bere
non è niente stai tranquilla è solo il cuore
porta ticinese piove ma c'è il sole
quando il dandy muore fuore nasce un fiore
le ragazze fan la fila per vedere
la sua tomba con su scritte le parole
"io vi amo
vi amo ma vi odio però
vi amo tutti
è bello è brutto io non lo so
io vi amo
vi amo ma vi odio però
vi amo tutti
è bello è brutto è solo questo"
Scusi
che ne pensa di un romantico alla Scala?
quando canta le canzoni della mala scola
quasi centomila Montenegro e Bloody Mary
mocassini gialli e sentimenti chiaro-scuri
Cara
scriverà sulle tovaglie dei Navigli
quanta gioia, quanti giorni, quanti sbagli
quanto freddo nei polmoni
che dolore
non è niente non è niente
lascia stare
se la Madonnina muore nasce un fiore
lui non vuole che la sua ragazza legga
quelle frasi incise quelle frasi amare
la sua tomba con su scritte le parole
"io vi amo
vi amo ma vi odio però
vi amo tutti
è bello è brutto io non lo so
io vi amo
vi amo ma vi odio però
vi amo tutti
è bello è brutto è un giglio marcio
io vi amo
vi amo ma vi sputo però
vi amo tutti
è bello è brutto è solo questo"
L'erba ti fa male se la fumi senza stile!
Performed by Baustelle
giovedì 5 maggio 2011
Il tanto decantato
C'era questa conversazione durante la quale lui mi diceva che l'amore era in fondo un po' come il vino: all'inizio ti piace, ma alla fine ti ubriaca. Io non ho mai sopportato l'amore, l'idea per lo meno. Mi ha sempre dato il voltastomaco. Per favore, gli dicevo, non parlare d'amore. L'amore è solo quello adolescenziale, quello che si vive tra i banchi di scuola, quando ancora non riesci neppure a immaginare ciò che ti aspetta davvero dopo il diploma, o la laurea. Magari fai il duro, il grande, e dici agli altri e a te stesso di saperlo benissimo, cosa sia la vita al di là dello studio; ma la verità è che sono solo supposizioni, teorie non supportate dalla pratica, non ancora per lo meno. L'amore, il tanto decantato, è un concetto costruito su di una vita dove ancora la casa non è invasa dalla polvere ogni tre giorni, nella quale le camicie si stirano magicamente da sole e le ritrovi già perfette dentro l'armadio. Ciò che proviamo noi, a trent'anni, è qualcosa di completamente diverso, un amore strofinato e liso, lavato, risciacquato; una stoffa che ti brucia e ti punge, ma di cui nonostante tutto non riesci a fare a meno perché altrimenti sentiresti un freddo cane. Così vanno bene pure le ustioni, piuttosto del gelo. L'amore dei trent'anni, l'amore grande, è difficile da spiegare, perché rispetto a quello dei quindici è assai più complicato, intrecciato com'è in mille altre cose.
mercoledì 4 maggio 2011
La fortezza della solitudine
Forse perfezionare una cosa era come distruggerla.
Croft andò in cucina e tornò con altri bicchieri e rimasero sotto il sole screziato a spremere limoni nella Coca-Cola e a sfogliare i giornalini, Dylan e Rachel e Croft, mentre Isabel Vendle si faceva diventare i polpastrelli quasi neri con l’inchiostro del Times. La Torcia umana era il fratello minore della Ragazza invisibile, che era sposata con Mr. Fantastic, mentre Ben Grimm era la Cosa e Alicia la sua fidanzata cieca, una scultrice in grado di apprezzare sinceramente l’orribile ma monumentale corpo di lui, e Silver Surfer era l’emissario di Galactus, e Galactus divorava i pianeti, ma Silver Surfer aveva aiutato i Fantastici Quattro a difendere la Terra, e Freccia Nera non poteva aprir bocca perché anche solo una sillaba da lui pronunciata era così potente da fare a pezzi il mondo: Croft e sua madre spiegarono tutte queste cose a Dylan, nuvolette di parole nelle tavole vivaci su carta giallina, mentre Vendlemachine muoveva le labbra in silenzio finché non si appisolò sulla sua sedia, e il pomeriggio domenicale di fine ottobre sprofondò nella sera.
“Come dicevo, ho notato che parlavi con Mingus Rude, è in terza media, com’è che lo conosci? Non che si faccia vedere granché, a scuola, eh? Però mi sa che è un vantaggio essere amici di… hsss… quel tipo di persone.”
Il discorso di Arthur Lomb aveva come una cicatrice grinzosa, un inciampo di fiato nel punto in cui aveva omesso la parola ‘nero’ dalla frase ma non dal pensiero che aveva dato origine alla frase.
Dylan non credeva di aver paura dell’altezza, ma il tetto di casa loro gli aveva sempre dato le vertigini, non tanto il vuoto fino a terra, quanto la vista sui tetti, fino a Coney Island e oltre. Era più facile se si guardava verso le torri di Manhattan. Ti rimettevano a posto, ti ponevano in una stabile relazione di piccolezza e timore reverenziale. Ancora più semplice inginocchiarsi sull’orlo del tetto, le mani aggrappate al bordo di mattoni alto fino alla caviglia, e scrutare di sotto il contenuto del tuo giardino: ailanto, mucchio di mattoni, ciuffi di erbacce una spaldeen sporca visibile appena come un brandello di carne. La realtà a dimensione di granello è rassicurante.
Il piccolo molo marcio su cui era seduto il ragazzo di città galleggiava in una chiazza grigioverde, simile alla fotografia corrosa di una nuvola.
Era abbastanza naturale in quei pomeriggi bagnati, ubriachi di insetti, la casa, il laghetto, il campo, il cortile di ghiaia davanti alla casa, tutti per Dylan e Heather, che si ritrovassero a un certo punto distesi in costume a lasciare impronte di culi umidi sul divano, uno accanto all’altro, ora ansimando ora ridendo istericamente, e un attimo dopo accucciarsi a ginocchia nude sulle sedie in cucina, a mescolare in un Tupperware da un litro cristalli di limonata con acqua di rubinetto fredda. Altrettanto probabile che poi decidessero di portare bicchieri grondanti pieni di ghiaccio i soffitta, che di giorno ribolliva di uno psichedelico sciamare di polvere fluttuante nella luce obliqua.
Potevi crescere nella città in cui si faceva la storia e, ciononostante, perdertela completamente.
La chiave di quasi tutto è nel far finta che la tua prima volta non sia veramente la prima.
I mesi tra il liceo e il college furono una fase di cupo deragliamento, tutti per metà proiettati verso nuovi destini ma senza essere ancora arrivati da nessuna parte.
Avrebbe dovuto passare l’estate a scrivere una parte della sua tesi… così come io avrei dovuto mettere già la mia sceneggiatura. Invece avevamo litigato e scopato, e, con il passare del tempo, eravamo precipitati in silenzi separati e torvi ognuno nella sua stanza.
Quando due corpi provano il crudo e arcano impulso a unirsi, quando ancora non si è avuto il tempo di farsi del male a vicenda, è facile per uno far sorridere l’altro.
Solo due notti più tardi, dopo che Arthur se n’era andato, Moira e io avremmo dormito di nuovo insieme, un errore pagato caro in un dicembre di errori pagati cari.
Jonathan Lethem
martedì 3 maggio 2011
Non raccontata
A volte mi prende voglia di raccontargli una storia che non è mai stata raccontata. Parla di un ragazzo e una ragazza, ovviamente. C'è un amico che cerca di fare capire al ragazzo quanto sia improbabile la relazione tra loro, tra il ragazzo e la ragazza, perché la ragazza in realtà sta con un altro ragazzo. Per quanto si possa sforzare l'amico non riesce a convincere il ragazzo a lasciare perdere, a voltare pagina per quanto questa pagina possa essere pesante e dura da voltare. Così il ragazzo rimane incastrato in tutta una serie di situazioni di stasi, una specie di coma cosciente, tipo trovarsi a passare la notte in un parcheggio deserto in attesa dell'arrivo della ragazza, fino a quando la ragazza non telefona per dirgli che non può più passare. Oppure fare lunghissimi viaggi estenuanti solo per trascorrere una manciata di minuti da solo con la ragazza, per fingere almeno una sera di essere una specie di coppia normale: cenare in una pizzeria fuori provincia, dove nessuno li conosce, senza il rischio di essere visti da qualcuno; immaginarsi per un poco, lui, dentro la vita dell'altro, del ragazzo vero della ragazza.
A un certo punto di questa storia il ragazzo e l'amico si trovano seduti su una panchina di un parco durante un pomeriggio qualsiasi. Parlano, l'amico per convincere il ragazzo a lasciare perdere, il ragazzo per cercare di capire la situazione, trovare il bandolo della matassa capace di risolvergli la situazione.
È una matassa bella complicata, dice l'amico, è piena di nodi. Scioglierli tutti è proprio un casino. Il ragazzo però non sembra ascoltarlo. È talmente immerso nel suo rompicapo da essersi isolato da qualsiasi cosa gli possa stare intorno. Non sente l'amico. Non sente le anatre starnazzare mentre nuotano nel laghetto del parco, né le risate di alcuni bambini intenti a giocare a due passi da loro. Un due tre, stella! Squisio. Bomba libera tutti! Il vento ha iniziato ad alzarsi, andando a sbattere freddo sulla faccia del ragazzo, ma lui non sente neppure quello.
Alla fine l'amico si alza dalla panchina un po' spazientito da tutto quel silenzio. Questa storia tra te e lei mi sta facendo venire il mal di gola, dice mettendosi in bocca una di quelle medicine sottoforma di caramelle aromatizzate al limone; si alza ma non se ne va. L'aspetta. Solo quando il ragazzo si alza dalla panchina i due escono dal parco per andare verso casa.
A volte vorrei raccontargli questa storia mai raccontata per tranquillizzarlo, fargli capire che nonostante mi possa alterare, mi possa arrabbiare, chiamare lui stupido e lei puttana, alla fine non lo lascerò solo in questo casino - anche quando magari mi verrà mal di gola a forza di parlarne, discuterne, ragionare di continuo dei soliti discorsi, come se stessimo avvitando una vite spanata che gira gira e gira ma gira sempre a vuoto - perché mi sento un po' la sua ciambella di salvataggio a cui può aggrapparsi, mentre viene sballottato di qua e di là da correnti sulle quali ha poco potere.
Mi piacerebbe però capisse anche che la loro storia è proprio come questa storia, ovvero non raccontata.
A un certo punto di questa storia il ragazzo e l'amico si trovano seduti su una panchina di un parco durante un pomeriggio qualsiasi. Parlano, l'amico per convincere il ragazzo a lasciare perdere, il ragazzo per cercare di capire la situazione, trovare il bandolo della matassa capace di risolvergli la situazione.
È una matassa bella complicata, dice l'amico, è piena di nodi. Scioglierli tutti è proprio un casino. Il ragazzo però non sembra ascoltarlo. È talmente immerso nel suo rompicapo da essersi isolato da qualsiasi cosa gli possa stare intorno. Non sente l'amico. Non sente le anatre starnazzare mentre nuotano nel laghetto del parco, né le risate di alcuni bambini intenti a giocare a due passi da loro. Un due tre, stella! Squisio. Bomba libera tutti! Il vento ha iniziato ad alzarsi, andando a sbattere freddo sulla faccia del ragazzo, ma lui non sente neppure quello.
Alla fine l'amico si alza dalla panchina un po' spazientito da tutto quel silenzio. Questa storia tra te e lei mi sta facendo venire il mal di gola, dice mettendosi in bocca una di quelle medicine sottoforma di caramelle aromatizzate al limone; si alza ma non se ne va. L'aspetta. Solo quando il ragazzo si alza dalla panchina i due escono dal parco per andare verso casa.
A volte vorrei raccontargli questa storia mai raccontata per tranquillizzarlo, fargli capire che nonostante mi possa alterare, mi possa arrabbiare, chiamare lui stupido e lei puttana, alla fine non lo lascerò solo in questo casino - anche quando magari mi verrà mal di gola a forza di parlarne, discuterne, ragionare di continuo dei soliti discorsi, come se stessimo avvitando una vite spanata che gira gira e gira ma gira sempre a vuoto - perché mi sento un po' la sua ciambella di salvataggio a cui può aggrapparsi, mentre viene sballottato di qua e di là da correnti sulle quali ha poco potere.
Mi piacerebbe però capisse anche che la loro storia è proprio come questa storia, ovvero non raccontata.
lunedì 2 maggio 2011
Marzo 2011

"Ho cercato di affogare i pensieri nell'alcool ma mi sono accorto che galleggiano."
Anonimo alcolista
Iscriviti a:
Post (Atom)