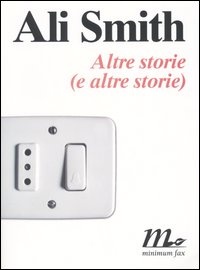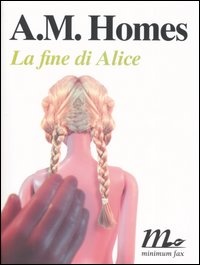venerdì 29 maggio 2009
giovedì 28 maggio 2009
Ieri
I pulman dei tifosi spagnoli incolonnati ci lasciano passare senza fretta. La mattina attorno a Firenze è tesa nelle ore che si allungano verso sera, turchese di quel turchese di cui il cielo si addobba con il sole ancora timido all'orizzonte. Poi nella sera, lontano da qui, le luci si accenderanno luminose, quando il sole proprio non ci sarà più, il buio nel resto e la luce dentro un buco, più grande di quanto non possa sembrare visto dall'alto. Voci distanti, voci contrastanti; urla e grida, cori fuori sincrono formeranno un nuovo timbro vocale, mille e seicento e passa corde vocali vibrano utilizzando la cassa di risonanza scheletrica, tubi di acciaio annidiati in forme giometriche, ellissi a rispecchiare l'orbita dei pianeti. Ma ora, qui, adesso, in questo preciso momento, la proiezione di ciò che avverrà stasera, o anche tra qualche ora, è solo l'ombra di un fantasma che scivola liquido appena sopra i miei occhi; o galleggia sui miei bulbi acquosi, mostrando opachi aloni dalle figure appena accennate.
Arrivo al casello, e l'immissione nel turbine confuso di due flussi diversi opposti che confluiscono l'uno sull'altro, è pericoloso come ogni volta: rischio di annegare, di picchiare, di scontrarmi contro onde di potenza maggiore, le lamiere colorate che si divertono a strombazzare con suoni riconoscibili da parte a parte. Mi metto in coda: sano, salvo. Di nuovo. I finestrini sono ancora chiusi, sigillando sottovuoto la macchina, atmosfera a gravità uno. L'aria condizionata, sputata fuori dai condotti appena sotto il parabrezza, diffonde nell'abitacolo un senso di falsa freschezza, irreale quanto il caldo fuori, in agguato appena premo sul pulsante per accedere all'esterno: zzzzzzzzzzppppppppppppp.
"Il solito, grazie." Quanti casellanti, a ruota, formeranno i turni di una postazione?
"A posto."
"La ricevuta, grazie."
"Si, la ricevuta: eccola."
Arrivo al casello, e l'immissione nel turbine confuso di due flussi diversi opposti che confluiscono l'uno sull'altro, è pericoloso come ogni volta: rischio di annegare, di picchiare, di scontrarmi contro onde di potenza maggiore, le lamiere colorate che si divertono a strombazzare con suoni riconoscibili da parte a parte. Mi metto in coda: sano, salvo. Di nuovo. I finestrini sono ancora chiusi, sigillando sottovuoto la macchina, atmosfera a gravità uno. L'aria condizionata, sputata fuori dai condotti appena sotto il parabrezza, diffonde nell'abitacolo un senso di falsa freschezza, irreale quanto il caldo fuori, in agguato appena premo sul pulsante per accedere all'esterno: zzzzzzzzzzppppppppppppp.
"Il solito, grazie." Quanti casellanti, a ruota, formeranno i turni di una postazione?
"A posto."
"La ricevuta, grazie."
"Si, la ricevuta: eccola."
mercoledì 27 maggio 2009
In viaggio
Mi sveglio con il sole non troppo invadente che passa dalla finestra. Non sento caldo, ma una fascia di luce mi attraversa la guancia andando a tuffarsi proprio nel mio occhio. Io lo apro appena, giusto uno spiffero per sbirciare fuori. Non sono a casa mia, non so dove mi trovi, ma non sono a casa. Il letto sul quale ho dormito non è il mio, è straniero, un po' come mi sento io in questo momento.
Mi alzo con fatica, stanco, ancora stanco. Ogni giuntura - gomiti, ginocchia, collo, oh dio non parliamo del collo - si muove arrugginita, scricchiolando ad ogni piccolo cambio di inclinazione. Mettersi a sedere sul materasso, sul materasso non mio e di chissà chi, è un'impresa titanica: trattenere il fiato per cinquanta minuti forse sarebbe più facile; camminare sui carboni ardenti, a piedi nudi: di più.
Mi guardo un po' in giro, ancora immerso per buona parte nel sonno, virtualmente con il cuscino ancora appiccicato alla faccia, e non riconosco niente. Le pareti bianche con foto appese in cornici di vetro mi sono del tutto nuove; così come la porta, di un marrone chiaro - che legno sarà? - o il comodino in stile antico. E' un mondo nuovo, tutto da scoprire.
I ricordi mi tornano a galla un po' come meduse, prima una poi l'altra. Nel mare chiaro sento qualcuno che suona alla mia porta. Vengo ad aprire e tu non mi dai neppure il tempo di salutarti. Ti fiondi in casa lasciandomi sulla soglia, guardo fuori per vedere se ti dovessi portare dietro una scia, come una cometa, o se stessi scappando da qualcuno, chi ti inseguiva. Ma te inizi a parlare non appena fatti due passi: sei eccitata, non riesci a trattenerti. Dobbiamo andare, dici, sbrigati, muoviti, dici. Chiudo la porta ancora un po' perplesso. Dove? Non fare domande stupide, rispondi con urgenza. Dobbiamo andare, non perdere tempo.
Mi alzo dal letto e muovo i primi indecisi passi della giornata. I piedi nudi sul pavimento freddo. Mi affaccio dalla finestra e vedo il mare. Sono in una collina e dalla finestra vedo una piccola strada che scende fino ad un punto che non riesco a vedere; poi il mare. Un'altra medusa affiora dal fondo scuro dell'acqua.
Dammi il tempo di preparare qualcosa, dico io. No, non abbiamo tempo, non c'è tempo, dici te. Vestiti, fai in fretta. Ma almeno delle mutande, dei calzini, qualcosa di ricambio. Compreremo tutto in corsa, dici mentre in camera afferri un po' di roba e la impacchetti dentro la mia borsa a tracolla. Io infilo saltellando una gamba dentro i jeans, rischio di cadere mentre infilo anche l'altra. Poi una maglia a maniche corte, verde, e sopra una a maniche lunghe, due tonalità diverse di grigio su strisce orrizzontali. Sono vestito, pronto, infilo le scarpe ai piedi e vengo da te. Ti afferro allora un polso con una mano, a fermarti, tranquillizzarti: ci sono. Prendo la tracolla militare, ci metto dentro quella specie di parallelepipedo informe che io arrossendo chiamo diario, e che tu invece chiami l'oggetto-strano-e-di-vita-propria-su-cui-scrivi; una manciata di penne, di vario colore, di cui spero almeno una funzioni; l'opera galleggiante, con il segnalibro nascosto tra le pagine, il lapis giallo e nero incastrato tra la copertina e la pagina, anche se so già si perderà nei meandri della borsa non appena mollo la presa; l'ipod bianco con gli auricolari neri attorcigliati attorno, fino a quando anche quelli mi abbandoneranno o da un lato inizierà ad uscire fuori un fastidioso fruscio; infine la polaroid, un quasi cubo nero, compatto, pronta a sputare le foto già incorniciate di bianco se solo avesse dentro delle pellicole da impressionare. Già, dici sorridendo quando la vedi scomparire o sbirciare fuori dalla borsa.
Siamo in Portogallo, mi dico mentre sono affacciato alla finestra e non guardo il mare ma guardo l'oceano e non ne vedo la fine, da quanto si perde e si distende fino e ben oltre l'orizzonte. Le meduse cominciano allora a nuotare un po' ovunque nei miei ricordi, tornano a galla e la mia memoria diventa piena zeppa di queste gelatine acide. Siamo partiti da casa mia, arruffando un po' di roba ognuno nella propria borsa. La tua macchina ci aspettava parcheggiata in strada: i finestrini aperti su una giornata di sole e caldo. Hai cercato di guidare con gli occhiali da sole, ma io te li toglievo e li appoggiavo sul cruscotto; poi te li riprendevi e li inforcavi sul naso; di nuovo io a toglierteli e sul cruscotto; te, di nuovo, con le lenti scure, una maschera, in faccia: un gioco di cinque o sei passaggi, fino a quando non ho preso gli occhiali e li ho lanciati nei sedili posteriori, a far compagnia alle nostre borse e a quei brevi chilometri che via via ci mettevamo alle spalle. Abbiamo riso, con la musica che suonava dallo stereo e l'aria a soffiare da fuori, arruffando i capelli. Sembri un'auto con le pinne, quando il vento ti pettina in questo modo i capelli laterali, sulle orecchie, dici guardando la strada poi me e di nuovo la strada. Guidi con la mano sinistra fuori dal finestrino, e l'aria fuori a cento all’ora quando passa tra le dita sembra quasi un’altra mano che si intreccia con la tua. Ci diamo il cambio più o meno dopo tre ore di viaggio, quando ci fermiamo ad un autogrill e mangiamo qualche boccone. Tappa al bagno, ricordi te anticipandomi, la prossima fermata sarà lontana. Poi di nuovo in strada, con il tramonto a scendere oltre il parabrezza, te che ti accucci come un cane sul sedile passeggero, i paesaggi notturni illuminati dai lampioni, dalle altre rare macchine che ci superano o superiamo. Abbiamo sconfinato l'Italia, entrati in Francia in punta di piedi; scalato i Pirenei, i pneumatici finiti, il battistrada consumato, l'odore bruciato dei freni in una discesa in folle. Lo abbiamo vissuto, o me lo sto solo immaginando?
Guardo al di là dei vetri della finestra. Non saprei dire dove. La camera sembra quella di un bed and breakfast, ma potrebbe essere quella della casa di alcuni tuoi amici di cui ignoro l'esistenza; e quello fuori non l'oceano ma il Mediterraneo, Genova.
Ovunque siamo, tu, dove sei?
Ai piedi del letto c'è la tua borsa aperta, alcuni pochi vestiti tirati fuori e ricacciati subito dentro; la mia tracolla slabbrata a vomitare a terra il suo interno. Sul cassettone la polaroid e un foglio, la tua calligrafia. Sono andata a comprare le pellicole, tu intanto scrivi quello che è successo, i posti dove siamo passati, i discorsi di cui abbiamo parlato: voglio leggere tutto, rileggere tutto, per non dimenticare niente.
Mi alzo con fatica, stanco, ancora stanco. Ogni giuntura - gomiti, ginocchia, collo, oh dio non parliamo del collo - si muove arrugginita, scricchiolando ad ogni piccolo cambio di inclinazione. Mettersi a sedere sul materasso, sul materasso non mio e di chissà chi, è un'impresa titanica: trattenere il fiato per cinquanta minuti forse sarebbe più facile; camminare sui carboni ardenti, a piedi nudi: di più.
Mi guardo un po' in giro, ancora immerso per buona parte nel sonno, virtualmente con il cuscino ancora appiccicato alla faccia, e non riconosco niente. Le pareti bianche con foto appese in cornici di vetro mi sono del tutto nuove; così come la porta, di un marrone chiaro - che legno sarà? - o il comodino in stile antico. E' un mondo nuovo, tutto da scoprire.
I ricordi mi tornano a galla un po' come meduse, prima una poi l'altra. Nel mare chiaro sento qualcuno che suona alla mia porta. Vengo ad aprire e tu non mi dai neppure il tempo di salutarti. Ti fiondi in casa lasciandomi sulla soglia, guardo fuori per vedere se ti dovessi portare dietro una scia, come una cometa, o se stessi scappando da qualcuno, chi ti inseguiva. Ma te inizi a parlare non appena fatti due passi: sei eccitata, non riesci a trattenerti. Dobbiamo andare, dici, sbrigati, muoviti, dici. Chiudo la porta ancora un po' perplesso. Dove? Non fare domande stupide, rispondi con urgenza. Dobbiamo andare, non perdere tempo.
Mi alzo dal letto e muovo i primi indecisi passi della giornata. I piedi nudi sul pavimento freddo. Mi affaccio dalla finestra e vedo il mare. Sono in una collina e dalla finestra vedo una piccola strada che scende fino ad un punto che non riesco a vedere; poi il mare. Un'altra medusa affiora dal fondo scuro dell'acqua.
Dammi il tempo di preparare qualcosa, dico io. No, non abbiamo tempo, non c'è tempo, dici te. Vestiti, fai in fretta. Ma almeno delle mutande, dei calzini, qualcosa di ricambio. Compreremo tutto in corsa, dici mentre in camera afferri un po' di roba e la impacchetti dentro la mia borsa a tracolla. Io infilo saltellando una gamba dentro i jeans, rischio di cadere mentre infilo anche l'altra. Poi una maglia a maniche corte, verde, e sopra una a maniche lunghe, due tonalità diverse di grigio su strisce orrizzontali. Sono vestito, pronto, infilo le scarpe ai piedi e vengo da te. Ti afferro allora un polso con una mano, a fermarti, tranquillizzarti: ci sono. Prendo la tracolla militare, ci metto dentro quella specie di parallelepipedo informe che io arrossendo chiamo diario, e che tu invece chiami l'oggetto-strano-e-di-vita-propria-su-cui-scrivi; una manciata di penne, di vario colore, di cui spero almeno una funzioni; l'opera galleggiante, con il segnalibro nascosto tra le pagine, il lapis giallo e nero incastrato tra la copertina e la pagina, anche se so già si perderà nei meandri della borsa non appena mollo la presa; l'ipod bianco con gli auricolari neri attorcigliati attorno, fino a quando anche quelli mi abbandoneranno o da un lato inizierà ad uscire fuori un fastidioso fruscio; infine la polaroid, un quasi cubo nero, compatto, pronta a sputare le foto già incorniciate di bianco se solo avesse dentro delle pellicole da impressionare. Già, dici sorridendo quando la vedi scomparire o sbirciare fuori dalla borsa.
Siamo in Portogallo, mi dico mentre sono affacciato alla finestra e non guardo il mare ma guardo l'oceano e non ne vedo la fine, da quanto si perde e si distende fino e ben oltre l'orizzonte. Le meduse cominciano allora a nuotare un po' ovunque nei miei ricordi, tornano a galla e la mia memoria diventa piena zeppa di queste gelatine acide. Siamo partiti da casa mia, arruffando un po' di roba ognuno nella propria borsa. La tua macchina ci aspettava parcheggiata in strada: i finestrini aperti su una giornata di sole e caldo. Hai cercato di guidare con gli occhiali da sole, ma io te li toglievo e li appoggiavo sul cruscotto; poi te li riprendevi e li inforcavi sul naso; di nuovo io a toglierteli e sul cruscotto; te, di nuovo, con le lenti scure, una maschera, in faccia: un gioco di cinque o sei passaggi, fino a quando non ho preso gli occhiali e li ho lanciati nei sedili posteriori, a far compagnia alle nostre borse e a quei brevi chilometri che via via ci mettevamo alle spalle. Abbiamo riso, con la musica che suonava dallo stereo e l'aria a soffiare da fuori, arruffando i capelli. Sembri un'auto con le pinne, quando il vento ti pettina in questo modo i capelli laterali, sulle orecchie, dici guardando la strada poi me e di nuovo la strada. Guidi con la mano sinistra fuori dal finestrino, e l'aria fuori a cento all’ora quando passa tra le dita sembra quasi un’altra mano che si intreccia con la tua. Ci diamo il cambio più o meno dopo tre ore di viaggio, quando ci fermiamo ad un autogrill e mangiamo qualche boccone. Tappa al bagno, ricordi te anticipandomi, la prossima fermata sarà lontana. Poi di nuovo in strada, con il tramonto a scendere oltre il parabrezza, te che ti accucci come un cane sul sedile passeggero, i paesaggi notturni illuminati dai lampioni, dalle altre rare macchine che ci superano o superiamo. Abbiamo sconfinato l'Italia, entrati in Francia in punta di piedi; scalato i Pirenei, i pneumatici finiti, il battistrada consumato, l'odore bruciato dei freni in una discesa in folle. Lo abbiamo vissuto, o me lo sto solo immaginando?
Guardo al di là dei vetri della finestra. Non saprei dire dove. La camera sembra quella di un bed and breakfast, ma potrebbe essere quella della casa di alcuni tuoi amici di cui ignoro l'esistenza; e quello fuori non l'oceano ma il Mediterraneo, Genova.
Ovunque siamo, tu, dove sei?
Ai piedi del letto c'è la tua borsa aperta, alcuni pochi vestiti tirati fuori e ricacciati subito dentro; la mia tracolla slabbrata a vomitare a terra il suo interno. Sul cassettone la polaroid e un foglio, la tua calligrafia. Sono andata a comprare le pellicole, tu intanto scrivi quello che è successo, i posti dove siamo passati, i discorsi di cui abbiamo parlato: voglio leggere tutto, rileggere tutto, per non dimenticare niente.
martedì 26 maggio 2009
Non perchè sono in ritardo, ma avevano chiuso le porte
"Cosa facciamo?"
"Festeggiamo."
"E come?"
"Stasera andremo a mangiare sulla luna."
"Festeggiamo."
"E come?"
"Stasera andremo a mangiare sulla luna."
lunedì 25 maggio 2009
L'unica volta che hai avuto freddo
L'unica volta che hai avuto freddo è stata quella sera che ti portai alla rocca. Indossavi solo una sottile maglia bianca, con delle scritte evidenziate alcune si altre no, con sopra il tuo solito giacchetto marrone, ed anche se ti ci abbracciavi dentro, cercavi di coprirti il più possibile senza però aggancaire la cerniera e chiuderla del tutto fin sotto il mento, era proprio fisicamente impossibile che tu potessi stare al caldo. La primavera non aveva ancora deciso se fermarsi oppure no: di giorno il sole scaldava facendoci spogliare o vestire il meno possibile, e la notte al buio il freddo diventava pungente cogliendoti di sorpresa. Quella sera non dovevi neppure uscire, avevi deciso di rimanere a casa a guardarti un film, o uno di quei documentari storici sugli egizi, gli atzechi o i babilonesi. Quando arrivai a casa tua e ti convinsi a fare un giro, più per parlare che non per altro, afferrasti le prime cose che avevi lasciato sopra il letto e partimmo poi con la mia macchina.
Non ricordo di preciso come ci ritrovammo alla rocca. Forse tra una curva a destra, un semaforo rosso e alcuni nuovi sensi unici, c'eravamo così vicini che mi venne naturale andarci. Tu non c'eri mai stato e quando mi fermai al parcheggio poco dopo la piazza dicesti che era un bel posto: buio, illuminato quel tanto da non essere eccessivo, e con un bel prato davanti. In realtà la rocca non è altro due antiche torri rimaste più o meno miracolosamente in piedi, unite tra loro da un muro di mattoni bianchi che delimitano una specie di cortile interno. Detta così può sembrare chissà cosa, ma in realtà è tutto molto più decadente e abbattuto da renderlo non certo molto speciale. L'unica cosa di meraviglioso, quello si, è il paesaggio che dall'alto si può guardare illuminarsi delle luci della vallata, le macchine come formiche elettriche e fluorescenti che passano giù in basso sull'autostrada, mentre attorno la notte avvolge le case, nascondendole del tutto o solo in parte.
Scendemmo di macchina continuando a parlare, con te che ti sfogavi di quella ragazza con cui uscivi. Lasciavi andare avanti le parole, su parole e parole, e mentre dicevi questo o dicevi quello capivo sempre di più che avevi semplicemente bisogno di parlarne, che forse non avevi le idee chiare neppure te e dire le cose a voce, magari anche a nessuno o avendo l'impressione di dirle a qualcuno anche se poi le dicevi soprattutto a te stesso, le capivi meglio e te ne facevi un'idea, un'opinione. Oppure avevi voglia di stare con lei e non con me, e parlando di lei, di come stava l'ultima sera che l'hai sentita, di quanto tempo era passato dalla volta che le avevi telefonato e ti aveva risposto, dei vostri discorsi e dei vostri sguardi, dei significati che tu davi ai suoi occhi e ai significati che i tuoi occhi acquisivano ogni volta che guardavano lei; forse parlando di tutto questo, impregnando ogni frase di questa ragazza, magari non così speciale ma pur sempre speciale, era un po' come se ci fossi insieme a lei, ne sentivi certo meno la mancanza.
Così, quando arrivati sotto la torre ti ho detto di salire, di andare a guardare un po' il panorama dall'alto, tu hai detto ok, andiamo, per poi fermarti a metà percorso, dicendo di voler tornare indietro. Avevi paura: non sei mai stato uno abituato alle grandi, o anche medie, altezze. Abbiamo ridisceso le scale in silenzio, senza quasi neppure respirare. Poi, seduta su una panchina nascosta dalla strada, abbiamo visto una coppia di ragazza legati tra di loro. Non si sono accorti di noi, hanno continuato a baciarsi come se niente fosse, come se noi non esistessimo affatto. Allora hai ripreso a parlare: portami a casa, hai detto. Ho voglia di vedere un documentario. Su una antica civiltà? Ti ho chiesto. No, sull'impollinazione dei fiori, mi hai risposto.
Non ricordo di preciso come ci ritrovammo alla rocca. Forse tra una curva a destra, un semaforo rosso e alcuni nuovi sensi unici, c'eravamo così vicini che mi venne naturale andarci. Tu non c'eri mai stato e quando mi fermai al parcheggio poco dopo la piazza dicesti che era un bel posto: buio, illuminato quel tanto da non essere eccessivo, e con un bel prato davanti. In realtà la rocca non è altro due antiche torri rimaste più o meno miracolosamente in piedi, unite tra loro da un muro di mattoni bianchi che delimitano una specie di cortile interno. Detta così può sembrare chissà cosa, ma in realtà è tutto molto più decadente e abbattuto da renderlo non certo molto speciale. L'unica cosa di meraviglioso, quello si, è il paesaggio che dall'alto si può guardare illuminarsi delle luci della vallata, le macchine come formiche elettriche e fluorescenti che passano giù in basso sull'autostrada, mentre attorno la notte avvolge le case, nascondendole del tutto o solo in parte.
Scendemmo di macchina continuando a parlare, con te che ti sfogavi di quella ragazza con cui uscivi. Lasciavi andare avanti le parole, su parole e parole, e mentre dicevi questo o dicevi quello capivo sempre di più che avevi semplicemente bisogno di parlarne, che forse non avevi le idee chiare neppure te e dire le cose a voce, magari anche a nessuno o avendo l'impressione di dirle a qualcuno anche se poi le dicevi soprattutto a te stesso, le capivi meglio e te ne facevi un'idea, un'opinione. Oppure avevi voglia di stare con lei e non con me, e parlando di lei, di come stava l'ultima sera che l'hai sentita, di quanto tempo era passato dalla volta che le avevi telefonato e ti aveva risposto, dei vostri discorsi e dei vostri sguardi, dei significati che tu davi ai suoi occhi e ai significati che i tuoi occhi acquisivano ogni volta che guardavano lei; forse parlando di tutto questo, impregnando ogni frase di questa ragazza, magari non così speciale ma pur sempre speciale, era un po' come se ci fossi insieme a lei, ne sentivi certo meno la mancanza.
Così, quando arrivati sotto la torre ti ho detto di salire, di andare a guardare un po' il panorama dall'alto, tu hai detto ok, andiamo, per poi fermarti a metà percorso, dicendo di voler tornare indietro. Avevi paura: non sei mai stato uno abituato alle grandi, o anche medie, altezze. Abbiamo ridisceso le scale in silenzio, senza quasi neppure respirare. Poi, seduta su una panchina nascosta dalla strada, abbiamo visto una coppia di ragazza legati tra di loro. Non si sono accorti di noi, hanno continuato a baciarsi come se niente fosse, come se noi non esistessimo affatto. Allora hai ripreso a parlare: portami a casa, hai detto. Ho voglia di vedere un documentario. Su una antica civiltà? Ti ho chiesto. No, sull'impollinazione dei fiori, mi hai risposto.
venerdì 22 maggio 2009
Skin Thin
Now that you've grown up
You can finally learn to be a child
We made it to the end of the world
But we'll neverv make it out a lie
Skin thin
I breathe out, you breathe in
But the day seems so long
Skin thin
Blood again
It's all I can do to hold on
We're just skin thin
Always knew if we didn't have each other
We'd have nothing at all
But you were always brave enough
To live like you can never fall
Skin thin
I breathe out, you breathe in
But the day seems so long
Skin thin
Blood again
It's all I can do to hold on
Now that we've grown up
You can finally learn to be a child
Good friends behind me
But ghosts up ahead for miles and miles
Skin thin
I breathe out, you breathe in
But the days they seem so long
Skin thin
Blood again
It's all I can do to hold on
Life's just skin thin
You can finally learn to be a child
We made it to the end of the world
But we'll neverv make it out a lie
Skin thin
I breathe out, you breathe in
But the day seems so long
Skin thin
Blood again
It's all I can do to hold on
We're just skin thin
Always knew if we didn't have each other
We'd have nothing at all
But you were always brave enough
To live like you can never fall
Skin thin
I breathe out, you breathe in
But the day seems so long
Skin thin
Blood again
It's all I can do to hold on
Now that we've grown up
You can finally learn to be a child
Good friends behind me
But ghosts up ahead for miles and miles
Skin thin
I breathe out, you breathe in
But the days they seem so long
Skin thin
Blood again
It's all I can do to hold on
Life's just skin thin
Performed by Ben Harper
giovedì 21 maggio 2009
Nevrosi di Maggio
Come uscire dalla provincia? Similitudini, o tentativi di, tra Pistoia e Pisa, le due Pi toscane. Da una parte il pubblico, teoricamente pistoiese; dall'altra tre personaggi, teoricamente pisani. Gipi, che odia Pisa ma di cui conserva però delle immagini eterne, belle, romantiche; Appino, cantante degli Zen Circus, che ha "scoperto" Pisa giusto quando ne è uscito, forse guardandola da fuori; Giovanni Guerrieri, della compagnia I Sacchi di Sabbia, in realtà di Piombino. Ne esce fuori di tutto: musica, parole e pensieri, con Gipi che ne fa da padrone. Il cuore è lui, anche se un po' schivo, se non ha dormito, ne esce fuori sempre con la solita leggera profondità, riuscendo a dire cose sincere e vere con una facilità impressionante, facendo ridere nei momenti opportuni, sdrammatizzando e usando similitudini non banali: voglio bene a Pisa proprio come si può voler bene ad una mamma che ti dice che lei è una troia; le vuoi bene, perchè in fondo è sempre tua madre, dentro hai qualcosa che ti spinge a volerle bene, lo senti nel profondo, ma è anche vero che è pur sempre una troia. Lui è caduto nel tombino, così a caso, proprio come è finito a fare quello che sta facendo - che lavoro fai? Fumettista. E che personaggio disegni? No, non disegno nessun personaggio. Allora disegni topi o cose simili. No, non è proprio questo (qui in Italia per spiegare cosa faccio ci metto sempre una mezz'oretta) - oppure è il contrario? Si, il contrario, il paragone va letto al contrario. Lui, a lui che neppure gli piaccioni i fumetti, e ora si trova a disegnarli, anche se io qui avrei voluto alzare la mano e dire: no, secondo me non disegni fumetti, con tutto il rispetto per chi disegna i fumetti ovviamente, ma tu secondo me racconti delle storie, che poi queste storie siano raccontate anche con dei disegni, beh, questa è un'altra storia; ma te racconti delle storie, come facciamo un po' tutti, chi volontariamente e chi inconsciamente, e per farlo utilizzi i tuoi strumenti. I tuoi strumenti sono i disegni, ma nei tuoi libri i disegni sono una parte, ci sono anche molte parole, magari non scritte a macchina, ma sempre e comunque parole, con le quali accompagni i disegni e racconti delle storie. Questo avrei voluto dire dopo aver riabbassato la mano, ma ovviamente non l'ho detto e non ho alzato neppure la mano e non ho fatto tremare la voce o balbettare parole a volume basso. Così come non ho detto: scrivi le cose per poterle capire meglio. Non l'ho detto, ma lo dico qui, ora. Magari non ha lo stesso senso, non hanno lo stesso potere, ma le dico qui. Un giorno ho aperto la finestra e un vento, un vento forte mi ha investito, e allo stesso tempo mi ha trascinato via. Un giorno ho scoperto Andrea Pazienza e questa finestra si è aperta. Siamo finiti a parlare di Parigi, confrontandola con Roma, e i manifesti dei sindaci: trova le differenze. Eravamo partiti da Pistoia, da Pisa, e siamo finiti a Parigi. Abbiamo scollinato le Alpi, siamo emigrati.
mercoledì 20 maggio 2009
Altre storie (e altre storie)
La mia infanzia non c'entra niente. Quando cerco di immaginarmela, questa entità chiamata infanzia, mi ritorna su, nutriente e benevola, come un bicchiere di latte, e io so ch equello è stato un periodo di stagioni senza sforzo
Pauline che camminava, bionda e carina, un pomeriggio assolato di giugno e la gente che si girava a guardarla. Bionda e con due occhioni grandi così sembrava uscita dalla vecchia réclame di una lacca per capelli, con la fronte un po' aggrottata, in modo grazioso, come se si stesse concentrando; magrissima e per questo ancora più bella; e mentre camminava per strada i capelli emanavano bagliori e lei infondeva un piacevole fremito nei cuori dei passanti.
Gli amici sono sempre carini, anche quando non lo sono.
Quelle parole mi hanno toccata nel profondo. Ho cercato di pensare a cose altrettanto appassionate e poetiche da dirti per telefono, mentre eri al lavoro, cose talmente intime che nel momento in cui te le avessi sussurrate all'orecchio attraverso il ricevitore, lo spazio fra te e il lavoro ch eavevi per le mani, fra te e le altre voci che c'erano sempre attorno a te, fra te e tutta l'altra gente che era sempre nella tua stanza, si sarebbe condensato separandoti da tutto e da tutti come una perfetta cortina di vetro.
Gli anni passano e loro sono sempre diversi e questo li rende tutti uguali
Tre anni fa è talmente tanto tempo che sembrano tre vite fa.
Una risata può essere fragorosa e soffocata allo stesso tempo? Le loro erano così, le loro risate, squillanti e sommesse, sfrenate e trattenute; altrimenti non sarebbero state appropriate, in qualche modo.
Mi sono chiesto cosa le fosse successo. E cosa sarebbe successo se qualcuno l'avesse presa e abbracciata forte.
Sei quasi del tutto spogliata, i tuoi vestiti sono ammucchiati per terra. Le parole mi affiorano alla bocca, mi arrivano quasi sulla punta della lingua, quanto sei graziosa, distesa così
Quell'estate il tempo era proprio come uno si immagina il bel tempo.
All'epoca era ormai un anno che eravamo divorate dall'amore e dai sensi di colpa, un anno di goffaggine ed estasi allo stato puro
Ancora vedo me e lei, le teste vicine, gli occhi, le bocche, assorte, graziose, serie come ermellini, mentre esprimevamo pensieri innocenti e pericolosi come, per esempio, che il suicidio doveva essere una cosa bella, o perlomeno una cosa molto romantica, qualcosa che ogni vero romantico farebbe, perché è ovvio che la gente che si suicida prova dei sentimenti molto intensi.
La mano che reggeva i lrossetto indugiò per un istante davanti alla bocca, e il volto assunse un'espressione pensosa.
Raccontami una storia, ti ho detto.
Ok, hai risposto tu. Che tipo di storia?
Una storia d'amore, ho detto io
Com'è possibile che due persone si vogliano così tanto bene senza rendersene conto?
una forma rudimentale d'amore
Ho sentito la tua voce che veniva da un luogo vicino al sonno.
Pauline che camminava, bionda e carina, un pomeriggio assolato di giugno e la gente che si girava a guardarla. Bionda e con due occhioni grandi così sembrava uscita dalla vecchia réclame di una lacca per capelli, con la fronte un po' aggrottata, in modo grazioso, come se si stesse concentrando; magrissima e per questo ancora più bella; e mentre camminava per strada i capelli emanavano bagliori e lei infondeva un piacevole fremito nei cuori dei passanti.
Gli amici sono sempre carini, anche quando non lo sono.
Quelle parole mi hanno toccata nel profondo. Ho cercato di pensare a cose altrettanto appassionate e poetiche da dirti per telefono, mentre eri al lavoro, cose talmente intime che nel momento in cui te le avessi sussurrate all'orecchio attraverso il ricevitore, lo spazio fra te e il lavoro ch eavevi per le mani, fra te e le altre voci che c'erano sempre attorno a te, fra te e tutta l'altra gente che era sempre nella tua stanza, si sarebbe condensato separandoti da tutto e da tutti come una perfetta cortina di vetro.
Gli anni passano e loro sono sempre diversi e questo li rende tutti uguali
Tre anni fa è talmente tanto tempo che sembrano tre vite fa.
Una risata può essere fragorosa e soffocata allo stesso tempo? Le loro erano così, le loro risate, squillanti e sommesse, sfrenate e trattenute; altrimenti non sarebbero state appropriate, in qualche modo.
Mi sono chiesto cosa le fosse successo. E cosa sarebbe successo se qualcuno l'avesse presa e abbracciata forte.
Sei quasi del tutto spogliata, i tuoi vestiti sono ammucchiati per terra. Le parole mi affiorano alla bocca, mi arrivano quasi sulla punta della lingua, quanto sei graziosa, distesa così
Quell'estate il tempo era proprio come uno si immagina il bel tempo.
All'epoca era ormai un anno che eravamo divorate dall'amore e dai sensi di colpa, un anno di goffaggine ed estasi allo stato puro
Ancora vedo me e lei, le teste vicine, gli occhi, le bocche, assorte, graziose, serie come ermellini, mentre esprimevamo pensieri innocenti e pericolosi come, per esempio, che il suicidio doveva essere una cosa bella, o perlomeno una cosa molto romantica, qualcosa che ogni vero romantico farebbe, perché è ovvio che la gente che si suicida prova dei sentimenti molto intensi.
La mano che reggeva i lrossetto indugiò per un istante davanti alla bocca, e il volto assunse un'espressione pensosa.
Raccontami una storia, ti ho detto.
Ok, hai risposto tu. Che tipo di storia?
Una storia d'amore, ho detto io
Com'è possibile che due persone si vogliano così tanto bene senza rendersene conto?
una forma rudimentale d'amore
Ho sentito la tua voce che veniva da un luogo vicino al sonno.
Ali Smith
martedì 19 maggio 2009
La città morta
Viviamo in una città morta, dicevi. Le nostre rampe di lancio emozionali sono dipinte di bianco e giallo, su sfondo nero, catrame ammassato su scomodi dossi, a distruggere le sospensioni, le ibernazioni momentanee dei nostri umori. Viviamo in una città morta, dicevi. Il silenzio sibila così tanto da riempire l'aria, gareggia con i nostri discorsi socchiusi in labbra serrate, strette così tanto da unire i denti e saldare la bocca: muguliamo per farci capire, linguaggio muto e segreto, un linguaggio cifrato che non ha bisogno di traduzioni, basta guardare la linea storgersi sotto il naso. Viviamo in una città morta, dicevi. Il cielo di una notte si perdeva di tempo, maturava in luccichii lontani anni luce, tra galassie disperse nelle nostre fantasie; e le stelle cadenti che ci cadevano sempre addosso, a bagnarci di luce quando invece volevamo soltanto il buio. Viviamo in una città morta, dicevi. Ci basta una candela per bruciare via l'opaca staticità dei nostri eventi, muovendoci piano in questo prato soffice e pungente; la cera colante tra le nostre gambe umide, ferme e aperte, speranze digonali a tappare l'ebbra lucidità. Viviamo in una città morta, dicevi. E' servito a poco scavare la terra in tunnel circolari, trovare gli spazi per nascondere e velocizzare il passaggio di stato, tra gassoso a solido, come la pioggia acida della nostra infanzia, quella pioggia che ci bruciava i vestiti addosso, lasciandoci ustioni dolenti e rosse, accaldate a strati sulle braccia: con leggiadra svogliatezza perdevamo la pelle di minuto in minuti, ci andava via come panni bagnati al sole, e le ossa gialle, dal midollo sempre più poroso, si muovevano arruffando l'aria intorno. Viviamo in una città morta, dicevi. I barbari ci attendono al confine, stanno per entrare dentro il nostro territorio per razziare e ammazzare, uccidere i bambini, stuprare le donne, sacrificare le vergini, e trasformare i nostri uomini in loro eunuchi; i barbari potrebbero portare nuova linfa, sottrarre il terreno sotto i nostri piedi e farci finalmente volare, cadere nel vuoto fino ad arrivare nel magma più fuso, rovente di terremoti e distorsioni terresti. Viviamo in una città morta, diveci, fatta di varianti che non riusciamo a metabilizzare, a fare nostre, e quando finalmente riusciamo a capirle sono già di nuovo cambiate. Viviamo in una città morta, dicevi, morta, morta, morta morta morta mortamortamortamortamorta. Ci sono solo strade deserte e accaldate dal sole che rimbalza sull'asfalto, i marciapiedi vuoti e le sirene delle ambulanze che non suonano neppure più. L'ospedale non sappiamo più a cosa possa servire, i semafori lampeggiano in eterno l'arancione sociale, e il fatto che siamo sull'orlo del fallimento forse è un sintomo che non dovremmo ignorare. Viviamo in una città morta, e l'unica cosa di cui avremmo davvero bisogno sarebbe una rivoluzione, una rivoluzione all'irrazionale immobilità che ci circonda, e ci ferma, immobilizza. Avvertimi, dicevi, quando scoppierà questa benedetta rivoluzione.
lunedì 18 maggio 2009
Gone Baby Gone

La realtà finisce in pellicola, la pellicola tristemente diventa realtà. Il tutto mescolato in una perfetta sequenza di eventi, legati fra loro da fili di relazioni sociali, che sfociano poi in una triste e sofferta scelta. Film che fa discutere, che può aprire dibattiti e dividere. Film dove personaggi veri, crudamente e crudelmente veri, camminano e si muovono su uno scenario dipinto di nero, tinte fosce, molte ombre. Casey Affleck nella primissima parte del film è lui e le sue scarpe da ginnastica bianche, poi fa da connettore in una città dove il social network è ancora umano e minaccioso. Amy Ryan è tossica ed anche se il suo personaggio la sniffa, la coca, è tossica fino al midollo, quasi un ago avesse passato la vena e si fosse conficcato nell'osso nel profondo. Ed Harris interpreta Viggo Mortensen invecchiato, da vecchio, e dio mio quanto è bravo. Morgan Freeman invece è troppo breve per dire cosa è: recita con la sagoma, vista da lontano.
Il film tiene, dall'inizio alla fine, grazie alla storia solida, sicura, a tratti granitica, e grazie anche ad attori di supporto a fare il loro sporco lavoro.
Giudizio: Dvd
- Cinema ==> Da vedere assolutamente, correre al cinema
- Dvd ==> Da vedere, ma si può aspettare il noleggio
- Tv ==> Niente di esaltante, se proprio si deve vedere aspettare il passaggio in tv
- Passeggiata ==> Perdibilissimo. Andate pure a fare una passeggiata.. anche sotto la pioggia
venerdì 15 maggio 2009
Impressioni di settembre
Quante gocce di rugiada intorno a me
cerco il sole, ma non c'è.
Dorme ancora la campagna, forse no,
è sveglia, mi guarda, non so.
Già l'odore della terra, odor di grano
sale adagio verso me,
e la vita nel mio petto batte piano,
respiro la nebbia, penso a te.
Quanto verde tutto intorno, e ancor più in là
sembra quasi un mare d'erba,
e leggero il mio pensiero vola e va
ho quasi paura che si perda...
Un cavallo tende il collo verso il prato
resta fermo come me.
Io faccio un passo, lui mi vede, è già fuggito
respiro la nebbia, penso a te.
No, cosa sono adesso non lo so,
sono solo un uomo in cerca di se stesso.
No, cosa sono adesso non lo so,
sono solo, solo il suono del mio passo.
e intanto il sole tra la nebbia filtra già
il giorno come sempre sarà.
Premiata Forneria Marconi (PFM)
Performed by Marlene Kuntz
Performed by Marlene Kuntz
giovedì 14 maggio 2009
Una ragazza mi ha ricordato te
C'è questa ragazza che ti somiglia in modo impressionante. Ha i tuoi stessi lineamenti, arrotondati e leggeri. Il naso, la bocca, pure i capelli, anche se li porta più lunghi di te: sembra la tua copia al femminile, nonostante l'assenza lunga dagli occhi miei, dagli occhi tuoi; dato che non ci vediamo da così tanto tempo e così tanti chilomtri, il mio ricordo potrebbe essere offuscato da ciò che vorrei ricordare e da come desidererei ricordarlo. Si perde talmente tando indietro, l'ultima volta che ci siamo incrociati, per caso, davanti a casa mia e ad un passo da casa tua, proprio dove prima eravamo soliti incontrarci. Eri in macchina mentre io camminavo a piedi. Ti fermasti rischiando di fermare tutto il traffico, ma tanto di macchine, nella nostra via, non ne sono mai passate tante. Ricordi quando un pomeriggio, d'estate, proprio all'inizio della festa di paese, i poliziotti avevano preparato le transenne per la sera, per bloccare il traffico a due isolati di distanza dal nostro, e noi per giocare indisturbati a pallone in strada nel pomeriggio eravamo andati a rubare la transenna con il divieto di accesso attaccato nel mezzo e l'avevamo piantata proprio a bordo del nostro campo di asfalto: il tuo cancello come porta e la ringhiera bianca di una casa enorme a fare l'altra. Oppure quando giocavamo a baseball, trasformando il piccolo parcheggio davanti casa tua in un diamante, e sparavamo queste palle dure e pesanti sull'abete enorme di questa casa grande. Ci arrampicavamo sui rami robusti per riprenderle, le palle, stando attenti a non farsi vedere, a non farsi scoprire, perché come colpivamo la palla verso l'albero così avremmo potuto rompere una finestra.
Questa ragazza mi ricorda quei periodi della nostra infanzia: quell'estate da bambini quando partisti per le vacanze e ci scambiammo una foto l'uno dell'altro, per sentir meno la mancanza. Ha gli occhi bianchi, così bianchi, questa ragazza, da sembrare l'unica cosa pulita in tutta la stanza. Le labbra sono curate, precise: due linee non troppo carnose, non troppo sottili, due linee un po' più rosa. Curate sono pure le sopracciglia, leggermente più folte di quelle che si vedono in giro ma che seguono perfette la curvatura dell'orbita. Indossa un giacchetto di pelle, attillato come quelli dei motociclisti, ma non credo abbia mai posseduto una moto. E' pallida, chiara in volto, così tanto che sulle tempie si possono vedere senza difficoltà le vene blu scuro che trasportano il sangue con l'anidride carbonica. Le palpebre, la parte più sottile della pelle, è rosata non so se per un eventuale filo di trucco o per il passaggio dei capillari. Forse somiglia di più a tuo fratello, a tuo fratello quando era piccolo. Ti ricordi quel pomeriggio, quando eravamo sotto casa tua e lo vedemmo arrivare con una mano a coprirsi la bocca? Non voleva farsi vedere dal naso in giù e non c'era verso fargli togliere quella specie di maschera dalla faccia, sembrava saldata. Quella volta che dopo tentativi infiniti riuscimmo a convincerlo a farci vedere cosa aveva sotto, promettendegli che non lo avremmo detto a nessuno e scoprimmo un fiume di sangue scorrergli in piena dalle narici fin sotto il mento. Era così tanto, così abbondante, così copioso, che non riuscivamo a capire se ci fosse una ferita, da dove uscisse tutto quel rosso, se dal naso dalla bocca o da qualche altra parte. Lei non si nasconde, tiene la faccia al sole, muove quegli occhi grandi e a volte li tiene fissi su qualcosa, attenta, concentrata. Mi mette un poco in soggezione anche se è, sembra, più piccola di me. Sarà che io mi sento straniero, mentre lei è indigena: si muove con sicurezza, tranquilla, gesti fluidi; io invece sono sempre titubante, mi muovo a scatti, con lo sguardo cerco sempre di aggrapparmi a qualcosa. Siamo così diversi, in questi atteggiamenti, ed è strano, davvero strano, perché in fin dei conti ci somigliamo assai, o vorrei somigliarle: ha i miei pollici, le stesse unghie, solo un poco più lunghe.
Questa ragazza mi ricorda quei periodi della nostra infanzia: quell'estate da bambini quando partisti per le vacanze e ci scambiammo una foto l'uno dell'altro, per sentir meno la mancanza. Ha gli occhi bianchi, così bianchi, questa ragazza, da sembrare l'unica cosa pulita in tutta la stanza. Le labbra sono curate, precise: due linee non troppo carnose, non troppo sottili, due linee un po' più rosa. Curate sono pure le sopracciglia, leggermente più folte di quelle che si vedono in giro ma che seguono perfette la curvatura dell'orbita. Indossa un giacchetto di pelle, attillato come quelli dei motociclisti, ma non credo abbia mai posseduto una moto. E' pallida, chiara in volto, così tanto che sulle tempie si possono vedere senza difficoltà le vene blu scuro che trasportano il sangue con l'anidride carbonica. Le palpebre, la parte più sottile della pelle, è rosata non so se per un eventuale filo di trucco o per il passaggio dei capillari. Forse somiglia di più a tuo fratello, a tuo fratello quando era piccolo. Ti ricordi quel pomeriggio, quando eravamo sotto casa tua e lo vedemmo arrivare con una mano a coprirsi la bocca? Non voleva farsi vedere dal naso in giù e non c'era verso fargli togliere quella specie di maschera dalla faccia, sembrava saldata. Quella volta che dopo tentativi infiniti riuscimmo a convincerlo a farci vedere cosa aveva sotto, promettendegli che non lo avremmo detto a nessuno e scoprimmo un fiume di sangue scorrergli in piena dalle narici fin sotto il mento. Era così tanto, così abbondante, così copioso, che non riuscivamo a capire se ci fosse una ferita, da dove uscisse tutto quel rosso, se dal naso dalla bocca o da qualche altra parte. Lei non si nasconde, tiene la faccia al sole, muove quegli occhi grandi e a volte li tiene fissi su qualcosa, attenta, concentrata. Mi mette un poco in soggezione anche se è, sembra, più piccola di me. Sarà che io mi sento straniero, mentre lei è indigena: si muove con sicurezza, tranquilla, gesti fluidi; io invece sono sempre titubante, mi muovo a scatti, con lo sguardo cerco sempre di aggrapparmi a qualcosa. Siamo così diversi, in questi atteggiamenti, ed è strano, davvero strano, perché in fin dei conti ci somigliamo assai, o vorrei somigliarle: ha i miei pollici, le stesse unghie, solo un poco più lunghe.
mercoledì 13 maggio 2009
Litigare è una parola troppo spigolosa
Non abbiamo fatto sedute spiritiche, unendo le mani con pollici e mignoli distanti, ma vero è che parlavamo e nel parlare è finito dentro il tuo nome, o le tue linee, i tuoi pensieri o te nei miei. E' vero che avevamo finito e ci affacciavamo oltre il burrone che era quella bottiglia vuota, guardando cosa ci potesse essere al di là del bordo leggermente macchiato di rosso. Mi domando quale sia stata, la parola magica, che ti ha fatto apparire come un ologramma che all'inizio mi trattenevo dal toccare, forse per evitare che la mia mano creasse un onda sulla tua immagine e per qualche misterioso corto circuito essa sparisse via, di nuovo. Forse è stata colpa, mia, la parola; oppure è stata chiamala, pronunciata in modo esortativo. Certo non è stata litigare: litigare è una parola così spigolosa, per piacere aiutami a cercare un posto dove poterla nascondere; oppure sbricioliamola come un biscotto scaduto, in mille pezzettini così minuscoli che neppure l'attack sarebbe capace di ricomporla in modo degno, l'unica cosa spero che l'attack non sia capace di incollare.
E non vorrei che tu credessi che durante questo trascorrere le cose si siano come per magia fermate, perchè non lo sono affatto; anzi, sono state ancora più uno scrivere, un accumulare e mettere tutto quanto da una parte, da poterlo rileggere in silenzio quando di colpo mi scoprivo a sentire la tua mancanza a seccare la pelle in superficie e le vene in profondità. Non vorrei che tu pensassi che il silenzio e lo spazio vuoto dove solitamente c'eri tu, si fosse colmato di qualcosa che non è silenzio o di qualcosa che quello spazio lo riempisse: no. E' cresciuto fino a moltiplicarsi e triplicarsi, fino a quando non ho costruito una gabbia abbastanza grande e robusta in cui chiudere tutto dentro, dove poter collezionare quello che non c'era più. Una specie di vetrina delle mie e dei miei rimpianti, una mensola dove posare le chiavi di casa tra le nostre parole felici e le nostre sincerità, le nostre; o i tuoi non rispondere o i miei forse fraintendimenti nel credere di averti finalmente scocciata quel tanto, troppo, da farti stufare. Questi che sono stati, quanti?, giorni, mesi, anni, secoli di solitudine: spazzati via dal vento, insieme alle palle di fieno nelle praterie del west dove ci siamo rincontrati, intenti a progettare progetti su fogli di carta, scrivere curriculum e preparare un film 3d per macchine parcheggiate.
E non vorrei che tu credessi che durante questo trascorrere le cose si siano come per magia fermate, perchè non lo sono affatto; anzi, sono state ancora più uno scrivere, un accumulare e mettere tutto quanto da una parte, da poterlo rileggere in silenzio quando di colpo mi scoprivo a sentire la tua mancanza a seccare la pelle in superficie e le vene in profondità. Non vorrei che tu pensassi che il silenzio e lo spazio vuoto dove solitamente c'eri tu, si fosse colmato di qualcosa che non è silenzio o di qualcosa che quello spazio lo riempisse: no. E' cresciuto fino a moltiplicarsi e triplicarsi, fino a quando non ho costruito una gabbia abbastanza grande e robusta in cui chiudere tutto dentro, dove poter collezionare quello che non c'era più. Una specie di vetrina delle mie e dei miei rimpianti, una mensola dove posare le chiavi di casa tra le nostre parole felici e le nostre sincerità, le nostre; o i tuoi non rispondere o i miei forse fraintendimenti nel credere di averti finalmente scocciata quel tanto, troppo, da farti stufare. Questi che sono stati, quanti?, giorni, mesi, anni, secoli di solitudine: spazzati via dal vento, insieme alle palle di fieno nelle praterie del west dove ci siamo rincontrati, intenti a progettare progetti su fogli di carta, scrivere curriculum e preparare un film 3d per macchine parcheggiate.
martedì 12 maggio 2009
La più lucente corona d'angeli in cielo
Doris era distaccata e cinica e piena di antipatie calcificate.
Dalle labbra di Marlene uscì un sospiro di estasi divina.
Oppure era solo profondamente consapevole dell'ineluttabilità della sofferenza in amore.
L'idea di che persone perbene, donne di saldi principi, ogni tanto si picchiavano tra loro perché si sentivano confuse e tristi e abbandonate e perciò aggiungevano il colore viola, l'amatoma, alla bandiera appesa sopra il municipio.
Quando si infilarono sotto il lenzuolo scompagnato, erano tutte e tre zuppe di sudore per lo sforzo, il sudore di quando il contatto non è stato totale.
Yvonne. Con dei pantacollant neri e strappati, i capelli biondi, un crocifisso nero e un bustino nero con un cardigan nero sbottonato sul davanti.
potevi vedere quanto più vasto sia l'insieme dei fatti potenziali rispetto all'insieme dei fatti che si verificano realmente.
L'amore era qualcosa che si portava appresso la minaccia dei guai. L'amore era fatto di rischi e obblighi e dipendenza dalla caffeina.
Non ho nessuna intenzione di portarmi in giro un piccolo Randy in miniatura per nove mesi e fottermi il corpo e gli ormoni solo perché tu possa avere un punto di riferimento o qualcuno che si prenda cura di te quando sarai vecchio e rincoglionito.
non aver mai avuto tempo per se stessa, e a dire il vero non essere mai stata se stessa.
Dalle labbra di Marlene uscì un sospiro di estasi divina.
Oppure era solo profondamente consapevole dell'ineluttabilità della sofferenza in amore.
L'idea di che persone perbene, donne di saldi principi, ogni tanto si picchiavano tra loro perché si sentivano confuse e tristi e abbandonate e perciò aggiungevano il colore viola, l'amatoma, alla bandiera appesa sopra il municipio.
Quando si infilarono sotto il lenzuolo scompagnato, erano tutte e tre zuppe di sudore per lo sforzo, il sudore di quando il contatto non è stato totale.
Yvonne. Con dei pantacollant neri e strappati, i capelli biondi, un crocifisso nero e un bustino nero con un cardigan nero sbottonato sul davanti.
potevi vedere quanto più vasto sia l'insieme dei fatti potenziali rispetto all'insieme dei fatti che si verificano realmente.
L'amore era qualcosa che si portava appresso la minaccia dei guai. L'amore era fatto di rischi e obblighi e dipendenza dalla caffeina.
Non ho nessuna intenzione di portarmi in giro un piccolo Randy in miniatura per nove mesi e fottermi il corpo e gli ormoni solo perché tu possa avere un punto di riferimento o qualcuno che si prenda cura di te quando sarai vecchio e rincoglionito.
non aver mai avuto tempo per se stessa, e a dire il vero non essere mai stata se stessa.
Rick Moody
lunedì 11 maggio 2009
diario/6
Sono solo parole a volte mi dico non sono solo parole sono anche prati e libri non letti e sole che filtra tra gli alberi e silenzi mai imbarazzanti non ci sono solo le parole dico ma anche quello che sta in mezzo alle parole e quello che sta in mezzo agli sguardi e quello che sta in mezzo fra lo sguardo e il cielo e non ci sono solo le parole, le parole ci sono state, le parole ci saranno, chissà se basteranno, forse sì forse no, ma in ogni caso ci si farà bastare quello che sarà e si potrà “essere” anche senza le parole o solo con quelle degli altri e magari si crescerà comunque ci si arricchirà comunque si farà tesoro delle parole come dei silenzi, si farà di ogni cosa grandi tesori e si terranno stretti perché in fondo è anche questo crescere, in fondo è anche questo vivere
William Dollace
William Dollace
venerdì 8 maggio 2009
23
E mi piacciono canzoni che potrebbero piacere, fino a ieri no. Mi domando dove cazzo sia finita, la mia cazzo di personalità. Quel poco di.
Twenty three seconds
All things we love will die
Twenty three magic
If you can change your life
Your tainted heart, your tainted heart
My tainted love, my tainted love
Repent now
How many times
As long as you live
How many times
The world will go around
He was a friend of mine
He was a son of god
He was a son of a gun
He was a son of god
He was a friend of mine
He was a son of god
He was a son of a gun
He was a son of god
Twenty three seconds
In you I see a chance
Twenty three magic
If you change the name of love
Your crazy heart
My crazy love
Repent now
How many times
As long as you wish
How many times
The world will go around
How many times
As long as you want
How many times
The world will go around
He was a friend of mine
He was a son of a gun
He was a son of god
He was a son of god
He was a friend of mine
He was a son of a gun
He was a son of god
He was a son of god
He was a friend of mine
He was a son of a gun
He was a son of god
He was a son of god
Twenty three
<==========>
Twenty three seconds
All things we love will die
Twenty three magic
If you can change your life
Your tainted heart, your tainted heart
My tainted love, my tainted love
Repent now
How many times
As long as you live
How many times
The world will go around
He was a friend of mine
He was a son of god
He was a son of a gun
He was a son of god
He was a friend of mine
He was a son of god
He was a son of a gun
He was a son of god
Twenty three seconds
In you I see a chance
Twenty three magic
If you change the name of love
Your crazy heart
My crazy love
Repent now
How many times
As long as you wish
How many times
The world will go around
How many times
As long as you want
How many times
The world will go around
He was a friend of mine
He was a son of a gun
He was a son of god
He was a son of god
He was a friend of mine
He was a son of a gun
He was a son of god
He was a son of god
He was a friend of mine
He was a son of a gun
He was a son of god
He was a son of god
Twenty three
Performed by Blonde Redhead
giovedì 7 maggio 2009
Labbra
Mi vengono in mente le farfalle, - e il prato in cui corriamo, verde smeraldo in lieve pendenza, con erba alta. Mentre corri lontana ti volti a guardarmi. Sorridi vedendo la gonna blu scuro a fiori viola scuro aprirsi a ventaglio, come quando da bambina ti divertivi a trasformarti in ballerina. La maglia nera con maniche a tre quarti, solo questo, sulla tua pelle chiara. I capelli ti frustano delicati la faccia, battendo sulla bocca, coprendoti gli occhi, per un istante. Ridi. Mi aspetti. Cammino verso di te. - anche se so che difficilmente ti si addicono. Sono delle vesti che non credo porti. Ma le vedo in bianco e nero, non colorate. Così sono più affini, dico tra me. Allora le ali ti si posano sui capelli, loro grigie chiare e tu scura. Fermagli vivi che donano un non so che di speciale, qualcosa di strano, affascinate - no: il tuo volto - fotogrammi in movimento su una foto scattata anni fa. Come una statua, immobile, tu stai: le parti illuminate sono avorio, venato da piccoli fiumi di petrolio, con una piccola isola felice; l'ombra invece è tutto il resto, ciò che resta dietro il sipario, e si macchia di nero: tatuaggi senza fine. Come fanno due labbra a guardarmi? Le tue.
mercoledì 6 maggio 2009
Lasciami Entrare

Difficile guardare un film tratto da un libro che si è letto: o è perfetto, o il rischio di rimanerne delusi risulta pittusto alto. Riassumere un libro di 416 pagine in un film di 114 minuti circa, beh è un azzardo che in fin dei conti porta dritti dritti alla seconda ipotesi. Non che Lasciami entrare sia un brutto film, anzi: sotto molti aspetti è ben riuscito, ma le differenze tra il libro e la pellicola sono assai numerose. Dove la storia su carta era un triller intrecciato con il rapporto tra i due protagonisti, nel film il tutto viene risolto nella sola relazione tra i due ragazzi: passaggio all'adolescenza per lui e ambientazione in un nuovo mondo per lei. Entrambi, in un modo o nell'altro, guadagnano qualcosa nella presenza altrui: simbionti. Una storia però più o meno corale viene ridotta ad un duetto sottile, alcuni personaggio vengono completamente tagliati, altri non vengono approfonditi a livello psicologico, tanto da non far capire a fondo i motivo dei loro gesti, e altri invece vengono lasciati 'morire' senza dar loro possibilità di 'risorgere'. Rimane un'atmosfera dilatata tra le nevi e due protagonisti calati bene nelle parti, soprattutto lei; ma l'impressione è che chi ha letto il libro riesca a godere del film di più di chi invece non ha sfogliato le pagine di Lindqvist.
Giudizio: Dvd
- Cinema ==> Da vedere assolutamente, correre al cinema
- Dvd ==> Da vedere, ma si può aspettare il noleggio
- Tv ==> Niente di esaltante, se proprio si deve vedere aspettare il passaggio in tv
- Passeggiata ==> Perdibilissimo. Andate pure a fare una passeggiata.. anche sotto la pioggia
martedì 5 maggio 2009
La fine di Alice
tale è la natura del mio male, essere attratto da troppe cose. E sono atterrito e mi rattristo.
per quanto dolci, per quanto teneri, semplicemente non bastano.
Lì, ora, adesso, sta ancora il fragile, il morbido, il caldo che accende il cuore.
Non voglio vederla - sarebbe troppo, importerebbe troppi paragoni -, quanto piuttosto accecarmi, chiudere gli occhi e semplicemente toccarla.
Attenzione, contiene follia.
Temo che me la portino via prima che io possa conquistarla, prima che io riesca a indurla a credere che niente è più vicino al cuore delle cose, alla sua vera natura, di quello che c'è fra noi, e che un'estate trascorsa a fare la stagista in qualche studio di avvocato o a imparare il tedesco porterà alla fin fine ben poco nella sua vita, mentre un'estate passata a raccontarci le nostre bricconate la muterebbe per sempre.
Non mi lascerò più mettere in una posizione simile, quella di chi deve implorare. Loro non hanno idea di quanto siano importanti per noi, non si rendono conto del potere che gli concediamo, non capiscono che basta un gesto così banale per farle entrare nella nostra vita.
Ti avrei scritto da lì, ma non c'era niente da dire.
Votate per il cazzo grande, è calmo, è sicuro di sé, è il vincitore in tutto e per tutto. Lo sapete bene. Dal momento che non possiamo vederlo, però, dal momento che non siamo tutti una banda di fessi, vince sempre l'uccello più strimizzito. Perché? Perché il suo possessore lotta, perché deve compensare; compete perché per lui quella roba lì conta moltissimo.
La guerra è una sega collettiva.
E' facile spiare quando nessuno pensa che stai osservando.
il buonumore è una cosa assai fragile.
ci sorvegliano e allo stesso tempo ci ignorano.
"Sono o no il ragazzo più strano che conosci?"
Lei scuote la testa. "No, ma sei molto tenero."
"E scommetto che hai un buon sapore."
Sono cambiate tante cose e lei non se n'è nemmeno accorta.
Fermo, vibro, tremo e comincio a riempirmi di nuovo di sangue.
La pelle più morbida del mondo, non pelle ma una strana stoffa, una seta rara.
Alza le sopracciglia, che si arricciano formando due punti interrogativi perfetti.
"Una volta avevo un amico", dice con una voce che sembra di carta. "E' morto giovane."
per quanto dolci, per quanto teneri, semplicemente non bastano.
Lì, ora, adesso, sta ancora il fragile, il morbido, il caldo che accende il cuore.
Non voglio vederla - sarebbe troppo, importerebbe troppi paragoni -, quanto piuttosto accecarmi, chiudere gli occhi e semplicemente toccarla.
Attenzione, contiene follia.
Temo che me la portino via prima che io possa conquistarla, prima che io riesca a indurla a credere che niente è più vicino al cuore delle cose, alla sua vera natura, di quello che c'è fra noi, e che un'estate trascorsa a fare la stagista in qualche studio di avvocato o a imparare il tedesco porterà alla fin fine ben poco nella sua vita, mentre un'estate passata a raccontarci le nostre bricconate la muterebbe per sempre.
Non mi lascerò più mettere in una posizione simile, quella di chi deve implorare. Loro non hanno idea di quanto siano importanti per noi, non si rendono conto del potere che gli concediamo, non capiscono che basta un gesto così banale per farle entrare nella nostra vita.
Ti avrei scritto da lì, ma non c'era niente da dire.
Votate per il cazzo grande, è calmo, è sicuro di sé, è il vincitore in tutto e per tutto. Lo sapete bene. Dal momento che non possiamo vederlo, però, dal momento che non siamo tutti una banda di fessi, vince sempre l'uccello più strimizzito. Perché? Perché il suo possessore lotta, perché deve compensare; compete perché per lui quella roba lì conta moltissimo.
La guerra è una sega collettiva.
E' facile spiare quando nessuno pensa che stai osservando.
il buonumore è una cosa assai fragile.
ci sorvegliano e allo stesso tempo ci ignorano.
"Sono o no il ragazzo più strano che conosci?"
Lei scuote la testa. "No, ma sei molto tenero."
"E scommetto che hai un buon sapore."
Sono cambiate tante cose e lei non se n'è nemmeno accorta.
Fermo, vibro, tremo e comincio a riempirmi di nuovo di sangue.
La pelle più morbida del mondo, non pelle ma una strana stoffa, una seta rara.
Alza le sopracciglia, che si arricciano formando due punti interrogativi perfetti.
"Una volta avevo un amico", dice con una voce che sembra di carta. "E' morto giovane."
Amy Michael Homes
lunedì 4 maggio 2009
venerdì 1 maggio 2009
Details Of The War
Bloody sheets
Tenderly she moves me
An opera star
Dying hard for love
You say I'm hurt
I will take your word
Leather pants
Happiness
A hundred dollars
Buy success
Hanging with your fashionable whores
And I'm a wounded bird
I will take your word
You and tom (you and tom)
To the prom (to the prom)
Camel dick (camel dick)
Crucifix (crucifix)
Everyone's the same and on and on
Emerging from the football stands
Clinging to his broken hand
It's over I have seen it all before
Nakedness (nakedness)
A flying lesson
Tattered dress
Sunburned chest
You will pay for your excessive charm
With a boy who knows
Less than he thinks
Drinks up his expensive drinks
Be careful with the details of the war!
Tenderly she moves me
An opera star
Dying hard for love
You say I'm hurt
I will take your word
Leather pants
Happiness
A hundred dollars
Buy success
Hanging with your fashionable whores
And I'm a wounded bird
I will take your word
You and tom (you and tom)
To the prom (to the prom)
Camel dick (camel dick)
Crucifix (crucifix)
Everyone's the same and on and on
Emerging from the football stands
Clinging to his broken hand
It's over I have seen it all before
Nakedness (nakedness)
A flying lesson
Tattered dress
Sunburned chest
You will pay for your excessive charm
With a boy who knows
Less than he thinks
Drinks up his expensive drinks
Be careful with the details of the war!
Performed by Clap Your Hands Say Yeah
Iscriviti a:
Post (Atom)