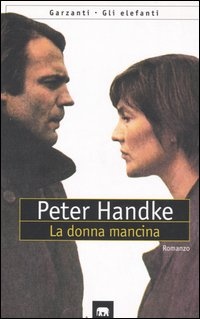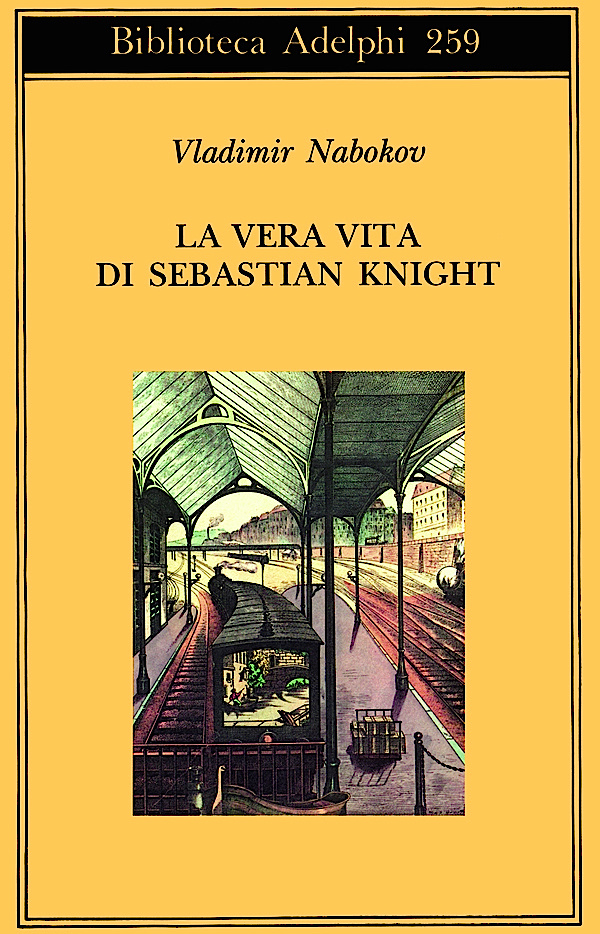Si esprimeva esclusiavamente per opinioni,
non perché ne fosse convinta, ma nel timore che altrimenti i discorsi
fossero presi per ciance.
Sull'esempio di quest'animale che ha
sempre la peggio, imparano sull'esistenza più di quel che potranno mai
recepire in questa landa benestante di proprietari di case e di terreni,
dove la vita consiste unicamente nello scimmiottare la televisione.
L'essere soli causa la più gelida, la più
repellente delle sofferenze: quella dell'inesistenza. Ecco perché ci
vuole della gente che ti faccia capire che non sei andato ancora del
tutto a male.
Peter Handke
lunedì 29 dicembre 2014
lunedì 22 dicembre 2014
Washington Square
Non ci vuole molto tempo per amare una persona, una volta che si comincia.
No, non sono in collera. La collera non dura per anni. Ma ci sono altre cose. Impressioni che durano, quando sono state tanto forti.
Henry James
No, non sono in collera. La collera non dura per anni. Ma ci sono altre cose. Impressioni che durano, quando sono state tanto forti.
Henry James
mercoledì 17 dicembre 2014
Contro l’occhio. La scrittura del dolore vero
In un piccolo volume del 2006, La Letteratura dell’inesperienza,
Antonio Scurati rifletteva su quanto la società di plastica in cui
viviamo abbia sostituito l’esperienza diretta del mondo (com’è, per
antonomasia, quella vissuta da chi ha fatto la guerra) con una sorta di
cognizione del dolore indiretta, asettica, disinfettata e interrotta da
assidui diaframmi che sono prima di tutto gli schermi attraverso i quali
giunge a noi la realtà, a pillole, frammentata, amplificata e voltata
in evento per far fronte all’insufficienza del nostro presente: in
sostanza, cioè, esperiamo quotidianamente l’inesperienza; la quale non
solo crea una letteratura incapace di poggiare i piedi per terra, ma
genera un cortocircuito che impedisce di gettare ponti verso il passato e
verso il futuro. L’uomo finisce così per mancare, nel campo delle cose
narrabili, di quel copioso materiale che ebbero per la testa i nostri
nonni. Ed è ovviamente un problema letterario, sì, ma prima di tutto
psicologico e morale; è un buco nella coscienza, colmato talora, e
tragicamente, dal piombare furioso dell’evento eccezionale: un
terremoto, un’alluvione, un disastro della natura. E quando accade, gli
scrittori aggrediscono il caso anomalo e terribile, lo accerchiano e se
ne lasciano invadere come la terra riarsa accoglie il fortunale.
Così, se l’uomo d’oggi è questo, incapace di dire la sofferenza, il freddo e la paura, la letteratura percorre due vie soltanto: o rende manifesto, quando riesce, l’handicap e, nel tentativo di superarlo, forza la scrittura ad aprire il diaframma e a farsi denuncia e superamento dello iato che ci separa dall’esperienza; oppure, in altri rari casi e avvalendosi di un campo d’indagine inedito per le nostre coscienze sopite, essa s’immerge nei brividi dolorosi provocati dalla vita quando la vita si leva i guanti e ci tocca con le sue dita gelide e ossute.
Scrivere intorno alle tragedie significa sfidare se stessi e il proprio tempo. Lo hanno fatto, nell’ultimo lustro (quello dei terremoti dell’Aquila e dell’Emilia, per arrivare all’alluvione di Senigallia del 3 maggio scorso), diversi scrittori, più sovente attraverso volumi collettivi che non con opere ‘in solitaria’: è il caso di E lieve sia la terra (Textus edizioni, 2011), antologia di testi, a cura di Luca d’Ascanio, dedicati alle persone scomparse il 6 aprile 2009 in Abruzzo; o dei 14 racconti attorno alla tragedia emiliana del maggio 2012, nel volume a cura di Paolo Roversi, con introduzione di Loriano Macchiavelli, Scosse. Scrittori per il terremoto (Felici editore, 2012); o ancora, con un titolo che è un brivido onomatopeico, delle testimonianze raccolte in Tremaggio. L’alluvione di Senigallia nel racconto di otto scrittori (a cura di Antonio Maddamma, con un testo di Massimo Cirri, Ventura edizioni, 2014). E c’è anche chi, come Enrico Macioci, ha affrontato il tema della terra che trema, ancora in Abruzzo, all’Aquila, con una scrittura via via più sperimentale, da Terremoto (Terre di mezzo, 2010) al labirintico ed espressionistico La dissoluzione familiare (Indiana, 2012).
Sono testi che, provando uno spettro di soluzioni che va dall’approccio cronachistico a quello filosofico, dallo sguardo sociologico alla stratificazione e trasfigurazione postmoderna, riattivano tutti, in prima istanza, una sacra ispirazione che fu della letteratura d’ogni tempo, e che forse nell’epoca dell’inesperienza ha cessato di funzionare, o di funzionare bene: quella di dare forma all’informe o, per dirla con Calvino, di “scegliere una strategia per affrontare l’inaspettato senza essere distrutto”; o, ancora, di impartirci, con le sue storie immutabili, con l’impossibilità di cambiare il destino che ai personaggi letterari è riservato, la più grande e utile lezione di vita, che è lezione “repressiva” – scriveva pochi anni fa Umberto Eco –, di educazione al fato, alla sofferenza, alla morte. Tanto di più quando si applica direttamente, e non per via teorica, a quegli oggetti della coscienza.
Ma oltre a ciò, scrivere del dolore e della morte (allorché il dolore e la morte sono veri, e non esercizio, seppur onorevole, della fantasia) significa recuperare altre funzioni umane spesso atrofizzate dalla piattezza delle nostre esistenze. La scrittura del dolore non solo cerca di scardinare l’apatia, non solo dimostra la lacerazione tra l’esperienza tragica e l’inesperienza diffusa, ma porta a scoprire ancora il pudore, quello che c’era nelle sofferenze di una volta, nelle guerre di un tempo, e che, come scriveva cent’anni fa Antonio Baldini in Nostro Purgatorio, riduceva al confine delle zone d’operazione quelli che la guerra non la facevano e non la dovevano fare. Baldini sosteneva che non può esserci spazio per chi guarda, perché era nel giusto solo chi la guerra la combatteva. La nostra società – che ci sia o che non ci sia la guerra – è invece tutta edificata sulla visione: forse vediamo troppo, ci è concesso di vedere troppo, e il nostro sguardo morboso (quello che ha iniziato a esercitarsi sulla morte in diretta di Alfredino Rampi) ha perduto l’organica moralità che un tempo fu eccitata dagli ostacoli del pudore.
Un compito della letteratura potrebbe essere allora – e la scrittura attorno alle tragedie ne è un esempio – il rigetto della visione, e la riconquista delle parole che fanno vedere, anch’esse, ma con dignità. Senza clamori, senza spettacolo, in maniera nostalgica. Per ottenere, infine, di avere ancora paura, e rispetto, per la nostra vita.
di Giacomo Verri
Trovato qui: Nazione Indiana
Così, se l’uomo d’oggi è questo, incapace di dire la sofferenza, il freddo e la paura, la letteratura percorre due vie soltanto: o rende manifesto, quando riesce, l’handicap e, nel tentativo di superarlo, forza la scrittura ad aprire il diaframma e a farsi denuncia e superamento dello iato che ci separa dall’esperienza; oppure, in altri rari casi e avvalendosi di un campo d’indagine inedito per le nostre coscienze sopite, essa s’immerge nei brividi dolorosi provocati dalla vita quando la vita si leva i guanti e ci tocca con le sue dita gelide e ossute.
Scrivere intorno alle tragedie significa sfidare se stessi e il proprio tempo. Lo hanno fatto, nell’ultimo lustro (quello dei terremoti dell’Aquila e dell’Emilia, per arrivare all’alluvione di Senigallia del 3 maggio scorso), diversi scrittori, più sovente attraverso volumi collettivi che non con opere ‘in solitaria’: è il caso di E lieve sia la terra (Textus edizioni, 2011), antologia di testi, a cura di Luca d’Ascanio, dedicati alle persone scomparse il 6 aprile 2009 in Abruzzo; o dei 14 racconti attorno alla tragedia emiliana del maggio 2012, nel volume a cura di Paolo Roversi, con introduzione di Loriano Macchiavelli, Scosse. Scrittori per il terremoto (Felici editore, 2012); o ancora, con un titolo che è un brivido onomatopeico, delle testimonianze raccolte in Tremaggio. L’alluvione di Senigallia nel racconto di otto scrittori (a cura di Antonio Maddamma, con un testo di Massimo Cirri, Ventura edizioni, 2014). E c’è anche chi, come Enrico Macioci, ha affrontato il tema della terra che trema, ancora in Abruzzo, all’Aquila, con una scrittura via via più sperimentale, da Terremoto (Terre di mezzo, 2010) al labirintico ed espressionistico La dissoluzione familiare (Indiana, 2012).
Sono testi che, provando uno spettro di soluzioni che va dall’approccio cronachistico a quello filosofico, dallo sguardo sociologico alla stratificazione e trasfigurazione postmoderna, riattivano tutti, in prima istanza, una sacra ispirazione che fu della letteratura d’ogni tempo, e che forse nell’epoca dell’inesperienza ha cessato di funzionare, o di funzionare bene: quella di dare forma all’informe o, per dirla con Calvino, di “scegliere una strategia per affrontare l’inaspettato senza essere distrutto”; o, ancora, di impartirci, con le sue storie immutabili, con l’impossibilità di cambiare il destino che ai personaggi letterari è riservato, la più grande e utile lezione di vita, che è lezione “repressiva” – scriveva pochi anni fa Umberto Eco –, di educazione al fato, alla sofferenza, alla morte. Tanto di più quando si applica direttamente, e non per via teorica, a quegli oggetti della coscienza.
Ma oltre a ciò, scrivere del dolore e della morte (allorché il dolore e la morte sono veri, e non esercizio, seppur onorevole, della fantasia) significa recuperare altre funzioni umane spesso atrofizzate dalla piattezza delle nostre esistenze. La scrittura del dolore non solo cerca di scardinare l’apatia, non solo dimostra la lacerazione tra l’esperienza tragica e l’inesperienza diffusa, ma porta a scoprire ancora il pudore, quello che c’era nelle sofferenze di una volta, nelle guerre di un tempo, e che, come scriveva cent’anni fa Antonio Baldini in Nostro Purgatorio, riduceva al confine delle zone d’operazione quelli che la guerra non la facevano e non la dovevano fare. Baldini sosteneva che non può esserci spazio per chi guarda, perché era nel giusto solo chi la guerra la combatteva. La nostra società – che ci sia o che non ci sia la guerra – è invece tutta edificata sulla visione: forse vediamo troppo, ci è concesso di vedere troppo, e il nostro sguardo morboso (quello che ha iniziato a esercitarsi sulla morte in diretta di Alfredino Rampi) ha perduto l’organica moralità che un tempo fu eccitata dagli ostacoli del pudore.
Un compito della letteratura potrebbe essere allora – e la scrittura attorno alle tragedie ne è un esempio – il rigetto della visione, e la riconquista delle parole che fanno vedere, anch’esse, ma con dignità. Senza clamori, senza spettacolo, in maniera nostalgica. Per ottenere, infine, di avere ancora paura, e rispetto, per la nostra vita.
di Giacomo Verri
Trovato qui: Nazione Indiana
lunedì 15 dicembre 2014
La vera vita di Sebastian Knight
Quante volte gli ho detto: “Sebastian,
sta’ attento, le donne ti ameranno alla follia”. E lui rispondeva
ridendo: “Be’, le amerò anch’io alla follia…”.
Sebastian, nonostante la sua tetraggine, a volte escogitava tiri diabolici, come quando su un tram affollato convinse il bigliettaio a consegnare a una ragazza, seduta all’altra estremità della vettura, un messaggio scribacchiato alla meglio che diceva letteralmente: “Sono solo un povero bigliettaio, ma ti amo”.
Non essere troppo sicuro di apprendere il passato dalle labbra del presente.
Quando penso a tutte le piccole cose destinate a morire, ora che non le possiamo più condividere, sento come se fossimo morti anche noi.
Perché l’amore è così misteriosamente esclusivo? Si possono avere mille amici, ma si deve amare una sola persona.
A osservare bene la ragazza più bella del mondo mentre trasudava la quintessenza dei luoghi comuni si scopriva senz’altro nella sua bellezza qualche piccolo neo corrispondente alle sue abitudini mentali.
Ci sono molte specie d’amore e molte specie di dolore.
Le sto dicendo quello che so io, non quello che a lei piacerebbe sapere.
A lei sembra che la sua vita contenga già le vicende sensazionali di cento romanzi.
Non sono le parti che contano, ma il loro modo di combinarsi.
Gli dava l’impressione di giocare continuamente a qualche gioco di sua invenzione, senza spiegare agli altri quali fossero le regole.
Gocce di pioggia colavano lungo i finestrini: non colavano già dritte ma a scatti, seguendo un percorso incerto, zigzagante, e arrestandosi di tanto in tanto.
Quale che fosse il suo segreto, ho appreso un segreto anch’io, e cioè: che l’anima è solo un modo di essere – non uno stato costante –, che ogni anima può essere la tua se ne scopri e ne segui le ondulazioni.
Vladimir Nabokov
Sebastian, nonostante la sua tetraggine, a volte escogitava tiri diabolici, come quando su un tram affollato convinse il bigliettaio a consegnare a una ragazza, seduta all’altra estremità della vettura, un messaggio scribacchiato alla meglio che diceva letteralmente: “Sono solo un povero bigliettaio, ma ti amo”.
Non essere troppo sicuro di apprendere il passato dalle labbra del presente.
Quando penso a tutte le piccole cose destinate a morire, ora che non le possiamo più condividere, sento come se fossimo morti anche noi.
Perché l’amore è così misteriosamente esclusivo? Si possono avere mille amici, ma si deve amare una sola persona.
A osservare bene la ragazza più bella del mondo mentre trasudava la quintessenza dei luoghi comuni si scopriva senz’altro nella sua bellezza qualche piccolo neo corrispondente alle sue abitudini mentali.
Ci sono molte specie d’amore e molte specie di dolore.
Le sto dicendo quello che so io, non quello che a lei piacerebbe sapere.
A lei sembra che la sua vita contenga già le vicende sensazionali di cento romanzi.
Non sono le parti che contano, ma il loro modo di combinarsi.
Gli dava l’impressione di giocare continuamente a qualche gioco di sua invenzione, senza spiegare agli altri quali fossero le regole.
Gocce di pioggia colavano lungo i finestrini: non colavano già dritte ma a scatti, seguendo un percorso incerto, zigzagante, e arrestandosi di tanto in tanto.
Quale che fosse il suo segreto, ho appreso un segreto anch’io, e cioè: che l’anima è solo un modo di essere – non uno stato costante –, che ogni anima può essere la tua se ne scopri e ne segui le ondulazioni.
Vladimir Nabokov
venerdì 12 dicembre 2014
L'amore non esiste
L'amore non esiste è un cliché di situazioni
tra due che non son buoni ad annusarsi come bestie
finché il muro di parole che hanno eretto
resterà ancora fra loro a rovinare tutto
L'amore non esiste è l'effetto prorompente
di dottrine moraliste sulle voglie della gente
è il più comodo rimedio alla paura
di non essere capaci a rimanere soli
L'amore non ha casa, non ha un'orbita terrestre
non risponde ai più banali meccanismi tra le forze,
è un assetto societario in conflitto d'interesse
l'amore non esiste…
Ma esistiamo io e te
e la nostra ribellione alla statistica
un'abbraccio per proteggerci dal vento
l'illusione di competere col tempo
Io non ho la religiosa accettazione della fine
potessimo trovare altri sinonimi del bene
l'amore non esiste, esistiamo io e te
L'amore se poi esiste è quest'idea di attaccamento
che ha l'uomo del mio tempo per le tante storie viste
non esiste fare i conti accontentarsi piano piano
di una vita mano nella mano
L'amore non esiste è un ingorgo della mente
di domande mal riposte e di risposte non convinte
vuoi tu prendere per sposo questa libera creatura
finché Dio l'avrà deciso o solamente finché dura?
Ma esistiamo io e te
e la nostra ribellione alla statistica
un abbraccio per proteggerci dal vento
l'illusione di competere col tempo
e non c'è letteratura che ci sappia raccontare
i numeri da soli non riescono a spiegare
l'amore non esiste, esistiamo io e te
Io non ho la religiosa accettazione della fine
potessimo trovare altri sinonimi del bene
l'amore non esiste…
Performed by Fabi Silvestri Gazzè
tra due che non son buoni ad annusarsi come bestie
finché il muro di parole che hanno eretto
resterà ancora fra loro a rovinare tutto
L'amore non esiste è l'effetto prorompente
di dottrine moraliste sulle voglie della gente
è il più comodo rimedio alla paura
di non essere capaci a rimanere soli
L'amore non ha casa, non ha un'orbita terrestre
non risponde ai più banali meccanismi tra le forze,
è un assetto societario in conflitto d'interesse
l'amore non esiste…
Ma esistiamo io e te
e la nostra ribellione alla statistica
un'abbraccio per proteggerci dal vento
l'illusione di competere col tempo
Io non ho la religiosa accettazione della fine
potessimo trovare altri sinonimi del bene
l'amore non esiste, esistiamo io e te
L'amore se poi esiste è quest'idea di attaccamento
che ha l'uomo del mio tempo per le tante storie viste
non esiste fare i conti accontentarsi piano piano
di una vita mano nella mano
L'amore non esiste è un ingorgo della mente
di domande mal riposte e di risposte non convinte
vuoi tu prendere per sposo questa libera creatura
finché Dio l'avrà deciso o solamente finché dura?
Ma esistiamo io e te
e la nostra ribellione alla statistica
un abbraccio per proteggerci dal vento
l'illusione di competere col tempo
e non c'è letteratura che ci sappia raccontare
i numeri da soli non riescono a spiegare
l'amore non esiste, esistiamo io e te
Io non ho la religiosa accettazione della fine
potessimo trovare altri sinonimi del bene
l'amore non esiste…
Performed by Fabi Silvestri Gazzè
martedì 9 dicembre 2014
Scatole
Quando c'è bisogno di più parole ho deciso di recarmi altrove. Non significa sia un posto migliore, o peggiore, o più chiaro, o più bello: è solo un altro posto, diverso.
Un cambiamento per dare un tocco di diverso, per far capire che nonostante a volte qui ci sia silenzio, da qualche altra parte c'è invece un continuo parlare e raccontare. A volte rumore, lo so, ma questa è un'altra storia.
Scatole si trova qui, se lo volete leggere:
Scatole su Medium
e se lo leggerete spero vi piaccia.
Un cambiamento per dare un tocco di diverso, per far capire che nonostante a volte qui ci sia silenzio, da qualche altra parte c'è invece un continuo parlare e raccontare. A volte rumore, lo so, ma questa è un'altra storia.
Scatole si trova qui, se lo volete leggere:
Scatole su Medium
e se lo leggerete spero vi piaccia.
venerdì 5 dicembre 2014
Spirit in the Sky
When I die and they lay me to rest
Gonna go to the place that's the best
When I lay me down to die
Goin' up to the spirit in the sky
Goin' up to the spirit in the sky
That's where I'm gonna go when I die
When I die and they lay me to rest
Gonna go to the place that's the best
Prepare yourself you know it's a must
Gotta have a friend in Jesus
So you know that when you die
He's gonna recommend you
To the spirit in the sky
Gonna recommend you
To the spirit in the sky
That's where you're gonna go when you die
When you die and they lay you to rest
You're gonna go to the place that's the best
Never been a sinner I never sinned
I got a friend in Jesus
So you know that when I die
He's gonna set me up with
The spirit in the sky
Oh set me up with the spirit in the sky
That's where I'm gonna go when I die
When I die and they lay me to rest
I'm gonna go to the place that's the best
Go to the place that's the best
Gonna go to the place that's the best
When I lay me down to die
Goin' up to the spirit in the sky
Goin' up to the spirit in the sky
That's where I'm gonna go when I die
When I die and they lay me to rest
Gonna go to the place that's the best
Prepare yourself you know it's a must
Gotta have a friend in Jesus
So you know that when you die
He's gonna recommend you
To the spirit in the sky
Gonna recommend you
To the spirit in the sky
That's where you're gonna go when you die
When you die and they lay you to rest
You're gonna go to the place that's the best
Never been a sinner I never sinned
I got a friend in Jesus
So you know that when I die
He's gonna set me up with
The spirit in the sky
Oh set me up with the spirit in the sky
That's where I'm gonna go when I die
When I die and they lay me to rest
I'm gonna go to the place that's the best
Go to the place that's the best
Performed by Norman Greenbaum
giovedì 4 dicembre 2014
In America si scontrano le culture della fiction
Alla fine della terza stagione di Girls, Hannah, la
protagonista interpretata da Lena Dunham, decide di abbandonare New York
per andare a studiare scrittura creativa alla Iowa University. Nota
bene: Hannah non punta a scrivere il Grande Romanzo Americano (con tutta
la tradizione di sottintesi che si porta dietro: una gara tra Maschi
Bianchi Morti e i loro omologhi viventi a chi ce l’ha più lungo), ma un
libro a metà tra memoir e il personal essay – immaginate qualcosa di
simile a Sheila Heiti o Joan Didion.
Ecco, se vi serviva una rappresentazione plastica del campo letterario americano oggi, non potevate chiedere di meglio: da una parte abbiamo New York City, le case editrici di Manhattan, gli anticipi a sei cifre, gli agenti, le vendite all’estero, le feste in cui “non posso andarmene se prima non conosco Mitchiko Kakutani”. Dall’altra le università con i MFA (Master of Fine Arts) e i loro corsi e diplomi in scrittura creativa – e prima fra tutte proprio Iowa, nelle cui classi di creative writing passarono, come insegnanti, studenti o entrambi, Cheever (ci insegnò un semestre) e Carver (che fu suo allievo), T.C. Boyle, Marilynne Robinson, Michael Cunnigam e molti altri.
Ovviamente il racconto di queste “due città” non può essere così semplicistico. MFA e NYC sono quelli che Bourdieu chiamerebbe “sottocampi”: ma non serve aver letto il sociologo francese (anche se aiuta) per intuire che le cose non sono così manichee come sembrano, e che tra le due città ci sono traslochi continui, commerci, interi quartieri condivisi, quando non veri e propri pendolari.
Per capire meglio come stanno le cose può essere utile un libro uscito da poco negli Stati Uniti, intitolato appunto MFA vs NYC e curato da Chad Harbach per i tipi di n+1. E non a caso molti dei contributi di questa antologia vengono proprio da autori che ruotano intorno alla rivista n+1 (Keith Gessen, Elif Batuman, Emily Gould, lo stesso Harbach): ma ci sono anche pezzi di David Foster Wallace, George Saunders, Lorin Stein o Fredric Jameson, tutta gente che per accidente biografico o interesse scientifico a un certo punto si è chiesta “Come vive uno scrittore?”. Che è come dire “Di cosa vive una scrittore?”.
Le constatazioni da cui parte Harbach sono semplici: i programmi di scrittura attivi nelle varie università del paese sono aumentati in maniera esponenziale negli ultimi trent’anni (nel 1975 erano 79, oggi sono 1269); questa espansione ha fatto sì che mai come oggi ci siano degli scrittori dentro i campus e le università: un altro modo per dirla è che l’insegnamento è diventata sempre più la fonte di reddito principale per molti scrittori (a scapito, ad esempio, della pubblicazione e della vendita dei loro libri). Gessen ne dà una bella testimonianza nel suo contributo, intitolato giustamente Money: il racconto di un anno di insegnamento alla Columbia dopo aver dilapidato l’anticipo del suo primo romanzo e di cosa ciò ha comportato per la sua scrittura ma anche, con tanto di estratti conto, per il suo tenore di vita. Gessen chiude con le perplessità di chiunque si trova per le mani un apparente paradosso: com’è possibile che la noia di un lavoro retribuito e ad alto tasso burocratico abbia contribuito alla serenità (economica e non solo) che serve per scrivere?
Del resto, molti se non la maggior parte di quelli che si iscrivono per prendere un MFA in scrittura creativa non lo fanno per imparare a scrivere, ma per trovare il tempo di scrivere, per sfuggire, trasferendosi in un campus, alle distrazioni e alle nevrosi di una grande città. E ai suoi affitti. E ancora: la maggior parte, se non la totalità, delle cattedre in scrittura creativa sono occupate da gente che vuole scrivere, non insegnare. Il risultato – come sottolinea Wallace – è che “ogni minuto speso in attività didattiche e dipartimentali è, per chi tiene i corsi del Programma, un minuto non speso a lavorare alla propria arte, e questo suscita per forza di cose un certo risentimento”. Finendo col far sentire gli allievi un peso: “è anche chiaro, però, che sentirsi un peso, un ostacolo alla produzione artistica reale, non contribuirà allo sviluppo dello studente e men che meno al suo entusiasmo”.
D’altro canto i master in scrittura creativa – a differenza, ad esempio di quelli in letteratura (e infatti i dipartimenti di inglese e comparate sono sempre più in crisi) – sembrano rispondere a una richiesta tipica della società contemporanea: come prolungare l’adolescenza fino ai trent’anni e soddisfare la domanda di chi vede “la creatività” come un proprio personale destino manifesto. Per quanto non fu sempre così: negli anni Cinquanta proprio Iowa ricevette i finanziamenti della Cia che vedeva nel Programma una sorta di risposta del mondo libero alle accademie sovietiche e all’influenza socialista. Se ne può leggere in The Program Era di Mark McGurl, un volume che ripercorre la storia dell’insegnamento della scrittura creativa e i suoi rapporti con la narrativa americana.
Ma al di là di questa genealogia da Guerra Fredda, l’idea è che la contrapposizione “istituzionale” porti a delle ricadute estetiche: il campo editoriale, leggi NYC, tende a incoraggiare il romanzo, ancora meglio se prova a fare un grande affresco sociale, a scapito di altre forme; mentre i corsi universitari trasformano il racconto in uno strumento didattico, quando non, per i professori, in una pubblicazione accademica buona per fare carriera all’interno del dipartimento. Cambiano anche i pubblici: se lo scrittore da college si confronta soprattutto con i pari, quello “professionista” si confronta col mercato. Di qui le possibili accuse per gli uni di autorefernzialità, e per gli altri di sottomettersi, magari inconsciamente, alle pressioni verso il middlebrow di chi deve raggiungere un pubblico in gran parte disinteressato a ciò che scrivi – d’altrocanto scrivere “per il mercato” vuole anche dire fare i conti con quell’universalità che sembra sempre meno la posta in gioco del letterario.
La “creatività”, dicevo. L’essere creativi, anche in quella peculiare versione depotenziata che è il pensare che ciò che sento,“IO!”, sia interessante per qualcuno, è in fondo l’oggetto del desiderio di questi corsi. Ma quale “creatività” si insegna? Il saggio di Jameson (e quello della Batuman) tenta di affrontare le mediazioni ideologiche con cui si legittima l’insegnamento della scrittura creativa, e in particolare del romanzo. In fondo, dice Jameson, se c’è una cosa che sembra impossibile da insegnare è proprio il romanzo, genere aperto, inconcluso e mutante per definizione.
Secondo Jameson è come se avessero preso il detto di Faulkner su ciò che compone la vita di uno scrittore – esperienza, immaginazione, osservazione – e l’avessero declinato nella loro versione: “scrivi di ciò che sai” (col rischio di ripiegamento autobiografico e confessionale); “trova la tua voce”: l’invenzione modernista dello stile rivenduta come uso ossessivo e manierato della prima persona; “mostra non raccontare”, il più ripetuto e travisato mantra da scuola di scrittura è anche quello che in fondo è più legato a una tecnica e quindi alla possibilità di insegnarla.
Ma l’università gioca uno strano ruolo in MFA vs NYC. Da una parte è lo sfondo su cui tutto si gioca. Che tu lavori nell’editoria di NYC o insegni in un MFA, molto probabilmente lo fai perché ti sei laureato o hai preso un dottorato in un’università. Viene quindi naturale chiedersi quale idea di letteratura si insegni oggi nelle università statunitensi (e in quelle italiane), quali tipi di lettori si formino, con quali gusti e valori. Dall’altra, l’università, o meglio una sua parte, è la grande assente: la critica. È venuta meno la funzione di mediazione tra i testi e i lettori che per lungo tempo ha svolto la critica – sia quella strettamente accademica che quella cosiddetta militante – così come sempre meno il critico è il compagno segreto, lo sparring partner, dell’autore. Il perché questo sia successo e se sia un male o no, è il tema di un altro libro.
In fondo di critici in Girls, io non ne ricordo.
di Francesco Guglieri
Trovato qui: Minima et Moralia
Ecco, se vi serviva una rappresentazione plastica del campo letterario americano oggi, non potevate chiedere di meglio: da una parte abbiamo New York City, le case editrici di Manhattan, gli anticipi a sei cifre, gli agenti, le vendite all’estero, le feste in cui “non posso andarmene se prima non conosco Mitchiko Kakutani”. Dall’altra le università con i MFA (Master of Fine Arts) e i loro corsi e diplomi in scrittura creativa – e prima fra tutte proprio Iowa, nelle cui classi di creative writing passarono, come insegnanti, studenti o entrambi, Cheever (ci insegnò un semestre) e Carver (che fu suo allievo), T.C. Boyle, Marilynne Robinson, Michael Cunnigam e molti altri.
Ovviamente il racconto di queste “due città” non può essere così semplicistico. MFA e NYC sono quelli che Bourdieu chiamerebbe “sottocampi”: ma non serve aver letto il sociologo francese (anche se aiuta) per intuire che le cose non sono così manichee come sembrano, e che tra le due città ci sono traslochi continui, commerci, interi quartieri condivisi, quando non veri e propri pendolari.
Per capire meglio come stanno le cose può essere utile un libro uscito da poco negli Stati Uniti, intitolato appunto MFA vs NYC e curato da Chad Harbach per i tipi di n+1. E non a caso molti dei contributi di questa antologia vengono proprio da autori che ruotano intorno alla rivista n+1 (Keith Gessen, Elif Batuman, Emily Gould, lo stesso Harbach): ma ci sono anche pezzi di David Foster Wallace, George Saunders, Lorin Stein o Fredric Jameson, tutta gente che per accidente biografico o interesse scientifico a un certo punto si è chiesta “Come vive uno scrittore?”. Che è come dire “Di cosa vive una scrittore?”.
Le constatazioni da cui parte Harbach sono semplici: i programmi di scrittura attivi nelle varie università del paese sono aumentati in maniera esponenziale negli ultimi trent’anni (nel 1975 erano 79, oggi sono 1269); questa espansione ha fatto sì che mai come oggi ci siano degli scrittori dentro i campus e le università: un altro modo per dirla è che l’insegnamento è diventata sempre più la fonte di reddito principale per molti scrittori (a scapito, ad esempio, della pubblicazione e della vendita dei loro libri). Gessen ne dà una bella testimonianza nel suo contributo, intitolato giustamente Money: il racconto di un anno di insegnamento alla Columbia dopo aver dilapidato l’anticipo del suo primo romanzo e di cosa ciò ha comportato per la sua scrittura ma anche, con tanto di estratti conto, per il suo tenore di vita. Gessen chiude con le perplessità di chiunque si trova per le mani un apparente paradosso: com’è possibile che la noia di un lavoro retribuito e ad alto tasso burocratico abbia contribuito alla serenità (economica e non solo) che serve per scrivere?
Del resto, molti se non la maggior parte di quelli che si iscrivono per prendere un MFA in scrittura creativa non lo fanno per imparare a scrivere, ma per trovare il tempo di scrivere, per sfuggire, trasferendosi in un campus, alle distrazioni e alle nevrosi di una grande città. E ai suoi affitti. E ancora: la maggior parte, se non la totalità, delle cattedre in scrittura creativa sono occupate da gente che vuole scrivere, non insegnare. Il risultato – come sottolinea Wallace – è che “ogni minuto speso in attività didattiche e dipartimentali è, per chi tiene i corsi del Programma, un minuto non speso a lavorare alla propria arte, e questo suscita per forza di cose un certo risentimento”. Finendo col far sentire gli allievi un peso: “è anche chiaro, però, che sentirsi un peso, un ostacolo alla produzione artistica reale, non contribuirà allo sviluppo dello studente e men che meno al suo entusiasmo”.
D’altro canto i master in scrittura creativa – a differenza, ad esempio di quelli in letteratura (e infatti i dipartimenti di inglese e comparate sono sempre più in crisi) – sembrano rispondere a una richiesta tipica della società contemporanea: come prolungare l’adolescenza fino ai trent’anni e soddisfare la domanda di chi vede “la creatività” come un proprio personale destino manifesto. Per quanto non fu sempre così: negli anni Cinquanta proprio Iowa ricevette i finanziamenti della Cia che vedeva nel Programma una sorta di risposta del mondo libero alle accademie sovietiche e all’influenza socialista. Se ne può leggere in The Program Era di Mark McGurl, un volume che ripercorre la storia dell’insegnamento della scrittura creativa e i suoi rapporti con la narrativa americana.
Ma al di là di questa genealogia da Guerra Fredda, l’idea è che la contrapposizione “istituzionale” porti a delle ricadute estetiche: il campo editoriale, leggi NYC, tende a incoraggiare il romanzo, ancora meglio se prova a fare un grande affresco sociale, a scapito di altre forme; mentre i corsi universitari trasformano il racconto in uno strumento didattico, quando non, per i professori, in una pubblicazione accademica buona per fare carriera all’interno del dipartimento. Cambiano anche i pubblici: se lo scrittore da college si confronta soprattutto con i pari, quello “professionista” si confronta col mercato. Di qui le possibili accuse per gli uni di autorefernzialità, e per gli altri di sottomettersi, magari inconsciamente, alle pressioni verso il middlebrow di chi deve raggiungere un pubblico in gran parte disinteressato a ciò che scrivi – d’altrocanto scrivere “per il mercato” vuole anche dire fare i conti con quell’universalità che sembra sempre meno la posta in gioco del letterario.
La “creatività”, dicevo. L’essere creativi, anche in quella peculiare versione depotenziata che è il pensare che ciò che sento,“IO!”, sia interessante per qualcuno, è in fondo l’oggetto del desiderio di questi corsi. Ma quale “creatività” si insegna? Il saggio di Jameson (e quello della Batuman) tenta di affrontare le mediazioni ideologiche con cui si legittima l’insegnamento della scrittura creativa, e in particolare del romanzo. In fondo, dice Jameson, se c’è una cosa che sembra impossibile da insegnare è proprio il romanzo, genere aperto, inconcluso e mutante per definizione.
Secondo Jameson è come se avessero preso il detto di Faulkner su ciò che compone la vita di uno scrittore – esperienza, immaginazione, osservazione – e l’avessero declinato nella loro versione: “scrivi di ciò che sai” (col rischio di ripiegamento autobiografico e confessionale); “trova la tua voce”: l’invenzione modernista dello stile rivenduta come uso ossessivo e manierato della prima persona; “mostra non raccontare”, il più ripetuto e travisato mantra da scuola di scrittura è anche quello che in fondo è più legato a una tecnica e quindi alla possibilità di insegnarla.
Ma l’università gioca uno strano ruolo in MFA vs NYC. Da una parte è lo sfondo su cui tutto si gioca. Che tu lavori nell’editoria di NYC o insegni in un MFA, molto probabilmente lo fai perché ti sei laureato o hai preso un dottorato in un’università. Viene quindi naturale chiedersi quale idea di letteratura si insegni oggi nelle università statunitensi (e in quelle italiane), quali tipi di lettori si formino, con quali gusti e valori. Dall’altra, l’università, o meglio una sua parte, è la grande assente: la critica. È venuta meno la funzione di mediazione tra i testi e i lettori che per lungo tempo ha svolto la critica – sia quella strettamente accademica che quella cosiddetta militante – così come sempre meno il critico è il compagno segreto, lo sparring partner, dell’autore. Il perché questo sia successo e se sia un male o no, è il tema di un altro libro.
In fondo di critici in Girls, io non ne ricordo.
di Francesco Guglieri
Trovato qui: Minima et Moralia
lunedì 1 dicembre 2014
Iscriviti a:
Post (Atom)