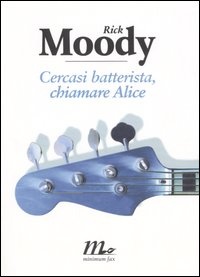Quando ero ragazzo mi piaceva scrivere. Era la sola cosa che volessi fare nella vita. Inventavo persone immaginarie e riempivo quaderni con le loro storie. Scrissi di un ragazzo che crescendo diventava talmente peloso che la gente gli dava la caccia per la sua pelliccia. Doveva nascondersi fra gli alberi e si innamorava di un uccello, e l'uccello pensava che lui fosse un gorilla di centocinquanta chili. Scrissi di due gemelle siamesi, uan delle quali era innamorata di me. Pensavo che le scene di sesso fossero molto originali. Comunque. Quando fui più grande decisi che volevo essere un vero scrittore. Cercai di scrivere di cose reali. Volevo descrivere il mondo perchè a vivere in un mondo non descritto mi sentivo troppo solo.
Ieri ho visto un uomo che dava un calcio a un cane e l’ho sentito dietro gli occhi. Non so dire bene dove, è un posto che sta prima delle lacrime.
11. Avevo sei anni quando a mio padre diagnosticarono un cancro al pancreas.
Quell’anno io e mia madre viaggiammo insieme in auto. Mi chiese di passarle la borsa. “Non ce l’ho” risposi. “Forse è sul sedile posteriore” disse lei. Ma non c’era. Accostò e si mise a cercarla, ma la borsa non si trovava. Si prese la testa fra le mani e cercò di ricordare dove l’aveva lasciata. Perdeva sempre tutto. “Uno di questi giorni” disse “perderò la testa.” Cercai di immaginare che cosa sarebbe successo se avesse perso la testa. Alla fine però fu mio padre che perse tutto: chili, capelli e vari organi interni.
Un giorno lo zio Julian mi ha detto che secondo Alberto Giacometti per dipingere una testa a volte è necessario rinunciare alla figura intera. Per dipingere una foglia, bisogna sacrificare l’intero paesaggio. Subito può sembrare una limitazione, ma dopo un po’ ti rendi conto che avendo solo un pezzetto di una cosa hai più opportunità di salvare un certo sentimento dell’universo di quante ne avresti facendo finta di avere tutto il cielo.
Che faceva sogni spaventosi e riusciva ad addormentarsi, se ci riusciva, solo dopo avere bevuto un bicchiere di latte caldo.
(“Mettiamoci in piedi sotto l’albero” disse. “Perché?” “Perché è più bello.” “Forse dovresti sederti sulla sedia e io mi metto in piedi vicino a te, come fanno marito e moglie.” “Che sciocchezza.” “Perché?” “Perché noi non siamo sposati.” “Ci teniamo per mano?” “Non possiamo.” “Ma perché?” “Perché lo capirebbero.” “Che cosa?” “Di noi.” “E allora?” “È meglio se resta un segreto.” “Perché?” “Così nessuno ce lo può portare via.”)
(Perciò la sensazione più antica del mondo potrebbe semplicemente essere stata la confusione.)
C’era un tempo in cui non era insolito usare un pezzo di filo per guidare le parole che altrimenti avrebbero faticato ad arrivare a destinazione. Le persone timide si portavano in tasca un rocchetto di filo, ma anche chi aveva facilità a esprimersi sentiva di averne bisogno dal momento che, chi era abituato a farsi ascoltare da tutti, spesso si trovava in difficoltà quando voleva essere ascoltato da una persona in particolare.
La falena si mosse debolmente sul palmo. Aveva perso un’ala. Lei gemette. Non sono stato io, dissi. Mi accorsi che aveva gli occhi pieni di lacrime. Una sensazione che non conoscevo ancora mi prese allo stomaco. Mi dispiace, sussurrai. Sentii il bisogno imperioso di abbracciarla, di cancellare con un bacio la falena e l’ala rotta. Lei non disse nulla. I nostri sguardi restarono intrappolati l’uno in quello dell’altra.
Mi infilò la lingua in bocca. Non sapevo se dovessi tenerla a contatto con la mia o se invece fosse meglio lasciare che si muovesse liberamente con la sua. Prima che avessi il tempo di decidermi, lui la ritirò e richiuse la bocca mentre io la lasciai aperta, il che aveva l’aria di essere uno sbaglio. Pensai che questo significasse che la cosa era finita lì, ma a quel punto lui aprì di nuovo la bocca mentre io la chiudevo, così finì che mi leccò le labbra. Allora io riaprii la bocca e tirai fuori la lingua, ma era troppo tardi, perché lui aveva già richiuso la sua. Poi in qualche modo ci azzeccammo, aprendo entrambi la bocca nello stesso momento come se fossimo lì lì per dire qualcosa
Alla fine, tutto ciò che resta di te sono gli oggetti che possiedi. Forse è per questo che non sono mai stato capace di buttare via niente. Forse è per questo che tendo a far tesoro di ogni cosa, a conservarla, con la speranza che, quando sarò morto, la somma totale di ciò che possiedo possa far pensare a una vita più importante di quella che in realtà ho vissuto.
Chiesi a Herman se avesse mai sentito parlare di Antoine de Saint-Exupéry e quando mi risposte di no gli chiesi se avesse mai sentito parlare del Piccolo principe e lui mi disse che gli sembrava di si. Allora gli raccontai della volta che Saint-Ex si schiantò con l’aereo nel deserto della Libia, bevve la rugiada che si era depositata sulle ali dell’aereo e che aveva raccolto con uno straccio macchiato d’olio, e camminò per centinaia di chilometri, disidratato e in preda al delirio per via del caldo e del freddo. Quando arrivai al punto in cui Saint-Exupéry viene ritrovato da un gruppo di beduini, Herman fece scivolare la sua mano nella mia, e io pensai che una media di settantaquattro specie di insetti, piante e animali si estingue ogni giorno e questa era una buona ragione, ma non l’unica, per tenere a qualcuno la mano, e subito dopo successe che ci baciammo, e scoprii che sapevo come si faceva, e mi sentii felice e triste in egual misura, perché capivo che mi stavo innamorando, ma non di lui.
Mi ricordo di quando per la prima volta mi accorsi di vedere cose che non esistevano. Avevo dieci anni e stavo tornando a casa da scuola. Alcuni miei compagni di classe mi passarono vicino di corsa, urlando e ridendo. Volevo essere come loro. Comunque. Non sapevo come fare. Mi ero sempre sentito diverso dagli altri, e la differenza faceva male. E poi girai l’angolo e lo vidi. Un grande elefante, in mezzo alla piazza, tutto solo. Sapevo che era semplicemente frutto della mia immaginazione. Comunque. Volevo crederci.
Così ci provai.
E scoprii che ci riuscivo.
Dal giorno in cui vidi l’elefante, permisi a me stesso di vedere e credere sempre più cose. Era un gioco che facevo tra me e me. Quando parlavo ad Alma delle cose che vedevo, lei rideva e mi diceva che adorava la mia fantasia. Per lei trasformai ciottoli in diamanti, scarpe in specchi, vetro in acqua, le diedi ali ed estrassi uccelli dalle sue orecchie, e nelle tasche le feci trovare le piume, chiesi a una pera di diventare un ananas, a un ananas di diventare una lampadina, a una lampadina di diventare la luna, e alla luna di diventare una moneta che lanciai in aria scommettendo sul suo amore: testa su entrambi i lati; sapevo di non poter perdere.
Ci sono tanti modi di essere vivi, ma uno solo di essere morti.
Nicole Krauss